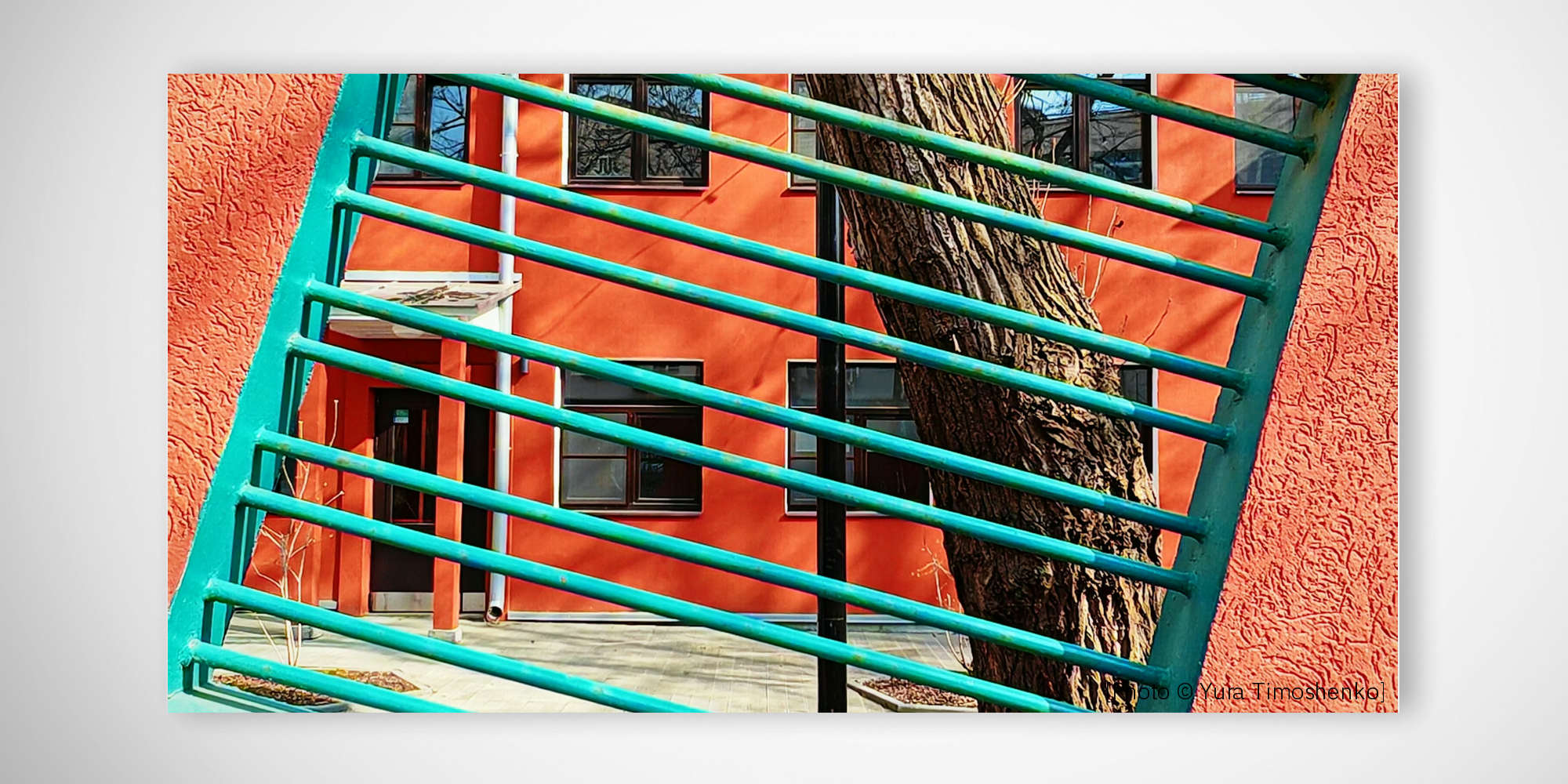
Piero Cristofani: Il modello ideale di famiglia stabile e non soggetto alle variazioni della Storia e della Società non è mai esistito. Secondo Engels e Marx, nella loro opera La nascita della famiglia, della proprietà privata e dello Stato, la famiglia non è un’organizzazione naturale, quanto invece il prodotto di vicende storiche, economiche, religiose, sociali ed altro. Dal Neanderthal, dal Paleolitico e giù fino ai tempi moderni. Dunque, a quale tipo di famiglia dobbiamo fare riferimento? Sostenere l’idea di una psicoterapeuta come Maria Rita Parsi, che i genitori anziché cercare di perseguire lauree nelle più svariate discipline dovrebbero impegnarsi invece a laurearsi in “famiglia”, è una affermazione ingenua. Si può riconoscere che se all’interno della famiglia, in condizioni normali, la coppia figlio-madre, soprattutto alle origini, ha una sua qualità così esclusiva da porsi quasi fuori dal mondo, poi il rapporto padre-figlio è assai condizionato dall’ambiente esterno. Il ruolo del padre sarebbe quello di insegnare al figlio ad essere un elemento positivo della società, ma se la società è necessariamente soggetta al mutamento del tempo, quale ruolo effettivo può stabilmente ricoprire il padre? E ancora: molti giovani si comportano come Pinocchio, (anche Pinocchio aveva una famiglia), il quale si stanca presto del padre Geppetto, onesto ma noioso, e lo abbandona per seguire Lucignolo, lo scolaro ribelle e strafottente. Nel bellissimo libro di Luigi Zoja Il gesto di Ettore la figura del padre esce con le ossa rotte. Le sue qualità sono così mutate nel tempo da farlo diventare una figura opaca, se non inconsistente, non più in grado di assolvere i compiti gravosi della crescita e dell’educazione verso la prole. Quale ruolo sociale e morale è allora chiamato a svolgere? Quale può essere tra i genitori la reciproca assunzione di responsabilità nei confronti dei figli? Quale organizzazione sociale può non sostituirsi, ma casomai affiancarsi ad una famiglia debole se non assente, e assolvere il delicato compito di impartire ad ogni individuo ciò che lui affettivamente richiede e che possiamo chiamare insegnamento educativo, se non la scuola…?
M.C.: Puoi chiarire in cosa consista la «visione nostalgica»?
P.C.: “Ai miei tempi sì che si studiava! Ai miei tempi sì che la scuola era una cosa seria!” Questa sorta di legame con il passato esprime solo un atteggiamento nostalgico, che non offre alcuna indicazione razionale e utile per affrontare con lucidità il problema attuale della scuola. Se si vogliono affrontare radicalmente e non idealmente o sofisticamente i problemi che da sempre la affliggono, non possiamo portarci dietro i ricordi del passato. Dice un proverbio: “Non si scappa trascinandosi dietro la catena”. La scuola dei miei tempi mi aveva costretto a sottostare ai ceppi, ai lacci, alle manette rappresentate da vecchie gabbie istituzionali (la classe chiusa), nonché a sopportare senza alcun intervento personale i penosi programmi scolastici e le vessazioni dei professori, più simili al sergente maggiore di Full Metal Jacket, che a portatori di umanità. “Si, ma allora si studiava!” Balle. Per quanto posso ricordare, si era costretti a studiare con tanto di paraocchi e a stare zitti con tanto di museruole. Quanto alla “nostalgia”, secondo Milan Kundera è mancanza di cose che non torneranno, desiderio di ritrovare un grande amore ridotto ad uno scheletro di poveri ricordi. Quale nostalgia si può nutrire ancora nei confronti di una scuola che non ci ha mai permesso di conoscere nessuna particella di noi stessi, dei nostri talenti e vocazioni? Questo orientamento è a tutt’oggi vivo e vegeto.
M.C.: Accade che nel sistema scolastico vigente prevalga una visione di tipo frammentario, con gap vistosi tra i percorsi formativi della materia alimentati da una perenne conflittualità tra diversi piani e diverse esigenze. I molteplici livelli non si dispongono in un sistema organico. Cedono il posto a una difficile connessione dove il punto fondamentale è l’inscatolamento degli studenti in gabbie istituzionali. Chi è lo studente? Tu hai sottolineato come lo studente venga orientato e spinto ad accettare un acritico senso del dovere.
P.C.: Altro non è che un nome inserito burocraticamente dentro una lista di nomi, chiamata classe, dentro la quale è costretto a vivere per anni. Quali aspirazioni, talenti, desideri egli porti dentro o di che pasta egli sia effettivamente fatto non interessa proprio a nessuno. Se poi, nel corso degli anni, non muore di noia e riesce a sopravvivere, simile a un topo in cattività all’interno di quella gabbia, vuol dire che possiede certe qualità come: furbizia piuttosto che intelligenza, l’arte di arrangiarsi piuttosto che cercare di rafforzare i suoi talenti. Bersagliato da ogni sorta di critica, è stato sempre obbligato a svolgere un ruolo imposto dal sistema, che lo ha reso impotente ad usare in modo produttivo i suoi poteri, di cui egli stesso non è mai arrivato a percepire l’esistenza, sempre mascherati se non addirittura alieni rispetto a lui stesso. Sottomesso, sorvegliato, inibito è sempre stato trattato come una pecorella da tenere a bada dentro un recinto.
M.C.: E chi sono i docenti? Ridotti a stereotipi modellati in base all’ideologia dominante e vincolati a svolgere anno dopo anno programmi ministeriali cervellotici incapaci di dare voce a curiosità ed emotività. Nessuno mette in discussione un ruolo obsoleto. Ciò si è tradotto in un formalismo asfissiante che soffoca il pensiero critico. Ma torniamo al male oscuro, quello che tu chiami anche il male dei mali, origine di ogni fallimento, il male che permea la stessa struttura che, fredda, metallica e anonima impedisce la costruzione di un mondo a misura di studenti e insegnanti. Da tempo ormai le categorie del mondo economico (certificazioni di qualità, efficacia, efficienza, ecc.) spingono alla costruzione di sempre nuovi indirizzi di studio, oggetto di paralisi burocratica. Così i presidi non sono più chiamati a ragionare sulla didattica, da educatori, ma a comportarsi da “manager”.
P.C.: I docenti sono sempre più spesso una massa informe di divulgatori passivi di un repertorio di saperi banalizzati in ripetitive lezioni, caricaturizzati in freddi e vuoti algoritmi, parodiati in pillole e schemi cognitivi da riscaldare a tempo debito e dare in pasto agli studenti. Dalla prima lezione fino all’ultima non cambia nulla nella ciclica e noiosa cronologia. Vittime della legge dell’apatia (fare il minimo indispensabile), avvizziti emotivamente, rinunciatari, si sono non di rado lasciati eclissare in un vuoto di inutilità esistenziale del tutto pari a quello di chi è costretto giorno per giorno a svolgere senza voglia le solite mansioni. Del resto solo pochi hanno le spalle abbastanza larghe per mettere in atto nuove forme didattiche, tali, ad esempio da sovvertire il consueto metodo basato sulla lezione frontale. Già: la lezione. Un blaterare in solitudine, sarebbe più corretto dire, un ripetere quanto tante altre volte detto in modalità periodica e permanente, anno dopo anno. Eros inteso come passione professionale? Non si sa più cosa sia. Quale desiderio è comune a tutti, se non la pensione!
L’espressione “processo formativo” indica una dimensione della psicologia dell’apprendimento troppo spesso sconosciuta agli insegnanti italiani. E praticare l’insegnamento educativo (aiutare lo studente a diventare ciò che è in potenza) è una condotta pressoché ignota: unico obiettivo che riescono a concepire è lo svolgimento del programma. “Questo è quanto devo fare. Mi basta. La mia coscienza è a posto”. Portati ad insegnare la loro materia, bene o male non importa, ripiegati e chiusi in sé stessi, dentro le loro classi e con i loro studenti, scollati dagli altri insegnanti non sentono alcuna motivazione a rinnovarsi sia nella conoscenza della disciplina, sia ad acquisire metodologie didattiche innovative. Non avvertono, ancora, nessun interesse a sapere cosa fanno i colleghi, non essendo mai stati educati dal sistema alla cooperazione e alla interdisciplinarietà didattica. Si vive dentro la propria classe e basta, si sta con i propri studenti e basta. Nessun collegamento didattico che si riflette anche sull’incapacità tra gli studenti di creare forme spontanee di libera aggregazione, tali da poter favorire ricerche di tipo esplorativo cognitivo e/o espressivo-creativo. Insomma si affronta quotidianamente il ruolo come quello di un impiegato costretto a sbrigare le solite pratiche.
M.C.: Che cos’è una «classe chiusa»?
P.C.: Nel corso degli anni ho assistito al proliferare di una quantità incommensurabile (e sterile) di indirizzi sperimentali partoriti da aristocrazie dirigenziali che si sono sbizzarrite a proporre accoppiamenti disciplinari spesso stravaganti. Interventi frettolosi (riforme di vento), ingannevoli e fragili operazioni di rinnovamento, non hanno mai prodotto effetti stabili ed efficaci. Soprattutto non hanno mai messo in discussione l’organizzazione del sistema ottusamente abbarbicato nel modello rigido della “classe chiusa”.
Mi piace ribadire l’accostamento di classe a gabbia istituzionale, a bunker; camere di asfissia educativa dove studenti e docenti sono costretti a vivere. Allargando ancora il concetto di classe chiusa si può affermare che essa è un microcosmo totalizzante dell’educazione, un blocco monolitico che tende a omologare relazioni secondo meccanismi di martellante conformismo. È una comunità di soggetti senza volto, sottoposti a una forza monopolistica micidiale, che si tramuta in un raffinato strumento di modellamento e irreggimentazione culturale. La classe chiusa è un contenitore-trappola che nega l’esistenza degli studenti come individui, e c’è di peggio: è un contenitore che si regge in piedi su orpelli idealistici studiati a dismisura, volti a garantire la sua stessa esistenza a discapito di quella dello studente e del docente.
M.C.: Occorre allora esercitare un’istanza critica radicale. Quale ruolo, dunque, dovrebbe avere la scuola?
P.C.: La società è costantemente attraversata dalle insidie dei cambiamenti, che di per sé creano instabilità e degenerazione del vecchio. Le famiglie, poi, abbiamo detto, sono sempre più lacerate da conflitti interni che rendono arduo lo svolgimento dei ruoli genitoriali nei confronti dei figli. Come affrontare questo stato di cose? Solamente attraverso la funzione risanatrice svolta dalla scuola: sì, ma quale scuola? “Una scuola è una scuola è una scuola è una scuola”, si potrebbe dire parafrasando una celebre frase di Gertrude Stein… Ovviamente non posso riferirmi alla nostra, basata sul sistema tossico delle classi chiuse; una scuola che categoricamente esclude qualsiasi forma di libertà individuale, è da radere al suolo. Una scuola che ondeggia tra false riforme che non penetrano l’essenza del problema è una scuola distorta, più votata a tradire le aspettative e la crescita dei suoi studenti che a promuovere le loro capacità.
M.C.: Viene da chiedersi, allora, quale sia la funzione attribuita alla scuola, nell’epoca della ferocia capitalistica, il cui esito è una catastrofe del mentale caratterizzata dalla presenza di vite soggette all’omologazione e all’alienazione, dove gli individui non riconoscono più se stessi. Genitori, studenti e insegnanti si muovono sulla scena scolastica tutti rivendicando la propria centralità. Può essere utile, pertanto, gettare uno sguardo su altre esperienze., tentando un confronto con altri sistemi scolastici – quelli scandinavi, ad esempio, che tu hai avuto modo di conoscere. Vuoi dirci qualcosa riguardo alle tue esperienze “fuori di casa”? Quale può essere il bilancio del confronto, e quali i punti critici?
P.C.: Questo è un punto cruciale. Lo spazio e il tempo sono categorie fondamentali nel processo di apprendimento, di crescita individuale e di sviluppo relazionale. Se tali elementi vengono utilizzati in modo maldestro o irriflesso, come succede nella scuola italiana, organizzata appunto secondo il modello della “classe chiusa”, essi possono generare squilibri, sia a livello psichico che fisico. Mentre il loro uso, se positivo, può favorire uno sviluppo ottimale della persona, se sbagliato può invece condurre al suo fallimento morale e psichico. Il tempo-scuola e lo spazio-scuola sono pertanto questioni fondamentali, assolutamente centrali per chi intenda interrogarsi sull’organizzazione della vita nella scuola. Nella scuola italiana il tempo è tarato per tutti sullo stesso flusso piatto, senza tener conto che ciascun studente possa avere tempi di apprendimento dettati dal suo particolare stile cognitivo. Nelle scuole del Nord-Europa, in modo particolare quelle danesi e norvegesi – da me visitate in diverse occasioni di scambi culturali – strutturate secondo il modello delle “classi aperte”, il tempo-scuola è un tempo liberante, de-istituzionalizzato, e de-assistenzializzato. Il tempo-scuola, secondo la concezione praticata in queste scuole, ha una duplice natura: epistemologica, cioè a dire che la natura dell’orario scolastico non può considerarsi come una categoria “ontologica”, immutabile, bensì una categoria “storico-esistenziale” esposta alle esigenze individuali e al mutamento delle condizioni culturali, al contesto. La seconda è socio-pedagogica, vale a dire che l’orario è flessibile e modulare. E lo spazio, ristretto solamente alle quattro mura della classe chiusa è invece inteso, in quei sistemi scolastici, come spazio aperto, spazio come ambiente/scuola, infine come ecosistema educativo/formativo.