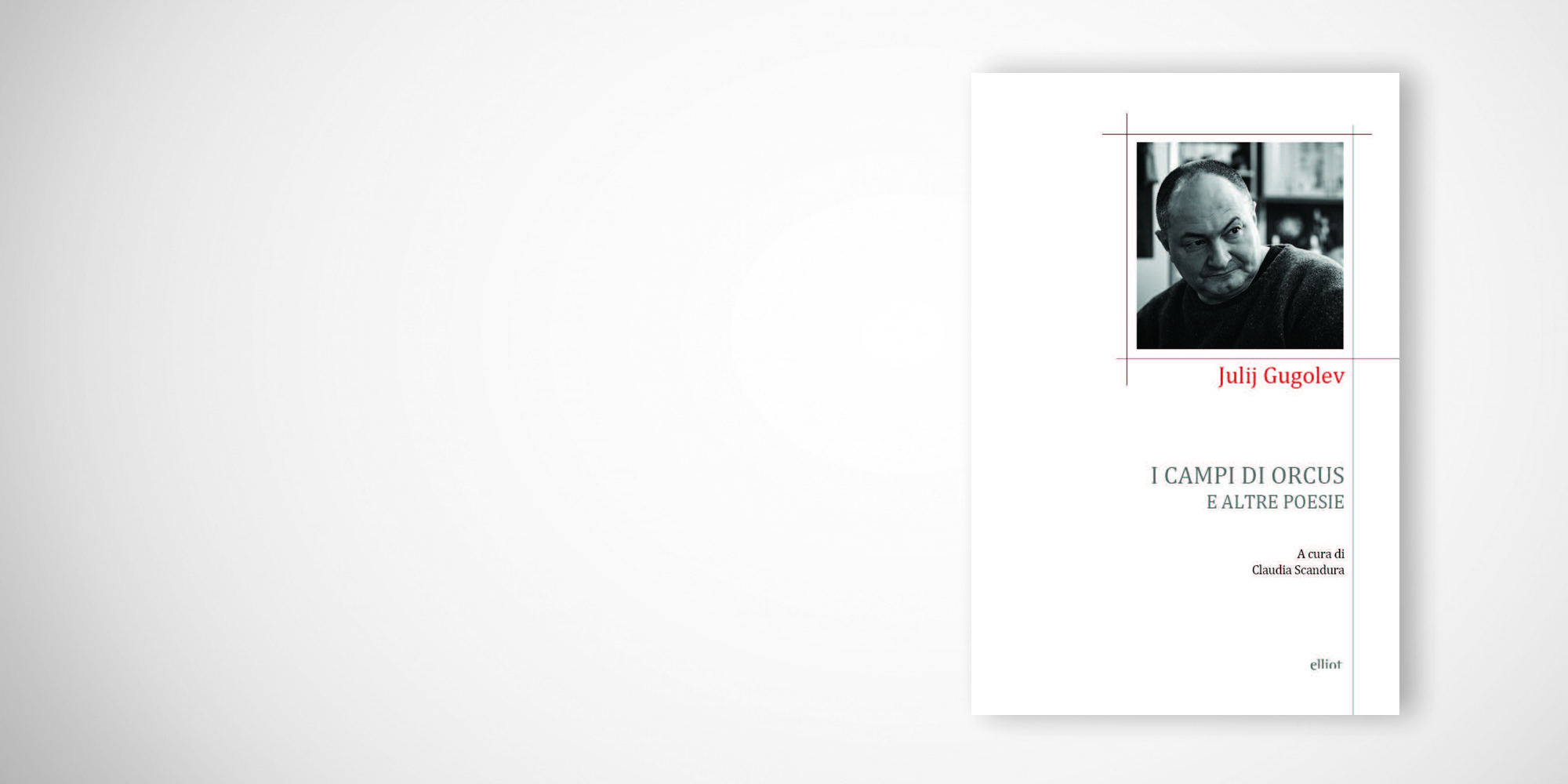
La lettura del libro di Julij Gugolev, recentemente uscito per le Elliot-Lit edizioni, I campi di Orcus e altre poesie, la prima antologia italiana del poeta moscovita che riunisce testi tratti da tre raccolte: My – drugoj (‘Noi siamo l’altro’, 2019), Volynščnik nad Arlingtonom (‘Lo zampognaro di Arlington’, 2020) e Orkovy polja (‘I campi di Orcus’, 2022) mi suggerisce alcune suggestioni. La miscellanea, che prende il titolo dall’ultima raccolta del poeta, uscita in Israele, a differenza delle precedenti pubblicate in Russia, è curata e tradotta da Claudia Scandura, la slavista ripetutamente segnalatasi per l’impegno nel presentare al lettore italiano le più significative voci poetiche della Russia contemporanea. Ricordiamo in particolare il poema Latrine (1990) del poeta osseto di lingua russa Timur Kibirov (Le lettere, Firenze, 2008), premiato nell’edizione del 2010 del Lerici-Pea, le raccolte poetiche di Sergej Gandlevskij, le poesie di Elena Fanajlova, e infine il volume Spogliatoio femminile. Poesia e prosa 2001-2015 di Marija Stepanova, autrice ora ben conosciuta in Italia, solo per citare gli autori principali.
Come leggiamo nell’illuminante saggio introduttivo della curatrice, al pari di molti scrittori russi anche Gugolev, poeta e traduttore, è approdato alla poesia dopo aver svolto lavori diversi, nel suo caso assistente medico nelle ambulanze e conduttore televisivo. Dopo l’iniziale diffusione delle sue poesie su rivista, le opere di Gugolev hanno cominciato ad essere pubblicate in volume nel nuovo millennio. Uno dei più interessanti autori della scena poetica russa contemporanea, Gugolev ha sviluppato negli anni una versificazione molto personale nella quale una lingua colloquiale e gergale, non priva tuttavia di riferimenti e citazioni del repertorio poetico classico, appare spesso declinata secondo una prosodia tradizionale. La trama linguistica, popolata di calembour, idiomatismi, assonanze paronomastiche, ambiguità polisemiche, contribuisce ad accentuare il contrasto fra il ritmo leggero, talvolta ai limiti della filastrocca, e la tematizzazione di situazioni angosciose e tristi. Con l’aggravarsi delle crisi internazionali e, soprattutto, della guerra fratricida estesasi dal Donbass all’Ucraina tutta, gli accenti ironici e autoironici si sono via via incupiti, e il tono dei componimenti più recenti esprime una critica amara che colpisce sia i nuovi media che allontanano dalla realtà e ne favoriscono la mistificazione, sia gli equilibri generazionali, nei quali i padri sono allineati alla tradizionale narrazione dell’“enorme paese” e sono pronti a sacrificare i figli che “non hanno vissuto”.
Colpisce come la poesia di Gugolev nasca e tragga alimento da un terreno che definirei organico e proprio attraverso la percezione sensoriale porti all’intersecarsi dei piani immaginativi che aprono spazi di autoriflessione.
alcuni arrivano molto lontano,
come una bolla, una cannuccia e una scarpa di betulla,
un motivo, Sulikò, per esempio…
Prendi la mensa. Fra gelatina e ricotta,
e tutti gli altri mangerecci,
d’improvviso hai voglia di obitorio,
di cloro, di pino non essiccato…
Oppure, vieni a congedarti dal cadavere,
e lo senti, lo percepisci appena,
strano, vicino all’obitorio odora di minestra,
splende il sole, frusciano le foglie…
Che razza di adulti, sono bugiardi!
Altrimenti a che cosa gli servirebbe,
che un uomo sebbene non viva
sotto l’effetto di birra e vobla (puro olio di pesce!)
se ne stia seduto a sudare e a starnazzare con loro:
com’è buono! Com’è bello questo mondo!
a esclamare che bontà! il mondo che meraviglia!
E nonno Arkadij, tracannando la Žiguli,
starnazza imperterrito. E la bugia guida il mondo.
Che anche in terra non vi diano posto
le lingue sparite del nord-est,
gli uomini dispersi del sud-ovest.
Si asciuga la pozza di nero inverno.
Si innalza verso il cielo il fumo grigio.
Quanto orrore ci sia al mondo,
ognuno lo decida per conto suo.
Portano con sé bambini altrui.
Chissà di chi sono, nostri, non nostri…
[…]
Il gattino miagola? Il cagnolino abbaia?
Il neonato sgambetta nella culla?
La patria ascolta, la patria sa…
Char’kov brucia. La cenere picchia.
La realtà filtrata dalla infosfera, manipolata sui social, genera sensi di colpa e di impotenza che di nuovo affrontiamo a distanza:
se sei in grado di alzare le chiappe,
inizia la tua mattina con i podcast,
la sera misurala a bicchierini.
Se per te ormai è proprio un tormento
manda qualcosa con PayPal,
immaginando a quante persone subito
nei rifugi andrà molto meglio.
il tuo acuto giudizio e il tuo strazio
a qualcuno sono serviti?
assumi un atteggiamento corretto,
ardono le case altrui dalla periferia
e la piazza in città brucia.
In Le vedi quelle luci lontane? l’ansia della precarietà è innescata dal fissare, nel dormiveglia, delle crepe nel soffitto e nelle pareti, con il sottofondo delle sirene delle ambulanze che sfrecciano nella notte, e culmina il giorno successivo durante il viaggio in campagna quando nel fischio del treno si insinua il ricordo della musica di un funerale militare, la ritualizzazione della morte al fronte, iconizzata da centinaia di film americani.
con i cani dagli amici alla dacia!
E là, sopra i quadratini delle dacie,
il fischio del treno ci schiaffeggia in viso,
come il pianto acuto, malinconico
dello zampognaro di Arlington.
Non è più una macchia, ma un marchio.
Tutta la notte l’ho tenuto a bagno,
pensavo, di mattina andrà via da solo.
Non è andato via, ho strofinato, non è sbiadito,
e striscia lungo il mio braccio.
E il gusto salato del ferro è
nel cielo, nell’aria, sulla lingua.