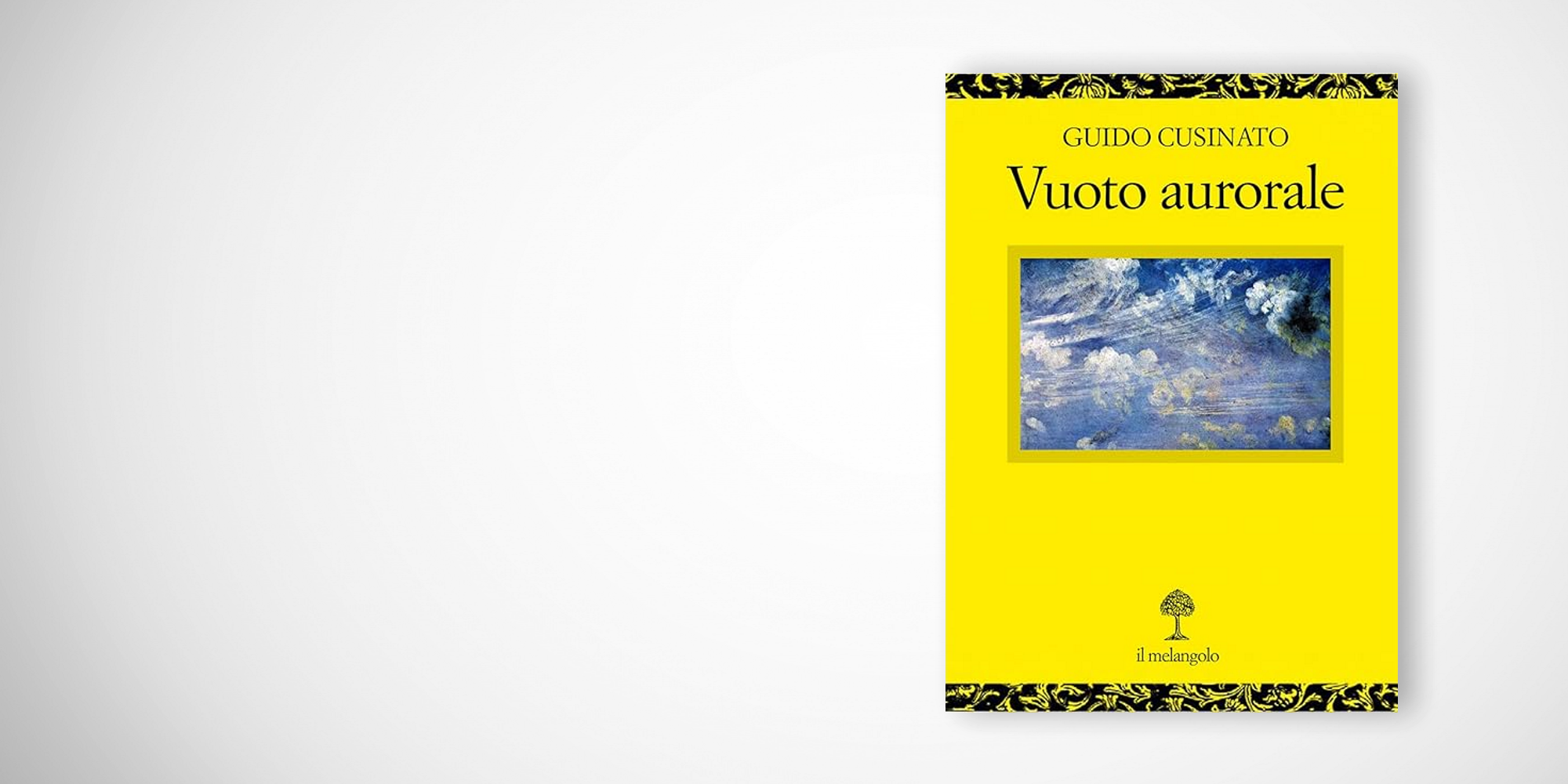
Guido Cusinato, Vuoto aurorale
Dello stesso avviso era anche Arthur Schopenhauer che, in Parerga e Paralipomena, afferma: «Le persone che hanno passato la vita leggendo e hanno attinto la loro sapienza dai libri somigliano a coloro che, da un gran numero di descrizioni di viaggi, hanno acquistato la conoscenza precisa di un paese».3 E ancora: «Vi sono due tipi di scrittori: coloro che scrivono per amore della cosa, e coloro che scrivono per scrivere. I primi hanno avuto idee oppure esperienze che sembrano loro degne di essere comunicate; i secondi […] scrivono per riempire la carta […]. Appena ce ne accorgiamo, dobbiamo buttar via il libro: il tempo è prezioso».4
Traggo queste due ultime citazioni dall’ultimo libro di Guido Cusinato, che pur sviluppando con rigore teoretico il concetto di «vuoto aurorale» come origine della filosofia e fondamento dell’esistenza umana, lo fa a partire da una prospettiva vissuta, radicata nella sua esperienza personale. È questo, almeno per me, il primo merito del libro, che auspico possa raggiungere molti lettori, perché offre strumenti preziosi per attraversare quei momenti in cui tutto sembra vacillare, in cui sentiamo mancarci la terra sotto ai piedi.
Ma partiamo dal dipinto scelto per la copertina: Study of Cirrus Clouds (1822) di John Constable. L’artista romantico inglese era affascinato dalla natura e, in particolare, dal cielo, che divenne uno dei soggetti privilegiati della sua pittura. In quest’opera, così come in Brighton Beach del 1824, lo sguardo dello spettatore è naturalmente attratto dalla trama delle nubi alte, fluttuanti, in continuo movimento nella volta celeste, che si distendono e si dissolvono, generando un senso di profondità e di dinamismo che pare espandersi oltre i confini del quadro.
Constable era famoso per annotare con estrema precisione il luogo e l’ora in cui realizzava i suoi studi. Non so se, in questo caso, stia dipingendo proprio il vuoto aurorale, quel momento sospeso tra la notte e il giorno, quando il buio si ritira lasciando spazio alla luce. Ma mi piace immaginare sia proprio così. Il blu profondo e intenso della parte superiore del dipinto si dissolve gradualmente in tonalità sempre più chiare, fino a diventare quasi bianco in prossimità del luogo da cui sorge il sole – un effetto che fa pensare a un’alba imminente. Il vuoto aurorale, come spiega Cusinato nel libro, è infatti un vuoto «promettente», un’oscurità gravida di luce, che preannuncia una nascita.
È dall’esperienza – dall’accettazione, assunzione e ascolto – di questo vuoto, che nasce la filosofia, o meglio che può nascere il filosofo. L’origine della filosofia non è infatti solo un evento storico, bensì un gesto «originario», che non rimane confinato agli albori della coscienza umana, non si esaurisce nella storia della filosofia, ma si rigenera in ogni essere umano che si pone il problema di dare una forma alla propria esistenza, rinnovandosi ogni volta in ciascun individuo che sceglie di interrogarsi e tentare di comprendere quanto è emerso nella propria esperienza e che conseguenze abbia avuto su di lui.
Un gesto, questo, che si rifà al movimento periagogico del prigioniero nella caverna di Platone,5 al momento in cui questi si gira, distogliendo lo sguardo dalle ombre per rivolgerlo verso la luce, il sole del Bene. Per Cusinato, questo gesto corrisponde a un’esperienza giovanile di crisi, un passaggio esistenziale che definisce «vuoto promettente» o «vuoto aurorale». Non si tratta – spiega – di una semplice mancanza da colmare, ma dell’esito di un evento traumatico che, se assunto e vissuto, ridimensiona, spazzandolo via, tutto ciò che è secondario o superfluo, aprendo così uno spazio interiore in cui può emergere qualcosa di nuovo, di essenziale, di autentico. Si tratta, insomma, di una sorta di risveglio. In termini religiosi parleremmo di conversio.
Ma da cosa nasce quel senso di disgusto della vita, che, a un certo punto del nostro percorso esistenziale, può afferrarci mettendoci in crisi? Da cosa nasce la nausea?
Cusinato parla di inquietudine del cuore, una tensione, una fame, che cerchiamo di colmare, spinti dalla società in cui viviamo, con il fare frenetico, con dei beni di cui non abbiamo bisogno, e poi soprattutto con il riconoscimento sociale. Quella fame invece è fame di nascere. È la «singolarità personale» che vuole formarsi a partire dall’informe. Essa preme dentro di noi per venire alla luce e non essere soffocata, prima di nascere, dal «piccolo sé», centrato solo su stesso, egoista. Io sono – scrive Cusinato – la mia fame di nascere:
L’inquietudine del cuore è dunque la percezione di uno «spazio» ulteriore che si estende oltre i confini del «piccolo sé» (la parte dell’anima che si identifica con l’io). È un vuoto che la logica del fare non può riempire. Questa inquietudine segnala che l’esistenza umana è un processo ininterrotto di nascita. L’uomo è «venuto al mondo senza aver finito di nascere» e l’inquietudine del cuore lo spinge a proseguire questa nascita, superando i limiti autoreferenziali del piccolo sé.
Pertanto, il vuoto del cuore è aurorale perché annuncia qualcosa che non è ancora nato. È un’apertura, un varco, uno spazio non saturo che richiede un atto sacrificale di distacco dal proprio sé egotico per manifestarsi. Il vuoto aurorale è un’apertura che, se non ostruita, accoglie una dimensione della realtà altrimenti inaccessibile. È quel vuoto che consente il manifestarsi di una presenza che altrimenti non potrebbe manifestarsi. Non è la singolarità a controllare il vuoto aurorale, ma è la singolarità stessa a prendere forma grazie ad esso, diventandone la custode della generatività, come precisa Cusinato:
Tuttavia – si badi – questa esperienza di trasformazione di sé non è neppure l’atto autopoietico di un sé autonomo, solitario, solo. L’essere umano è originariamente in relazione con altri sé e con il mondo, come ha spiegato l’esistenzialismo da Max Scheler in poi. Non nasce con una forma esistenziale compiuta, ma la assume attraverso l’esperienza e le relazioni sociali. Cusinato insiste molto sul carattere intrinsecamente relazionale e sociale del sé. L’esperienza dell’incontro con l’altro è vista pertanto come una novità che feconda e trasforma, permettendo la continuazione della nascita.
Ora il desiderio è sempre desiderio d’altro. Anche quello della «persona singolare» è sempre rivolto all’altro, ma non cerca nell’altro una mera conferma del proprio essere, bensì un’uscita da sé per rinascere nell’incontro. L’amore vero sposta il baricentro del desiderio e del proprio essere dall’io, dal sé piccolo, all’altro. L’altro non è desiderato per farne «trofei» – simboli del proprio successo, come accade nel caso del piccolo sé –, ma per la sua esemplarità, ovvero l’energia che emana da chi ha superato il proprio piccolo ego. Il rapporto tra persone singolari non è una relazione di dominio, ma di reciproco riconoscimento.
In Vuoto aurorale un ampio rilievo è accordato agli «esercizi spirituali», pratiche di purificazione, svuotamento, attenzione. Riprendendo il pensiero di Pierre Hadot, Cusinato sostiene, a ragione, che il discorso filosofico moderno abbia tradito l’eredità della filosofia antica, la quale era concepita come un vero e proprio «esercizio di cura dell’anima».
Mi soffermerò, in questa recensione, sull’esercizio dell’attenzione, intesa come la facoltà capace di farci percepire la bellezza e la verità e di indirizzarci verso azioni giuste. È impressionante notare come, riguardo all’attenzione che definisce aurorale, Cusinato giunga autonomamente, per proprio conto, alle stesse conclusioni di Simone Weil. La filosofa francese non è mai citata, e tuttavia sembra che un’eco segreta attraversi entrambi i pensieri.6
Cusinato distingue tre forme di attenzione. Vi è anzitutto quella volontaria, un atto intenzionale che concentra lo sguardo e lo sforzo su un oggetto o su un compito preciso. Vi è poi l’attenzione involontaria, passiva e indifesa, che si lascia catturare dagli stimoli esterni, trascinata senza filtro né attesa, esposta al fascino di ciò che seduce o alla ferita di ciò che colpisce. Infine, l’attenzione «aurorale», che non è né il gesto mirato della volontaria, né l’abbandono inconsapevole dell’involontaria, ma piuttosto una vigilanza distesa e silenziosa, resa possibile da un esercizio di alleggerimento della volontà del «piccolo sé» e di svuotamento dalle distrazioni e dal rumore interiore.
Questa forma di attenzione è per Cusinato, come anche per Weil, uno «sforzo negativo», un esercizio del «non» (non volere, non cercare, non interrogare…),7 che comporta il distacco da noi stessi, sospendendo pensieri, preoccupazioni, ambizioni e desideri del piccolo sé. E, come Weil, anche Cusinato non la considera soltanto un atto intellettuale o cognitivo, ma ne mette in luce il valore morale, intendendo l’attenzione come la capacità di aprirsi ad altro e all’altro, di vederlo, ascoltarlo, comprenderlo davvero.
In questo stato di «vuoto», diventiamo infatti capaci di accogliere davvero ciò che vogliamo comprendere. L’attenzione è attesa, scrive ripetutamente Weil (le due parole hanno infatti la medesima radice). Solo nel vuoto e nell’attesa è possibile il manifestarsi della presenza di qualcos’altro. L’attenzione si manifesta allora anche come una profonda capacità di ascolto, che apre la strada a un amore autentico per il prossimo. La pienezza dell’amore, affermava Weil, sta semplicemente nella capacità di chiedere all’altro: «Qual è il tuo tormento?».
La pienezza dell’amore per il prossimo è semplicemente la capacità di domandargli: “Qual è il tuo tormento”. […] Per questo motivo saper posare su di lui un certo sguardo è sufficiente, ma indispensabile. Uno sguardo che prima di ogni cosa è uno sguardo attento, con il quale l’anima si svuota completamente del proprio contenuto per accogliere in sé l’essere che sta guardando così com’è, in tutta la sua verità. Di un simile sguardo è capace solo colui che sa prestare attenzione.8
Significativamente, il libro si chiude con una riflessione sull’arte del kintsugi, quale metafora di rinascita. Il kintsugi, letteralmente ‘riparazione con l’oro’, è un’antica arte giapponese che consiste nel riparare oggetti in ceramica rotti utilizzando una lacca mescolata con metalli preziosi. Questa tecnica non nasconde le fratture, ma le esalta, le evidenzia, rendendole parte integrante dell’oggetto. Grazie alle sue “cicatrici” dorate, l’oggetto riparato diventa più prezioso di quanto non fosse prima della rottura. Le cicatrici testimoniano della sua storia e della sua unicità.
Nel contesto del libro, il kintsugi funge da potente metafora per il processo di rinascita della singolarità personale dopo un trauma. Come il vaso riparato, la persona non si limita a tornare come prima, ma rinasce in una nuova forma, arricchita dalla memoria del trauma superato e dalla forza delle relazioni di cura che l’hanno sostenuta. Allo stesso modo i tagli nei quadri di Lucio Fontana, vere e proprie ferite impresse nelle tele, conferiscono loro la dimensione della profondità, così come le nostre ferite, segnandoci, ci aprono al mondo:
Come per le esperienze analoghe di Descartes e Spinoza, descritte nelle loro opere e riprese e commentate in Vuoto aurorale, anche in questo caso l’esperienza vissuta è stata un seme che, nutrito dalla meditazione, ha fatto germogliare il pensiero e modellato la personalità in una forma nuova.
Nel Discorso sul metodo, dopo aver narrato l’esperimento del dubbio radicale vissuto in solitudine in una stanzetta ben riscaldata, Descartes scriveva: «vorrei che i lettori non impiegassero solamente il poco tempo che occorre per leggerla, ma qualche mese o almeno qualche settimana a considerare le cose di cui essa tratta, prima di passare oltre». «Descartes – chiosa Cusinato – […] getta al lettore i semi della propria esperienza formativa, con l’invito a lasciarli germinare. Ma affinché possano germinare, le sue pagine vanno meditate» (p. 70).
Anche le pagine di questo libro, come quelle degli autori a cui viene dato rilievo, non vanno semplicemente lette, vanno fatte lievitare. Non si tratta di una mera trasmissione d’informazioni dottrinarie, ma di una comunicazione germinativa. Ovvero, come avrebbe detto Kierkegaard, di una «comunicazione di esistenza».
1 B. Pascal, Frammenti, trad. it. di E. Balmas, Milano, Rizzoli, 1994. Questa traduzione italiana numera i frammenti seguendo l’ordine di ricorrenza e la numerazione dell’edizione delle Pensées curata da L. Lafuma. I frammenti citati sono il 633 e il 427.
2 S. Kierkegaard, Diario, trad. it. di C. Fabro, Brescia, Morcelliana, 2011, tomo I, p. 119, 1° agosto 1835.
3 A. Schopenhauer, Parerga e paralipomena, a cura di G. Colli e M. Carpitella, Milano, Adelphi, 1983, tomo II, § 262.
4 Ivi, § 272.
5 Sempre su questo tema, si veda G. Cusinato, Periagoge.Theory of Singularity and Philosophy as an Exercise
of Transformation, eng. transl. by R. Shibuya and K. Whittle, Leiden Boston, Brill, 2023.
6 Forse l’eco del comune riferimento a tradizioni orientali e a Meister Eckhart.
7 «Gli esercizi di distensione sono esercizi del non volere, del non cercare, del non domandare. Esercizi del non progettare o prefigurare qualcosa. Qualcosa di nuovo può emergere dal vuoto aurorale solo se non è riconducibile al previsto, al noto, al già classificato. Altrimenti faccio esperienza solo di quello che sono e so già e non incontro mai qualcosa che è al di fuori della mia mappa mentale. Se sono concentrato nella ricerca di qualcosa, allora vedo solo ciò che cerco; incontro solo il riflesso di ciò che ho già anticipato» (pp. 97-98, corsivi miei).
8 S. Weil, Riflessione sul buon uso degli studi scolastici in vista dell’amore di Dio, in Ead., Attesa di Dio, trad. it. di M.C. Sala, Milano, Adelphi, 2009, p. 200.
9 Cfr. la registrazione della conferenza: La filosofia come esercizio di trasformazione e il vuoto aurorale.