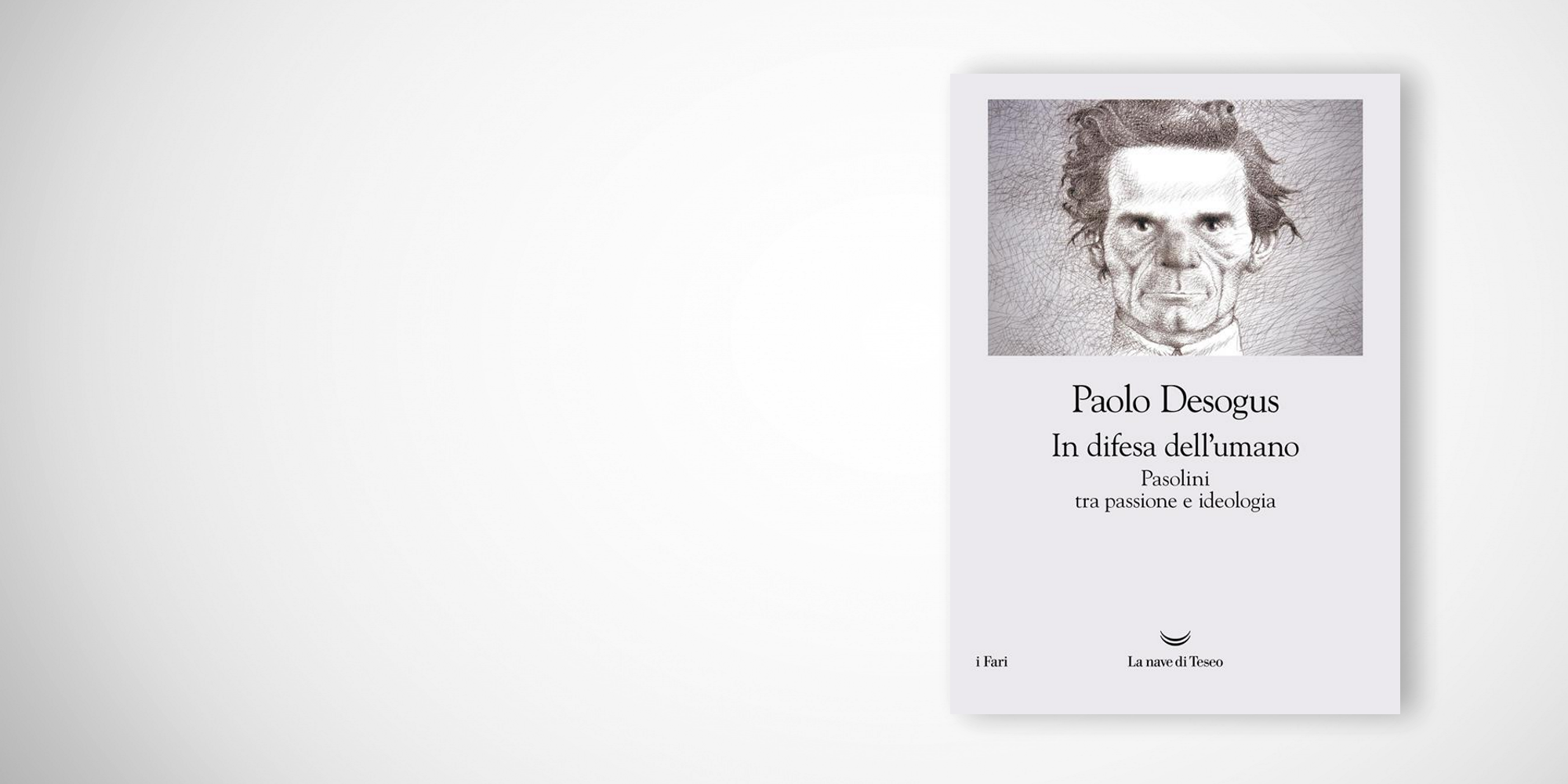
Il problema Pasolini è con ogni probabilità un problema irrisolvibile. Non è in giudizio la questione se ci piaccia o no la sua poesia, se Pasolini è stato o non è stato un poeta, se Pasolini è stato uno scrittore di opere essenzialmente incompiute, un poligrafo senza capo né coda, se questa sua condizione dettata dalla sua stessa mitografia può essere l’origine di una situazione di ambiguità critica. Ma ciò che pare davvero difficile da sbrogliare del “problema Pasolini”, è quello di riferirsi a Pasolini scrittore nel suo aspetto più concreto riguardante, fin dalla sua adolescenza ipersensibile, la multiforme realtà delle sue opere, dentro al fatto della sua arte poetica «la cui capillarità è la mia stessa capillarità» come egli stesso la autodefinisce. Arte poetica capillare strutturata ogni qual volta Pasolini decide di definire una sua circostanza poetica.
Pasolini nella sua capacità di elaborare più stili si spinge verso il luogo creativo di una oltranza istintiva, oltre i modelli letterari istituiti. Ma questo non è un problema riguardante soltanto l’accendersi di quella poesia, è un problema riflesso nella poesia in generale e di trasformazione della vita in poesia dentro alla propria officina poetica. Di questo ordine di problemi Pasolini è vitalmente saturo. Ne parla e fa, fa e ne parla, è una costante. La poesia è una ricerca con qualche approdo, le opere, mai sicuro. Rileggendo le biografie scritte su Pasolini (dove ampi stralci di lettere e diari e quaderni aperti sono riportati), in ordine cronologico: quella tempestiva di Enzo Siciliano, scritta subito dopo la morte del poeta assassinato, di Nico Naldini e di Barth David Schwartz, e la più recente quella di Antonio Tricomi, si può constatare come queste biografie non siano dei requiem, anzi. Si rimane abbagliati dalla coscienza di Pasolini, fin dalla sua «meglio gioventù», di essere come per destino un poeta, e, aggiungerei, di essere un poeta assoluto. In più si può aggiungere alla storia di Pasolini che egli fu un poeta disobbediente. Pasolini poeta disobbediente in poesia. Nel mondo delle lettere italiane, un poco alessandrino, è un elemento di instabilità concreto, con la sua poesia e per i temi legati alla poesia che si carica sulle sue spalle. E bisogna avere spalle robuste. Nel poeta delle Ceneri di Gramsci esiste la capacità di trasformazione dei dati concreti dettati dall’esperienza come dalla ricerca culturale. La sua poetica in atto, in pratica, non è imputabile a un territorio poetico concettuale privo di solidità, invaso unicamente da cellule emotive in continua dispersione. Pasolini esplicita, porta alla luce, proprio fuori di sé, questo suo lavoro ossessivo di elaborazione artistica compreso il concetto stesso della forma del saggio letterario. Passione e ideologia, Empirismo eretico e, a mio avviso, il postumo Descrizioni di descrizioni, rappresentano le cose migliori di un poeta che parla di poesia nel mentre sta facendo la sua poesia.
Quella di Pasolini è un’epoca lontana da noi anni luce. Storia fattuale, storia poetica e storia delle idee si intessono e convergono nel nuovo libro dedicato a Pasolini da Paolo Desogus, In difesa dell’umano, Pasolini tra passione e ideologia. Pasolini ha avuto, e ciò mi pare davvero incontestabile, la capacità di far partire da lui e attraverso di lui una miriade infinita di fili concettuali derivante anche dalla sua abilità (del suo genio), di assorbire qualsiasi elemento che potesse rendere utile e comunicativa la varietà del suo operare altrettanto di indubbio talento. Voglio riportare dalla biografia di Scharwz un breve annotazione. Poco dopo la morte di Pasolini il critico svedese Bengt Holmquist che pochi giorni prima lo aveva incontrato a Stoccolma, scrive del poeta friuliano e della sua capacità multiforme di fare: «Il suo fu un talento di respiro raramente visto prima […]. Per avere un equivalente si dovrebbero immaginare Sartre, Böll e Bergman nella stessa persona…». Ci spiega Desogus in modo concreto ed efficace con un linguaggio abbordabile ai più (è un merito senza venire meno alle sue puntuali analisi, quasi cento pagine di note, quasi un libro nel libro, note di approfondimento necessarie, sempre interessanti non di superficie accademica) che la cultura di Pasolini non era quella di un flâneur di passaggio e a passeggio (Desogus fa alcuni nomi, quello di Siti e Mengaldo su tutti, e mi trova d’accordo; nell’antologia di Mengaldo Poeti italiani del Novecento del 1978 l’esperienza della rivista «Officina» nell’introduzione è appena accennata, né esiste la poesia di Roberto Roversi) ribaltando una vulgata abbastanza comune, cioè quella di un Pasolini senza. E della ricchezza di Pasolini come limite. Già nel corso degli anni è emersa la notizia critica di un Pasolini incompiuto, di Pasolini (addirittura) non poeta, con fondamenti filosofici azzerati. Desogus ribalta questa analisi critica, lo fa in modo assertivo, pervicace, nei documenti e, lasciatemi dire, pure con un certo orgoglio che si coglie nella sua scrittura critica. Desogus pone la sua attenzione di critico su alcuni aspetti che sono le fondamenta del sapere di Pasolini. Non Pasolini poeta dell’irrazionale. Pasolini poeta irrazionale, no. Montale che è il recto della poesia italiana del novecento, Pasolini il suo quasi esatto verso, scrive (è cosa nota) riprendendo l’idea da Tommaso Ceva che «la poesia è un sogno fatto alla presenza della ragione». Pierre Klossowski in un labirintico libro a spirale su Nietzsche spiega: «Bisogna dunque tener presente che, per Nietzsche, il fine (la vita inconscia) esiste solo perché c’é di mezzo (la coscienza)». Se poi un poeta come Pasolini riesce a pescare nel suo inconscio tramite un medium diretto è una ricchezza da non invidiare, è una ricchezza, i poeti lo fanno e sono così.
In particolare, ed è più di una semplice curiosità, è un documento storico, c’è il ritrovamento ed è una scoperta proprio sua di Desogus, del registro degli esami di filosofia (sarebbe stata la sua seconda laurea dopo quella in lettere con la tesi su Pascoli) dell’Università di Bologna come allievo del filosofo esistenzialista Felice Battaglia. Desogus ritrova le dispense degli anni accademici 1945-1947. Filosofia esistenzialista (insieme a quelle su Fortini-Pasolini e Gramsci-Pasolini, e De Martino-Pasolini sono le pagine migliori, scritte con un un certo fascino dei tempi andati, forniscono al lettore una certa nostalgia e voglia di andare a rileggere Pasolini alla luce di questi riferimenti filosofici e antropologici) che va a incrociarsi con la poesia di Giacomo Leopardi. È Leopardi la sorgente della poesia di Pasolini. Filosofia che si trasforma in poesia, conoscenza del sé (Rimbaud) e conoscenza delle cose in «ultrapoesia» (la filosofia, il suo carattere esistenziale, innervata a proseguire nell’azione della poesia) come scrive Desogus muovendo da una intuizione di Remo Bodei. È Leopardi proprio a innervarsi in quella poesia del giovane di Casarsa e poi universitario a Bologna. Approfondimenti, questi di Desogus, trascritti nella volontà ostinata di non piegarsi ai luoghi comuni che fanno del «buio ventre» di Pasolini il solo luogo possibile della poesia e non, invece, la ragione vitale della sua poesia. Inoltre bisogna in ogni modo chiarire che un poeta non è una enciclopedia del sapere filosofico. Allora cosa possiamo dire di Sandro Penna? Un poeta per sua natura possiede già, a diversi gradi, una sua poesia esistenziale, derivata dalla sensibilità dell’esperienza del suo esistere, e spesso è un motivo o sono due al massimo i motivi che accompagnano tutta la vita un poeta. Il male di vivere di Montale, la perplessità angosciata dell’esistente di Sereni, le ferite mai ricucite della ragione e della ideologia e come del cuore di Fortini. La contraddizione in atto dei poeti e della poesia. Poeti si è come lo era Pasolini e non, per forza, si diventa. La poesia agisce per soluzione e assorbimento (come avviene per la poesia del suo contrario Montale) dentro una densità sociale.
Più complesso è il rapporto ideologico tra marxismo e poesia. Desogus propone l’incontro della lettura di Gramsci da parte di Pasolini già ai tempi della federazione comunista di Casarsa retrodatando di fatto la scoperta gramsciana come nucleo fondativo dunque ragionativo per la poesia di Pasolini. L’empatia a contatto delle poesie Pasolini è un pianto che ricade che sta sulla terra concreta non sulle astratte nuvole. Pasolini è un anti-ermetico (sulla rivista «Officina» dal primo numero presenta il suo pensiero; si veda per di più l’approfondita antologia edita da Einaudi nel 1975 e mai più riproposta di Gian Carlo Ferretti, «Officina», il sottotitolo è: «cultura, letteratura e politica negli anni cinquanta») non è uno scrittore per suo volere occulto, è simile a Gide de L’immoraliste e De Sade di Les 120 Journées de Sodome. Nelle poesie postume L’hobby del sonetto si legge: «sevizia / la mia povera anima libertina / in un vecchio, / atroce struggimento». Pasolini non è uno scrittore occulto che parte dal suo ventre buio per poi ritornarvi, è invece un poeta che vuole, che ha il desiderio della luce per esprimersi attraverso la poesia. La sua morte è stata il vero spartiacque nella nostra poesia. La faglia temporale tra un prima e un dopo. Il 1975 è una data senza ritorno. La poesia giovane italiana da quella notte di novembre del 1975 è tornata nel suo meglio pensierosa e lacerata oppure nel suo peggio bisognosa altrimenti di non pensarci. La poesia ha sempre la capacità, come certi fiori, di sopravvivere al buio. Ha una sua innegabile volontà di sopravvivenza. Ma ciò che veramente si è perso (almeno negli ultimi trent’anni, lo abbiamo visto in modo più diretto) è stata la perdita nella nostra poesia di una ricchezza (proprio concettuale, di problemi, di filosofia della composizione) derivante complessivamente anche dal lavoro di Pasolini. La cosa interessante di questo libro è che si accede a Pasolini non per via negativa (non ha fatto come invece poteva fare ecc., era privo di un fondamento filosofico, spiluccava qua e là su tutto ecc…). È strano, inoltre, come non ci si sia accorti di come Pasolini sia tutt’altro che un poeta soddisfatto di sé e del proprio risultante fare. È come tutti i veri poeti. Non è Pasolini la figura saldamente statica di un ego antimoderno vivente nella traduzione esplicita del suo desiderio. Ogni qual volta cita la tradizione di un passato lo scrittore di Petrolio la fa urtare con uno pseudo benessere mentale, non so quanto borghese ma certamente ultrapostmoderno. Qui, è inutile nasconderci, siamo arrivati in questo ultra-postmoderno più poveri di noi stessi e intellettualmente malconci ma ancora, è la misurata illusione, intellettualmente vivi. Chi scrive versi sa che una poesia finita può essere un piacere, un soddisfatto desiderio, ma che diventa o che può diventare quasi subito dopo un orrido piacere trascritto come da un sosia o da un altro che da lui medesimo. Vengono alla mente i versi di Sereni: «non c’è mai / alcun verso che basti / se domani tu stesso te ne scordi». In pratica Pasolini non ha ricchezze sepolte ma ricchezze esposte. È un poeta, Pasolini, che rifeconda altri luoghi espressivi. Se lo stile è una impronta, in Pasolini ci troviamo di fronte a una foresta di impronte dove ognuna di queste imprime la propria linfa vitale nella necessità di non perdere quella ricchezza. Il presente per la scrittura Pasolini è sincronico (oggi invece viviamo in un presente, per quanto riguarda la poesia, asincronico, «transumanista» sottolinea Desogus, con cadute verso l’arcadia dei sentimenti e con ritardi di ogni tipo), poesia e storia in lui finalmente si univano si stringevano nel loro stesso fondamento della poesia come azione. Pasolini cercava e con una certa ostinazione l’efficacia di questa utopia che è l’utopia dei poeti. Se la sua poesia dinamica si trasforma a livello formale di tecnica poetica facendo leva su di un verso elastico non metricamente compresso è il segno fattivo, insieme ad altre mille cose piene di tragiche bellezze, della sua curiosità inesauribile, della sua ricchezza di poter cambiare per poter meglio dire le cose in poesia, anzi il suo sogno poetico di una cosa.