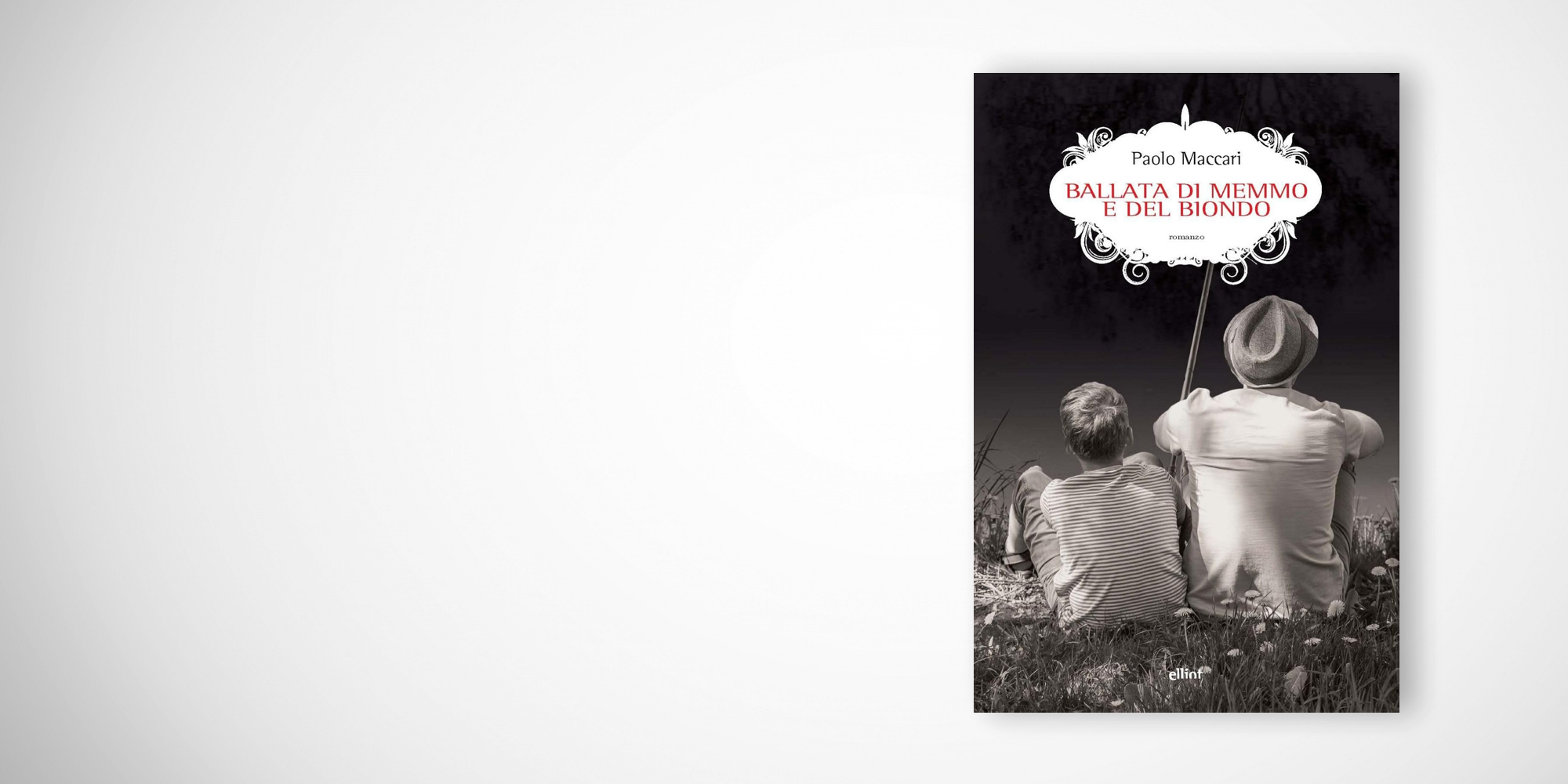
Al giro di boa dei cinquant’anni, con già diverse raccolte poetiche1 di sicura originalità e alcuni studi critici2 di alto profilo alle spalle, Paolo Maccari con la sua Ballata di Memmo e del Biondo fa brillare una luce destinata a durare nel tempo, ed è come venisse da qualche astro sperduto, invisibile alle rilevazioni degli strumenti ordinari. Racconto lungo, romanzo breve, prosa con accenti poetici, monologo teatrale? Inutile baloccarsi con le definizioni: nella Ballata coesistono in armonia componenti di generi diversi; e non si dimentichi che fin dagli esordi nei libri di Maccari si leggevano, intramezzati ai versi, affilatissimi testi in prosa che sapevano far riecheggiare note provenienti dall’invadente, stranita polifonia (ovvero cacofonia) del mondo, sicché malinconie e motivi del versante lirico non esaurivano mai l’orizzonte del discorso ma s’intrecciavano tra loro dischiudendo un surplus di senso, alcunché da maneggiare con prudenza perché abrasivo e molesto per il pensiero conciliato o abituato ai comfort del disincanto. Ambivalente, del resto, – suggestioni musicali a parte – è la stessa titolazione del nuovo libro, dove il termine “ballata” adombra coordinate poetiche di stampo romantico-popolareggiante, mentre dal retrobottega del racconto arrivano ogni tanto gelidi spifferi à la Villon (sarà un caso ma anche qui c’è un testamento…), sottili dissonanze in calcolato controcanto.
Il fatto è che l’autore in questione è sempre un po’ più in là di dove pensi di collocarlo, la sua radice modernista e anticonformista non gli consente di riposare nei calchi della tradizione, che deve ogni volta reinventare e torcere ai propri fini – il che può fare solo chi la conosce bene – senza però ingenuamente rinnegarla. In questo senso anche i nomi che quasi in automatico la critica ha evocato per Ballata, come Tozzi e Bilenchi, pur appartenendo di diritto alla stagione del modernismo italiano ed essendo ovvi riferimenti per uno scrittore toscano, non sono pienamente convincenti: non foss’altro perché la mimesi affidata alla lingua, dall’andamento colloquiale-monologante, in Maccari fa parte del personaggio dell’io narrante, che a sua volta è deuteragonista della fiction e modella la sua postura recitando uno spartito su cadenze “locali”. Quanto alla storia, è presto detta: si tratta dell’incontro tra due esponenti di generazioni diverse, il giovane Biondo e l’anziano Memmo (imprenditore come il padre), sullo sfondo di un paesaggio sociale e geografico (Colle Val d’Elsa) delineato come dall’interno, nei tratti esatti di una topografia familiare e sentimentale che serba l’aura dell’esperienza e del ricordo. Anche qui, come in certi classici, il “cronotopo” dell’Incontro e il motivo del Ritorno si alleano felicemente, facendo coincidere l’arco narrativo con il testamento di Memmo – che è poi l’autobiografia orale al cuore del testo – e con la visita del Biondo: nello spazio di una sera è racchiuso un viaggio nel tempo, disperso in emersioni memoriali pausate, con un proprio ritmo variabile e sapientemente scandito sul metronomo soggettivo.
Colle diventa, allora, la conchiglia in cui risuona il rombo del cosmo sociale, in movimento e ormai in odore di decadenza, proprio come l’azienda di Memmo e la sua stessa famiglia; dalle pagine dedicate ai figli, tra le più memorabili, stinge su tutto un’amarezza tanto più fonda e desolante in quanto non accusata ma implicita nel racconto – il lascito di una vita, se non su un piano meramente economico, non ha eredi; tutto un mondo, con i suoi arredi sentimenti conflitti tradimenti, si perde, una forma di tradizione s’interrompe. Ma il bello è che Maccari mena il lettore, in estroversa e persino contagiosa confidenza, su percorsi per nulla scontati, anzi inquietanti: là dove sembra affiorare l’idillio o spuntare il quadretto di provincia – ed è così promossa l’adesione a figure, luoghi, abiti sociali del tempo andato3 – con piccole scosse egli incrina l’edificio che va costruendo; brevi a parte insinuano dubbi, marcano impercettibili distanze, revocano facili fiducie e slanci irriflessi; i ruoli portanti del racconto a tratti vacillano. Finché, alla fine, l’io narrante stesso si rivela come figura partecipe di un fallimento morale – solo un altro «demonietto cinico», è così che si definisce – e al lettore s’impone una variante di visuale che investe, retrospettivamente, l’insieme del testo. La mossa – a suo modo un coup de théâtre – non è frequente nella letteratura corrente (più spesso semmai nella tradizione anglosassone),4 che dell’ironia e delle sue sfumature sa poco o niente, corriva com’è alle richieste del Mercato e alle mode di un giorno. Qui, invece, è del tutto coerente con il vero tema del libro: l’intorbidarsi di ciò che pareva limpido, l’insinuarsi del falso nel vero, le crepe subdole del reale, l’ambiguità irriducibile del vissuto, sono l’intuizione e la pena di tutto questo a formare la cifra e il momento di Maccari, la sua ferma e resistente impronta nel fosco paesaggio dei nostri anni.
1 P. Maccari, Ospiti, Lecce, Manni, 2000; Id., Fuoco amico, Firenze, Passigli, 2009; Id., Contromosse, Monghidoro, Con-fine, 2013; Id., Fermate, Roma, Elliot 2017; Id., Quaderno delle presenze, Firenze, Le Lettere, 2022.
2 P. Maccari, Spalle al muro. La poesia di Bartolo Cattafi, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2003; Id., Il poeta sotto esame. Con due importanti inediti di Dino Campana, Firenze, Passigli, 2012.
3 Tra questi da rammentare almeno la caccia, che fornisce l’occasione per un passaggio esemplare per efficacia e compiutezza, con riverberi sul significato complessivo: l’uccisione del fagiano (p. 87), qui siamo tra Cattafi (L’allodola ottobrina) e Bassani (L’airone).
4 Si pensi a una pièce come The Homecoming di Harold Pinter, solo in apparenza remoto dal mondo di Maccari.