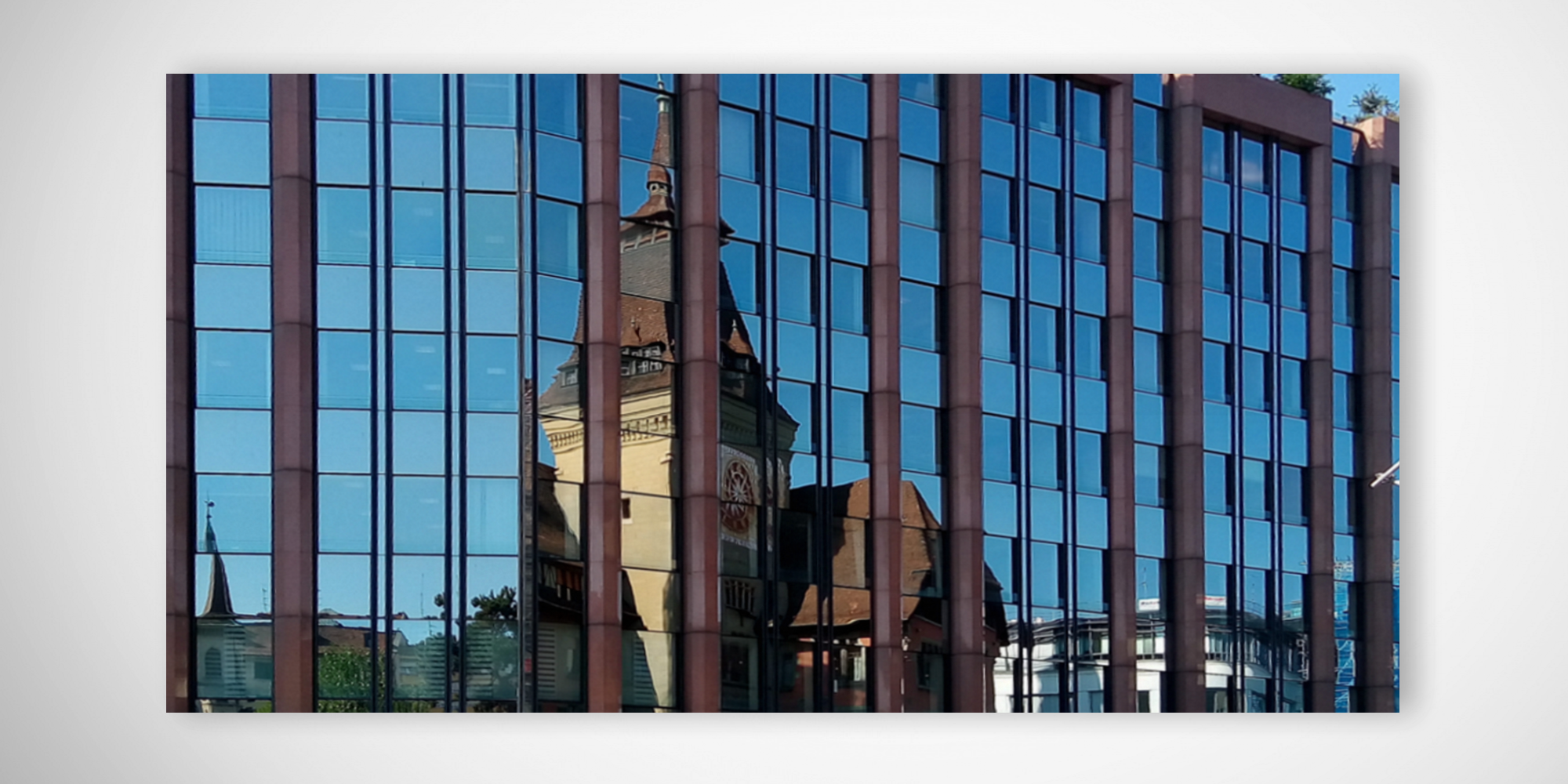
Nel dibattito critico intorno all’opera di Pecoraro c’è un dato che viene spesso ingiustamente trascurato: prima del tardivo esordio in letteratura la disciplina che ha maggiormente frequentato, per formazione e professione, è stata l’architettura. Difatti, dopo essersi laureato presso la Facoltà di Architettura dell’Università “La Sapienza” di Roma, è stato assistente di Ludovico Quaroni e, per un breve periodo, docente di Composizione. La sua produzione progettuale e saggistica è stata pubblicata nelle principali riviste del settore; Paolo Portoghesi, nel 1985, lo ha incluso all’interno dell’antologia I nuovi architetti italiani.2 Nel frattempo, Pecoraro aveva cominciato a esercitare la professione in studi privati e, successivamente, per il Comune di Roma, dove si è svolta la sua trentennale carriera da architetto e urbanista. In una simile prospettiva, è evidente che gli interessi architettonici e, in senso lato, spaziali sono un dato da non trascurare per comprendere la genesi di una certa forma mentis etica, estetica e immaginativa che si riversa nella sua scrittura. Dal piano strutturale a quello tematico, fino a quello microtestuale, diverse sono le implicazioni del primo Pecoraro, disegnatore e progettista, sullo sguardo del Pecoraro narratore: i disegni di copertina dei libri, la logica compositiva dei romanzi e le parentele sintattiche tra urbanistica e scrittura sono, infatti, soltanto alcuni dei terreni di incontro tra le due discipline.
Quella che segue è la trascrizione di un’intervista che intende indagare le forme e le modalità attraverso cui l’architettura entra in relazione con l’opera letteraria di Pecoraro; è stata realizzata nel 2023 a Roma, presso l’abitazione dello scrittore, che ringrazio per aver accettato di rispondere alle mie domande con gentilezza e disponibilità.
Francesco Pecoraro: Mi sono laureato in Architettura a Roma nel 1971, poi ho lavorato come assistente volontario – non c’erano i ricercatori all’epoca – dal 1973 fino a un po’ prima del 1980, dopodiché per tre anni sono rimasto nell’ambiente accademico come professore a contratto nella Facoltà di Reggio Calabria. Durante quei sette anni da assistente volontario ho esercitato parallelamente la professione in uno studio. Ho avuto pochissimi incarichi. È stato un periodo molto difficile, anche per ragioni private. Provai quindi il concorso pubblico, lo vinsi e decisi di accettare. Dal 1980 al 2010 ho lavorato al Comune di Roma occupandomi per vent’anni di Centro Storico e poi di Piano Regolatore. È stato interessante, perché oltre ad avere a che fare con temi molto belli si aveva l’impressione di stare sulle cose. Se ti interessa la professione non è male. Tuttavia sono pochi quelli come me, diciamo così… quelli a cui interessa il lavoro. Il rapporto con la professione è stato questo. Naturalmente non ho mai smesso di studiare architettura, è stata una passione divorante per me.
N.C.: Da romano, com’è stato potersi occupare della propria città? Quali progetti sei riuscito a realizzare?
F.P.: Lavorare al Comune è stato molto duro, si realizzava poco. Essendo un progettista appassionato non smettevo mai di progettare e qualcuno dei miei progetti è andato in porto. Tra questi, ad esempio, c’è la sistemazione di piazza Madonna ai Monti, che prima era un parcheggio. Quando si decise di renderla pedonale feci diversi progetti, molti dei quali non piacquero al comitato di quartiere e perciò dovetti trovare un compromesso, come succede quasi sempre. Inoltre la riprogettazione di piazzale Flaminio, il restauro dell’Acquario Romano e la realizzazione del giardino di un centro anziani in Centro Storico, che all’epoca era l’unico edificio moderno costruito nella Città Antica dopo il 1975. In realtà non è proprio un edificio, è un hortus conclusus, un giardino murato (che piace ad alcuni e non piace ad altri). Ho fatto poi diversi piani, come il Piano di riqualificazione dell’area di Piazza Vittorio e altre cose che francamente adesso non mi ricordo neanche più.
N.C.: Poco fa hai detto che l’architettura è stata una passione divorante e che non hai mai smesso di studiarla. Quali erano le letture che più hanno influenzato il tuo percorso?
F.P.: Gli architetti leggono poco, leggono di tutto e quasi mai di architettura. Leggono romanzi, saggi, eccetera. Però attraverso di questi guardano molta architettura. Io ero molto interessato a vedere i progetti e mi era abbastanza chiaro come andava l’architettura nel mondo. Ero abbonato a diverse riviste, stavo in uno studio con parecchia gente e questi materiali circolavano, ero amico di altri architetti i cui studi che frequentavo quasi giornalmente. Era un po’ un fermento, un circolare intorno a questo personaggio che poi è stato il mio maestro, Ludovico Quaroni.
N.C.: Che tipo di rapporto hai avuto con lui?
F.P.: Quaroni teneva un corso di Composizione architettonica e lo aveva suddiviso in un certo numero di coppie di assistenti a ciascuna delle quali aveva assegnato un seminario. Io ero tra questi. Nei vari seminari preparavamo gli studenti all’esame. Non ho mai pensato che Quaroni fosse un grande architetto, però era una persona che sapeva pensare. Credo che quel po’ di capacità che possiedo di organizzare mentalmente le cose lo debbo a lui. Non è che ci fosse un rapporto molto stretto tra noi, però quando è morto mi sono reso conto che gli volevo molto bene.
N.C.: Leggendo «Tash-blog», il tuo blog attivo dal 2005 al 2011,3 mi sono accorto che compaiono frequentemente i nomi, tra gli altri, di Le Corbusier, Louis Kahn, Mies van der Rohe e Giorgio Grassi.4 Sono stati dei modelli per te nel modo di pensare l’architettura?
F.P.: Sono cose che ho scritto talmente tanto tempo fa che è difficile ricordarle… Indubbiamente, quando parlavo di architettura nel blog non ne parlavo come architetto. Il grande dramma degli architetti, in realtà, è che nessuno si interessa alla loro disciplina, pochissime persone. Anche se tutti abitiamo nelle case, la maggior parte di noi non ci fa caso. Andiamo a visitare le città, che sostanzialmente sono degli insiemi di architetture, però non ci importa della nostra. Queste sono strane contraddizioni. Se io chiedo a un mio collega scrittore chi è Rothko, lo sa. Se gli chiedo chi è Louis Kahn quasi sicuramente non lo sa. Se gli dico Le Corbusier sì, perché Le Corbusier è stato un personaggio storico, anche se vedo che le giovani generazioni che non fanno architettura non sanno chi sia. Quelli che fanno architettura sono come dei monaci: culturalmente emarginati e pieni di miti sulla cultura non architettonica dalla quale pescano in continuazione temi che cercano di riversare nella propria disciplina, quasi mai riuscendoci. Però questa cosa stranamente li fa essere più interessanti: non sanno quasi niente però sanno tutto, non so come dire. Si interessano di tutto, sono aperti, aperti al nuovo.
Poi a un certo punto gli architetti, come tutte le persone, si chiudono. Oppure, se hanno successi, diventano dei profeti: vedi Renzo Piano, che pure è un architetto che stimo, adesso parla come se fosse un papa.
N.C. Mi viene in mente un post del 2008 in cui si distingueva architettura di un tempo e architettura di oggi. Quest’ultima era definita come l’arte di far stare in piedi e rendere abitabili forme scelte a priori a seconda dell’estro e dei bisogni mass-mediali. Potresti approfondire?
F.P.: Non è più così, le cose sono cambiate. In qualche modo penso che la disciplina si stia ricomponendo, ma dato che non la seguo molto, non vorrei dire cazzate. Quel post, se non mi ricordo male, lo feci dopo aver visto un servizio di «Casabella» sul cantiere del Guggenheim Museum di Bilbao di Frank Gehry. Adesso tutte le mie riviste, che erano centinaia, le ho buttate. È stato un dolore terribile, ma anche una liberazione. Nel servizio si vedeva che le forme di quell’edificio hanno una struttura interna calcolata al computer. Il ruolo del computer non va sottovalutato in questa vicenda. Quello che vedi esternamente è un guscio che serve a un’immagine plastica, scultorea, una forma a priori resa abitabile non a partire dal fatto che quella è un’architettura, e quindi che l’abitabilità e la forma sono due cose che devono essere in qualche maniera legate insieme. Si possono pure praticare invenzioni molto spinte, però devono avere un senso architettonico. Insomma, mi dava fastidio questo modo di progettare, tuttavia mi ha sempre interessato, perché mi faceva riflettere.
Ho visto un documentario, sempre su Gehry, in cui nelle prime fasi di progetto prende un pezzo di carta, lo accartoccia, lo guarda e lo butta per terra. Dopodiché alcuni suoi assistenti lo prendono, lui dice quello che gli interessa e cominciano a lavorarci sopra, a scannerizzarlo, a capire qualcosa, ecco. Vedere una cosa del genere è stato per me uno shock e tuttavia devo ammettere che la produzione di Frank Gehry e di Daniel Libeskind, che per me è in linea di massima abbastanza repellente, crea edifici assai iconici che hanno la capacità di attirare e divertire il ceto medio istruito occidentale.
N.C.: A fronte di queste critiche, qual è il modo di fare architettura che contrapponi?
F.P.: Questa è una domanda alla quale per me è molto difficile rispondere. Gehry lo conoscevo da tempo, perché da tempo era emerso come architetto pop. Avevo visto una sua mostra a New York che mi aveva molto divertito, era un personaggio che seguivo. Tuttavia, l’architettura che a me interessava era ancora un’architettura per qualche verso rinascimentale, cioè basata sulla triade vitruviana, su Ser Filippo Brunelleschi, sulla prospettiva, eccetera.
N.C.: Nel 1979 scrivevi su «Controspazio»5 intorno al concetto di casa rifacendoti all’idea di Robert Venturi secondo cui «l’architettura si manifesta tutte le volte che si verifica un passaggio di stato esterno-interno e viceversa». Di tensione tra coppie oppositive è composto anche il saggio Ponte e porta di Georg Simmel, citato in La vita in tempo di pace. Quanto sono stati importanti questi concetti per il tuo modo di concepire l’architettura? Inoltre, mi sembra che tra il Pecoraro architetto e il Pecoraro scrittore ci siano degli interessi costanti, come ad esempio i concetti di ponte, porta e finestra, la triade vitruviana, il sistema trilitico, il discorso su delimitare e abitare, l’idea di mondo come sistema di camere e stanze. Come pensi che tutto questo possa fare sistema?
F.P.: Ma guarda, sono cose rimaste più sul piano concettuale che sul piano progettuale, sebbene abbiano pesato anche su quest’ultimo. Sono concetti che stavo cercando di mettere a punto a partire da un saggio di Lucio Colletti in cui viene fatta una distinzione, che però adesso non ricordo più molto bene, tra opposizioni dialettiche e opposizioni reali. Mi ero chiesto per tanto tempo il perché della fascinazione che avevo per i quadri che mostravano finestre aperte su qualcos’altro, poi ho letto questo libro che mi ha rischiarato le idee. Mi è sembrato di capire che abitare significa esperire un’opposizione primaria tra ciò che è dentro e ciò che fuori. Questa sembra una banalità, e lo è, però è anche profondamente vero, lo vedi anche negli animali: l’istinto dei gatti di andarsi a infilare nelle scatole è il piacere di stare dentro. Se estendi questo concetto a tutta l’esistenza ti accorgi che passiamo la nostra vita, non soltanto a stare dentro o a stare fuori qualcosa, ma anche a avere la sensazione di starci. Questa intuizione me l’ha suggerita un’opera di De Dominicis: un quadrato a terra con scritto Io sono sicuro che voi o siete dentro questo quadrato o siete fuori. È una cosa banale e assolutamente incontestabile, no? In quel momento o si stava dentro il quadrato o si stava fuori. Quando poi estendi ulteriormente questo discorso a quelle che io chiamo camere geografiche, a quel punto ti rendi conto che esperiamo la natura, o comunque la geografia, in questo modo qui: essere dentro il bosco, essere nella valle, essere sulla montagna. Sono tutte condizioni spaziali che creano in noi delle emozioni più o meno positive. Però la percezione base è quella di abitare l’opposizione dentro/fuori che significa poi caldo/freddo, bagnato/asciutto, vento/quiete, eccetera.
Sto leggendo un libro sugli Inuit in questo periodo. Loro d’estate non hanno niente, se non delle tende, per difendersi dal freddo e soprattutto dal vento. D’inverno, quando le temperature scendono vertiginosamente e il paesaggio è interamente coperto di ghiaccio e neve, paradossalmente stanno meglio perché possono costruirsi degli igloo in qualsiasi luogo. L’igloo significa difendersi dagli elementi e stabilire un micro-clima interno più caldo rispetto ai -40° che ci sono all’esterno, significa poter accendere dei lumi di olio di foca sui quali asciugare gli abiti di pelle di renna. È molto interessante questo fatto: un po’ prima che si faccia notte, se sei un Inuit devi fermarti e costruire per forza un igloo, perché non puoi dormire all’aperto, sennò muori. Certo, in questo caso l’opposizione è estrema, ma vero è che ne abbiamo sempre bisogno.
N.C. Tutte queste teorie sono l’effetto della passione divorante per l’architettura?
F.P. Sì e no. Sono domande che mi sono posto a prescindere dall’essere architetto o meno, infatti le ho applicate piuttosto poco e male, forse perché non ho avuto modo di farlo con continuità. Ho progettato e costruito muri senza coperture, la cui funzione era unicamente quella di essere dei diaframmi, servivano solamente a dare la sensazione di stare dentro. Alla fine, molto banalmente, se individuo un precinto di riferimento, io sono sicuro al 100% che tu o sei dentro o sei fuori di quel posto, seguendo il discorso di De Dominicis. È una cosa banale e profonda allo stesso tempo.
N.C.: Però chi decide dove tracciare il limite e come farlo è l’architetto…
F.P.: Il problema del limite è fondamentale. Questi ragionamenti e queste teorie mi sono molto piaciute e hanno ancora corso nel mio serbatoio, diciamo così, mentale. Tuttavia, hanno poco a che fare con la scrittura. O forse no.
N.C.: La fase della progettazione è forse la più importante in architettura, è anche quella in cui la soggettività dell’architetto emerge maggiormente. Quanto conta, invece, nella scrittura? C’è stata progettualità prima di scrivere i romanzi?
F.P.: Un’idea architettonica del romanzo ce l’ho avuta con La vita in tempo di pace, quando ho dovuto organizzare una serie di materiali che avevo scritto e con cui volevo costruire il libro. Quindi sì, la progettualità c’è stata ma a posteriori. Mi ha aiutato la metafora – un po’ pretenziosa forse, però mi è servita – del tempio dorico, una forma architettonica per me molto interessante, quasi sacra. Sulla base di questa idea ho organizzato il libro e laddove mancava qualche elemento fondamentale me lo sono costruito appositamente. Fondamentalmente [inizia a disegnare su un foglio di carta, N.d.A.] si tratta di un basamento sul quale poggiano otto (o nove?) colonne. Nei templi le colonne costituiscono la struttura portante e sono sempre in numero pari. Infatti, mi ero proposto di farle pari, ma forse sono nove. Ciascuna colonna è un capitolo a ritroso, gli spazi vuoti sono invece le descrizioni del presente che via via ci sono nel libro. Questa parte qua [il basamento, N.d.A.] non mi ricordo più che cos’è e non mi ricordo più che cos’è il coronamento, cioè il timpano, che però credo fosse la fine del libro. C’era, quindi, un movimento in verticale e un movimento strutturale in orizzontale. Detto così, mi rendo conto che non ha molto senso.
N.C.: Per quale motivo hai pensato di strutturare in questo modo il romanzo?
F.P.: Non avendo una formazione letteraria, se non grazie alle letture di piacere che, come si può vedere, non sono pochissime [quasi tutte le pareti dell’appartamento, infatti, sono arredate con librerie alte fino al soffitto, N.d.A.], non avendo una formazione letteraria, dicevo, non avevo neanche un’idea strutturale di come si costruisce un romanzo. Perciò me la sono dovuta prendere dall’architettura, e neanche dall’architettura moderna, ma dall’architettura antica. In quel primo romanzo c’è un’idea un po’ formalistica della struttura, che poi è una struttura a ritroso. Non poteva che essere così, ma non mi chiedere il perché, è passato troppo tempo.
N.C.: Credi che le fascinazioni estetiche e strutturali per il tempio dorico abbiano agito inconsciamente anche sulla fase di scrittura del romanzo?
F.P.: No, assolutamente no, come dicevo è stata una cosa a posteriori. Quest’idea è nata quando ho deciso di mettere insieme porzioni di testo che avevo scritto in precedenza. Dopodiché, quando già avevo in mente la struttura che volevo dare al romanzo, mi sono accorto che avevo bisogno di una colonna in più e che uno spazio non era definito. Per cui, visto che a Roma non riuscivo a scrivere, sono andato appositamente in Grecia, mi sono preso una stanza su un’isola e lì in pochissimo tempo ho scritto tutto il capitolo sul Sessantotto. Per farlo mi sono basato anche sulle raccolte di testi politici scritti dagli studenti del Movimento, che avevo conservato e che mi erano sembrati incredibilmente lucidi. Quel materiale mi è servito anche per ricordare. Ovviamente il Sessantotto l’avevo fatto: avevo 23 anni a quell’epoca e mi ero trovato pienamente coinvolto. È stato un momento di formazione molto importante che mi ha cambiato completamente la vita, anche quella successiva, e il modo di pensare.
N.C.: Agganciandomi a quest’ultimo discorso mi piacerebbe fare un’incursione sul versante politico del Pecoraro scrittore.
F.P.: Questa è certamente una caratteristica dei novecenteschi, della nostra formazione e della nostra vita, che era molto più impregnata di politica di quanto non lo sia adesso. Vivevamo nelle quattro culture: non c’era una realtà, c’erano quattro realtà, ciascuna filtrata da uno dei sistemi ideologici che in quel momento formavano quello general-democratico. C’era la cultura liberale, quella cattolica – perlomeno in Italia –, quella socialcomunista e quella fascista, che comunque persisteva. Queste quattro costruivano tutti i giorni un’interpretazione della realtà. Se succedeva una qualsiasi cosa e tu compravi «Paese Sera», per esempio, quello che leggevi su quel qualcosa era comunque una interpretazione di quel partito o vicina al partito. Questo valeva per tutti i giornali, anche per i giornali cosiddetti indipendenti. Erano tutti ideologizzati e anche oggi è così, non si vive senza ideologie. Quindi sì, la politica dai vent’anni in poi è stata importante, anche perché prima ero non dico un animale apolitico, ma non mi ero mai realmente interessato alla politica. Mio padre diceva di essere liberale, ma più che altro era un fascista e io ero un liberal-fascista come lui quando sono entrato all’università. Lì piano piano mi hanno capovolto la visione delle cose. Non so come dire, è stato un percorso molto complicato, da un lato ho cominciato a leggere saggi e dall’altro ho assorbito un clima. Non dimenticherò mai i compagni di allora, qualsiasi cosa siano diventati in seguito.
N.C.: Torniamo adesso all’intersezione tra architettura e scrittura: nel 2008, compare su Tash-blog un post in cui riporti il seguente passo di Giorgio Grassi, tratto da Una vita da architetto:
F.P.: La posizione di Grassi è una posizione estrema e tuttavia produce dell’architettura molto interessante. Sostiene la necessità della forma, ma il suo non è funzionalismo, è una cosa diversa: è il rifiuto della forma a priori. Come a tutti quelli della mia generazione, anche a me a quei tempi piaceva molto Hemingway perché aveva questa essenzialità, apparentemente non c’era nessuna aggiunta a ciò che serviva di dire e al modo di dirlo. Ultimamente ho letto per la prima volta The Sun Also Rises (Fiesta)La posizione di Grassi è una posizione estrema e tuttavia produce dell’architettura molto interessante. Sostiene la necessità della forma, ma il suo non è funzionalismo, è una cosa diversa: è il rifiuto della forma a priori. Come a tutti quelli della mia generazione, anche a me a quei tempi piaceva molto Hemingway perché aveva questa essenzialità, apparentemente non c’era nessuna aggiunta a ciò che serviva di dire e al modo di dirlo. Ultimamente ho letto per la prima volta The Sun Also Rises (Fiesta) di Hemingway e sono rimasto sbalordito dalla sua bellezza: riuscire a non far succedere nulla e contemporaneamente a farti stare attaccato alla pagina. Hemingway sarebbe il caso di leggerlo, soprattutto i racconti. Come dice Edmund Wilson, «Hemingway non è il più grande scrittore del Novecento, ma è il più importante, perché è quello che ha influenzato più scrittori».
Quello che io volevo (e forse voglio ancora, anche se non ne sono così sicuro) era trasferire concettualmente la triade vitruviana nella costruzione del testo. Un testo deve avere utilitas, firmitas e venustas. L’utilitas è il contenuto, perché un testo deve avere una qualche solida ragione d’essere, anche nel non volere un contenutolo. La firmitas è il costrutto, deve cioè essere costruito solidamente, qualsiasi cosa questo voglia dire. E infine, deve essere pure bello e intenso da leggere, cioè deve avere delle caratteristiche estetiche, quello che si chiama uno stile. Quest’ultimo aspetto appartiene alla venustas che, forse sì, deriva dall’efficacia delle prime due.
N.C.: Abitare un luogo e da questo essere abitati è un concetto ricorrente nei tuoi discorsi sullo spazio e, soprattutto, sulle città. Se anche in questo caso si provasse a sostituire la parola “testo” alla parola “luogo” il concetto risulterebbe valido? In che modo?
F.P.: Se per abitare s’intende una presenza dentro di sé del testo e una presenza di noi dentro il testo direi senz’altro di sì, però è un concetto astratto. Mentre quella dei luoghi, il fatto che i luoghi ci conformino è quasi un’ovvietà. Una giornalista a Palermo mi ha chiesto di recente in che modo la città costruisce i suoi abitanti e le ho risposto che lo fa nella stessa misura in cui una famiglia, i genitori, influenzano i propri figli. La stessa presenza, la conformazione dei luoghi, la lingua che si parla, il carattere delle persone. Le città hanno un carattere, e Roma ha il suo, un romano è un romano. L’ho verificato più volte in prima persona: quando ho fatto il militare, nel 1972, c’erano ragazzi di tutta Italia e tutti erano aggregati in base alla provenienza, quindi i napoletani con i napoletani, i romani con i romani, eccetera. E si vedeva molto bene il comportamento diverso di ogni gruppo. Quella del militare è stata una delle esperienze più interessanti che ho fatto nella mia vita. Se fossi andato in guerra sarebbe stato ancora meglio, però ci sarebbe stato qualche inconveniente [ride, N.d.A.].
N.C.: E se si estendesse la tua concezione del mondo come «sistema complesso e esteso di camere e stanze»8 al romanzo o, forse ancora meglio, ai racconti? Sarebbe lecito pensare alla raccolta come camera e ai racconti come stanze?
F.P. Guarda, la differenza che c’è tra camera e stanza sta nel Devoto: camera viene dal greco kamàra e vuol dire unità strutturale, stanza viene dal participio latino stans, stantis, quindi ciò che sta, ciò che è radunato in un posto. In questa cucina questo tavolo fa stanza mentre i muri fanno camera. Quello che mi stai chiedendo è se all’interno di un libro ci sono elementi di arredo e elementi strutturali… se vogliamo portare avanti questa metafora possiamo dire di sì, poi però andare a dire quali sono è già un po’ più difficile, credo. Non ci avevo mai pensato.
N.C.: In La vita in tempo di pace distingui forma e conformazione, due concetti di cui avevi già parlato nel tuo blog e in Questa e altre preistorie: l’universo caotico è regnato dalla conformazione e il compito dell’uomo, in qualche modo, è quello di ordinarlo organizzandolo in una forma. Allo stesso modo, si può pensare che la letteratura, che parla di una porzione finita del mondo infinito, sia uno dei modi di dare forma alla conformazione del mondo? Se sì (o se no), in che modo?
F.P.: Quando io dico forma e conformazione mi riferisco all’opposizione tra artificio e natura. Artificio ha una geometria in genere, e questo è anche il motivo per cui mi innervosiscono le architetture di Gehry, Libeskind e Zaha Hadid, perché più che imitare la natura imitano un edificio in stato di demolizione. Quelle di forma e conformazione sono due categorie che mi ero costruito come architetto. Estendendo il discorso alla letteratura, non bisogna dimenticare che in principio fu il verbo. La prima forma, importantissima, è la parola e attraverso quel sistema combinatorio di parole noi riusciamo a organizzare il mondo. La letteratura viene dopo, viene seconda rispetto all’invenzione del linguaggio come produttore di forma. Poi certamente hai ragione, ma più che descrivere la conformazione del mondo la letteratura dà forma alle vicende del mondo.
N.C.: È per questo che ammetti anche parolacce e bestemmie, elementi presenti nelle vicende del mondo ma di rado ammessi nell’idea più alta di letteratura?
F.P.: Sì, solo che le bestemmie mi stanno penalizzando molto. Per esempio, «L’Avvenire» mi aveva sempre fatto delle ottime critiche su tutti i miei libri ma ha ignorato Solo vera è l’estate, in cui ci sono più bestemmie rispetto agli altri. È assurdo, perché sono più che altro dei fonemi, no? Però questo accade da tempo: se ci si pensa, in tutti i libri di Pasolini le parolacce erano puntate – tra l’altro, un tempo tra lettori di Pasolini ci divertivamo a parlare in quella maniera, porc. putt. [ride, N.d.A.] –. Gliel’aveva imposto Garzanti mi pare, adesso i libri di Pasolini credo siano pubblicati senza quei punti.
N.C.: Mi sembra molto interessante quello che hai scritto in un post del 2007: «l’ordine del tessuto di una città, quando c’è ed è percepibile, può paragonarsi alla struttura di un testo e si sa che testo e tessuto hanno lo stesso etimo, textum, intreccio».9
F.P.: Di tessuti si parla apertamente in urbanistica nella contrapposizione, per esempio, tra tessuto e monumento, continuum e unicum. Va tenuto presente che quando noi scriviamo, scriviamo grosso modo secondo tre forme: la forma sintattica, in cui costruiamo e articoliamo un discorso in maniera complessa, la forma paratattica, che consiste nell’elencazione – quella che preferisco – e la forma ipotattica, in cui subordiniamo degli elementi ad altri elementi.
Nella città vale lo stesso. Per esempio, immaginiamo di essere a Roma e di muoverci a piedi da Piazzale Flaminio. Attraversiamo la Porta e entriamo in Piazza del Popolo, dalla quale parte il cosiddetto Tridente di Via del Corso. In questo breve tratto abbiamo provato un’esperienza spaziale intensa e complessa – e anche molto bella secondo me: questo è un esempio di sintassi. Se invece ci si trova al quartiere Prati, lì ci si accorge di come il tessuto urbano sia paratattico, un elenco di isolati, uniformi anche nella scelta neo-rinascimentale del linguaggio architettonico. La gran parte delle città contemporanee sono costruite in questo modo, soprattutto e principalmente la città americana, che è una forma democratica di occupazione del suolo: chi è più bravo e ha più soldi costruisce più alto. In una città come New York non solo non c’è la forma urbana ma non c’è nemmeno la parola per indicare uno spazio che ha una funzione centrale indipendentemente dalla sua forma. In italiano c’è ed è piazza, gli americani hanno circus e square ma non hanno place, place vuol dire luogo.
Per quanto riguarda l’ipotassi, continuando con gli esempi romani basta spostarsi un po’ più a nord del cuore di Prati e arrivare a Piazza Mazzini, dalla quale partono una serie di direttrici che organizzano il tessuto per grandi isolati su strade radiali. Questo genere di pianificazione urbana, quella ipotattica, deriva direttamente dalla Parigi haussmanniana dell’Ottocento francese, che a sua volta ha radici antiche.
Questi sono i contatti tra la disciplina della città e la costruzione del testo. Un’amica criticava questi miei ragionamenti perché diceva che certi passaggi erano troppo meccanici, il che probabilmente è vero. Però per me hanno una certa utilità.
N.C.: Qual è la tua idea di testo, quindi?
F.P.: L’idea del testo che ho è quella di un tappeto. Adesso per esempio sto scrivendo un libro da un’idea orizzontale, non tridimensionale. Qualcuno mi ha chiesto perché scrivessi delle parole con la maiuscola: un po’ perché sono affascinato da Foster Wallace, ma soprattutto perché quelle parole sono monumenti mentali, delle emergenze talmente potenti che alla fine assumono il ruolo di istituzioni vitali, per questo le scrivo in maiuscolo, come fossero monumenti emergenti dal tessuto del testo. Città di Dio l’ho chiamata così perché non mi volevo sentire obbligato alla precisione. Mi spiego meglio: se per esempio uno dei miei personaggi si muove in una città che esiste davvero e che nel romanzo si chiama come nella realtà, so che finirei per seguirlo su Google Street View per assicurarmi che i tragitti che fa siano consequenziali e precisamente rispettati (come è successo per Edimburgo, nel capitolo centrale di La vita in tempo di pace). Per evitare di rimanere ancorato a questa mia fissazione ho deciso di dare a Roma un nome convenzionale, lo stesso che aveva già usato Pasolini in Una vita violenta (Notte nella Città di Dio, appunto). Sono rimasto molto impressionato da quel suo modo di chiamare Roma, ancora adesso se lo pronuncio mi viene da piangere.
N.C.: È la seconda volta che lo ricordi in modo appassionato. Qual è stata l’importanza di Pasolini nella tua vita?
F.P.: Lessi per la prima volta Pasolini a quindici anni, cominciai da Una vita violenta. In quel momento nella mia famiglia e tra quelli che conoscevo ero l’unico a leggere un libro del genere. Io ero nato in un buon quartiere di Roma, figlio di piccolo-borghesi in ascesa, sostanzialmente ero un privilegiato. Pasolini è stato importante perché mi ha fatto conoscere delle realtà di Roma che non sapevo esistessero, le ho conosciute attraverso la letteratura e il cinema. È stato interessante anche per il modo in cui scriveva, cioè in un dialetto romano adottato dall’esterno, da chi non è di Roma.
Ricordo ancora il giorno della sua morte, mi sembra che fosse persino un giorno di festa. Mentre andavo in studio incontrai un amico che lavorava nello studio di fronte al mio. Mi disse: «Hai visto che hanno ammazzato er pàsolo?» Noi lo chiamavamo così, er pàsolo. Per noi Pasolini era un personaggio fondamentale, è uno dei massimi autori di riferimento per quelli della mia generazione. Non ci interessava che avesse parlato in quel modo di Valle Giulia: ci faceva riflettere. Quindi Pasolini, essenzialmente, è stato importante per la mia formazione di uomo. Anzi, di essere umano.
N.C.: Torniamo alla struttura dei romanzi: Lo stradone è organizzato in capitoli-tessere che rappresentano un mosaico della storia ambientale, individuale e collettiva dell’angolo di mondo in cui vive l’io che prende la parola nel libro. Per quali motivi hai deciso di strutturarlo in questo modo?
F.P.: Volevo scrivere un romanzo il cui oggetto fosse il marciapiede davanti casa mia. Avevo scritto un sacco di testo, di critica dei luoghi, chiamiamola così. Avevo, inoltre, una serie di rilevazioni di tipo antropologico che facevo nei locali della zona: mi sedevo e prendevo appunti sui discorsi che si facevano al bar. Adesso non si fanno più i discorsi, stanno tutti con gli occhi sul cellulare. Poi a un certo punto mi sono reso conto che, se avessi voluto scrivere qualcosa sul luogo dove vivevo, avrei dovuto studiarne la storia, cosa che ho fatto e che mi ha portato allo studio anche della storia sociale. Per quest’ultima, ho fatto ricorso alle riviste che avevano condotto indagini sociologiche sul campo, come ad esempio quella di Ferrarotti, «Critica Sociale». Nell’approfondire sorsero tutta una serie di questioni che mi appassionarono molto, come la leggenda della venuta a Roma di Lenin e tutto il dibattito tra lui e Bogdanov sull’empiriocriticismo. È per questo motivo che Lenin è andato a Capri, cioè per cercare di capire che cosa stessero facendo Bogdanov, Gor’kij e Lunačarskij, che nell’isola avevano organizzato una scuola di formazione politica per i rivoluzionari in esilio a seguito della Rivoluzione russa del 1905. Lenin si era reso conto che i tre avevano preso una deriva idealistica. Ma lui aveva tutta un’altra concezione che si chiama, appunto, Leninismo e che consiste nel costruire dei nuclei di partito, molto forti, di rivoluzionari che al momento giusto prendano la testa di una rivolta e la dirigano. Che è poi quello che è successo nel 1917. Nel libro ci sono brani sull’esistenza del protagonista, un personaggio che un po’ coincide con me e un po’ no: per esempio, io non sono mai stato in galera, come non sono mai stato impiegato in un Ministero e non sono mai stato socialista. Come al solito le cose che si scrivono un po’ coincidono con la propria storia e un po’ no.
Lo Stradone nasce quindi da tutta questa serie di frammenti, che a un certo punto non sapevo più come mettere insieme. Lo feci con mia moglie (che fa l’editor di mestiere), mi diede un importante aiuto: ho delle fotografie di lei sul letto mentre provava a organizzare il testo, era sommersa da questi mucchietti di fogli che man mano isolavamo prima di metterli insieme.
N.C.: Quindi viene meno l’idea di struttura che c’era, invece, ne La vita in tempo di pace?
F.P.: Completamente.
N.C.: E per Solo vera è l’estate com’è andata?
F.P.: Solo vera è l’estate per me è un libro molto particolare: ci ho messo dieci anni a scriverlo. Iniziai a pensarci subito dopo l’uscita di La vita in tempo di pace e per molto tempo è rimasto dormiente. È particolare perché decisi di scrivere un romanzo che non fosse il risultato dell’aggregazione di brani e materiali elaborati separatamente, ma di un testo sul quale avrei lavorato dall’inizio, sarei andato avanti a scrivere e avrei smesso una volta terminato. Avevo questa vaga idea di tre ragazzi che partono da Roma con il caldo e se ne vanno a mangiare una cosa al mare, cosa che faceva a volte mio figlio con i suoi amici. Volevo partire dalla costruzione dei personaggi di cui all’inizio non avevo un’idea molto precisa. Ho cominciato quindi a progettarlo piano piano, assegnando, per figurarmi la faccia, un attore a ognuno di loro. Biba non era assolutamente prevista. Ho persino rivisto degli appunti in cui c’è scritto proprio questo: Personaggio femminile che deve essere molto forte, molto determinante, ma non deve comparire mai. Invece a un certo punto Biba compare, mi ha preso la mano. Prima di SVE avevo sempre evitato di scrivere molti dialoghi, perché credevo che non mi riuscisse molto bene (mi era stato anche detto), invece questo libro ne è pieno. Anche sul narratore, sono sempre stato contrario al narratore onnisciente, eppure in questo caso mi serviva che sapesse tutto dei suoi personaggi, altrimenti non ne sarei venuto a capo. Per questo dico che è un libro molto differente dagli altri ed è un libro interamente costruito da me, come era accaduto per Dove credi di andare.
N.C.: Il personaggio di Biba è passato, quindi, dall’essere assente nel progetto al costituire persino il titolo di un capitolo (due in realtà, Biba e Biba & GEF).
F.P.: La cosa è interessante perché per la prima volta mi sono reso conto fino in fondo che quando si scrive libri è bene non sapere esattamente come vanno a finire le cose, non sapere esattamente ciò che sono. Perlomeno questo vale per me. Quindi non so neanche bene chi abbia scritto SVE: è il problema che ho con lo sdoppiamento del me scrivente e del me che invece fa tutte le altre cose. Quando scrivo vado un po’ in trance.
N.C.: Il titolo è una citazione del primo verso dell’omonima poesia di Sereni, tratta da Diario d’Algeria (1947). Come mai?
F.P.: Sì, è una citazione. Sto appresso a quel titolo da anni, volevo dare quel titolo anche a La vita in tempo di pace. Cercavo da tempo di imporlo all’editor e non sono mai riuscito. Ma questa volta sì, anche perché l’altra ipotesi era Un altro mondo è impossibile, il rovesciamento dello slogan del G8 di Genova «Un altro mondo è possibile». È un titolo certamente pertinente, ma che non mi piaceva molto.
N.C.: Hai dei particolari interessi per Sereni?
F.P.: In realtà no. Ho in casa le sue poesie ma devo ancora finirle. Ci sono molte cose che mi propongo di leggere e di fare, ma che poi non faccio, sono un procrastinatore.
N.C.: Come sei arrivato a pubblicare Dove credi di andare, il tuo primo libro?
F.P.: È successo anche questo per caso. Silvia Bortoli, che lavorava come traduttrice dal tedesco per Mondadori, leggeva il mio blog. A un certo punto mi ha scritto per dirmi che le piaceva come scrivevo e per chiedermi di mandarle altri pezzi in modo da provare a vedere se potevano essere pubblicabili. Io per fortuna avevo già altro materiale, dei racconti che avevo scritto in una situazione molto difficile della mia vita in cui ho subito mobbing nel mio ufficio. Senza entrare nel merito di questa vicenda, mi sono trovato a lavorare in una stanza a Villa Borghese, non c’era da timbrare il badge, non era insieme ad altri uffici. Era una stanza singola, separata da altri edifici, all’esterno, avevo persino la chiave. C’erano dei gechi, il telefono taceva tutto il giorno, ma c’era un computer su cui mi misi a scrivere racconti per un anno o forse due, fino a quando non riuscii (quasi) a recuperare la mia posizione a lavoro. Questi racconti li ho sistemati e mandati a questa mia amica (cioè stampati e portati a Napoli, dove a quel tempo abitava). Ne parlammo e capimmo che mancava qualche racconto per rendere la raccolta un pochino più corposa. Dopo di che lei scrisse una mail al direttore della narrativa italiana di Mondadori: mi ha telefonato quasi subito, dicendo di voler pubblicare il libro… mai più successo! [ride, N.d.A.] La vita in tempo di pace ci ha messo un anno e mezzo per essere accettato.
N.C.: Il tuo primo libro di poesie è uscito nel 2012,10 ma già nel blog avevi pubblicato dei versi. Questo fa pensare che un’inclinazione per la poesia esista da molto tempo e forse sia stata uno dei primi modi di avvicinamento alla scrittura. Quando hai iniziato a scrivere versi? Come concepisci la poesia?
F.P.: L’innesco della poesia per me è stato, a parte la lettura di molto precedente di Le ceneri di Gramsci di Pasolini, quella di Sandro Penna. Sandro Penna mi sembrava un miracolo e mi sembra ancora un miracolo. Tuttavia, la sua è una poesia che puoi leggere una, due, cinque volte e basta, perché dopo un po’ non ti arriva più, come se si scaricasse. Questo capita anche con molti artisti visivi. Per esempio, un tempo andavo pazzo per i quadri di Afro, mentre adesso meno. Sandro Penna mi piace per il linguaggio naturale e per il senso apparentemente evidente. Questa cosa era per me fondamentale, a quel tempo la poesia per me doveva essere questo. Ma Penna a parte, la poesia per me nasceva da una condizione esistenziale molto difficile che ho vissi per cinque anni, da quando cioè mi separai da colei che allora era mia moglie. Vivevo in uno stato quasi di miseria, passavo molte notti senza sapere che fare e mi sono messo a scrivere versi. Praticamente, ho iniziato per istinto, anzi no, per spandere sulla pagina la mia condizione mentale di allora. A quel tempo – parliamo del 1981, credo – ero in contatto con un gruppo di poeti più giovani di me che aveva una rivista chiamata «Oceano Atlantico» (il motivo del nome è che abitavano all’EUR, in Viale Oceano Atlantico). All’interno dei pochi numeri che la rivista pubblicò sono uscite tre mie poesie. Nel 1985 vivevo con una ragazza che aveva da poco comprato un computer. Ho cominciato a usarlo e a trascrivere le poesie scritte a mano nei primi anni Ottanta attraverso uno dei primi programmi di scrittura Microsoft. Era fantastico. Per mezzo della poesia ho avuto così il primo rapporto con la scrittura al PC. Da lì ho cominciato a produrre prosa, ma è passato molto tempo prima di fare qualcosa di strutturato. La scrittura me l’hanno facilitata soprattutto il blog che avevo allora e i vari blog di letteratura cui partecipavo.
N.C.: Nella tua prosa ci sono dei filoni tematici il cui seme si intravede già in Primordio vertebrale, la tua prima raccolta di poesie. L’impressione è che il verso sia stato quasi il modo di fermare un’intuizione, un’immagine abbozzata, come lo schizzo preparatorio di un disegno futuro. È così?
F.P.: Ci sono temi, nei miei versi, che ritornano anche nella prosa. Temi che ritornano anche nei miei disegni, almeno in quelli figurativi. Uno di questi è l’adorazione dell’acqua, la totale adorazione dell’acqua e l’innamoramento quasi maniacale dell’isola [si riferisce all’isola greca nella quale è solito recarsi, N.d.A.] e delle isole in generale. Sì, alcune mie ossessioni si vedono bene già nella poesia, però è tanto che non prendo in mano quel libro. Fatico a rileggerlo, perché contiene cose per me ancora toccanti. Come ho detto, le scrivevo in uno stato emozionale molto alterato, che però nella scrittura cercavo di freddare il più possibile. Ma avendole scritte nei primi anni Ottanta, mi ritorna in mente anche il mio clima interiore di quegli anni. A quel tempo, ovviamente, non sapevo che avrei sviluppato testi in prosa.
N.C.: Stai scrivendo poesie?
F.P.: Ho cominciato a scrivere una specie di poemetto, che avevo intenzione di pubblicare, ma mi sono fermato. Per ora si intitola Mentre fallivo, probabilmente sarà inglobato in una prosa lunga su cui sto lavorando. Racconta le tappe di quello che considero il mio fallimento. Per me la letteratura è un ripiego, mi considero un architetto fallito che fa lo scrittore per caso, ma che come scrittore non sa bene quello che fa. Quando lavoravo a un progetto sapevo esattamente quello che stavo facendo. Avevo studiato a fondo la disciplina. Se mi metti davanti un edificio, molto probabilmente so di che si tratta, sia dal punto di vista storico che da quello linguistico. Cioè in linea di massima capisco quali problemi affronta e cerca di risolvere. Un testo per me non è la stessa cosa. Avevo assegnato la ragione della mia vita all’architettura – il che naturalmente era una cazzata –, a quell’epoca ero bravo a disegnare: ce n’erano molti più bravi di me, però insomma me la cavavo. Tuttavia, se calcolo la quantità di energie che ci ho messo rispetto a quello che ho ricevuto dalla disciplina, ne risulta un bilancio francamente piuttosto negativo. E questo fallimento l’avevo cominciato a scrivere, ne avevo anche letto due o tre pagine durante una lettura collettiva di testi in corso di elaborazione, che si tenne l’altr’anno alla libreria Tomo di Roma.
Ho scritto anche molta altra poesia, ma non-lirica, diciamo, più brutale, arida, volutamente legnosa, auto-critica, interdetta, illeggibile. Non so bene, ho una cartella che si chiama “versi”, ci butto dentro la roba che scrivo e poi me la dimentico. Può succedere che, se la vado a riaprire, ci torni a lavorare. Ma in genere non lo faccio. Credo che chi scrive debba lasciarsi un campo segreto, che resti tale, di completa libertà. In un certo senso pubblicare è costrittivo.
1 Su Pecoraro hanno scritto, tra gli altri, Giulio Ferroni, Massimo Raffaeli, Stefano Giovanardi, Linnio Accorroni, Gabriele Pedullà, Filippo La Porta, Guido Mazzoni, Gianluigi Simonetti e Andrea Cortellessa.
2 P. Portoghesi, I nuovi architetti italiani. Le luci del paradiso perduto, a cura di G. Massobrio, Roma-Bari, Laterza, 1985, pp. 58, 369-370.
3 A voler essere più precisi, i blog di Pecoraro sono più di uno. «Tash-blog» è il primo in ordine cronologico e senza dubbio il più rilevante per contenuti e profondità. Sebbene il suo indirizzo originario non sia più disponibile online («tashtego.splinder.com») tuttavia è ancora possibile consultarlo grazie ai molti salvataggi effettuati dalla Wayback Machine di Internet Archive, il più recente dei quali risale al 20 novembre 2011 (ultimo accesso 10/12/2025). Nell’estate del 2012, con la chiusura della piattaforma Splinder, il blog migra su Blogspot cambiando nome in «Tashtego» (ultimo accesso 10/12/2025). Successivamente, sulla piattaforma WordPress.com compare un terzo blog al nome di «TASH-BLOG 2.0» (ultimo accesso 10/12/2025) e contiene soltanto otto post scritti nell’arco di un mese, dal 26 gennaio al 24 febbraio 2021. In questi ambienti virtuali Pecoraro ha pubblicato con costanza contenuti di ogni genere: appunti, riflessioni, disegni scansionati, narrazioni brevi, opinioni, poesie, fotografie, persino trascrizioni di volantini. L’eterogeneità dei materiali e l’abitudine nel produrli, pertanto, rende lecito considerare la produzione del blog alla stregua di uno Zibaldone contemporaneo.
4 Le menzioni di Le Corbusier sono numerose e spesso sbrigative, su Louis Khan si veda soprattutto F. Pecoraro, Our architect, in «Tash-blog», 7 giugno 2005 (ultimo accesso 10/12/2025). Di Mies van der Rohe si parla più specificatamente in Id., [Senza titolo], in «Tash-blog», 16 novembre 2009 (ultimo accesso 10/12/2025). Per quanto riguarda Giorgio Grassi, infine, si rimanda a Id., Grassi, Herzog & de Meuron, in «Tash-blog», 28 luglio 2008, e a Id., L’architettura “com’era”, in «Tash-blog», 30 luglio 2008 (ultimo accesso 10/12/2025).
5 Id., Note sulla figurazione dello spazio quotidiano. Casa, in «Controspazio», 1-2, gennaio-aprile 1979, pp. 64-68.
6 G. Grassi, Una vita da architetto, Milano, Franco Angeli, 2008, p. 29.
7 F. Pecoraro, Grassi, Herzog & de Meuron cit.
8 Id., Dove credi di andare, Milano, Mondadori, 2007, p. 14.
9 Id., Forma urbis & forma mentis, in «Tash-blog», 20 aprile 2007 (ultimo accesso 10/12/2025). Il post compare con lo stesso titolo all’interno di Id., Questa e altre preistorie, Firenze, Le Lettere, 2008.
10 Id., Primordio vertebrale, Roma, Ponte Sisto, 2012.