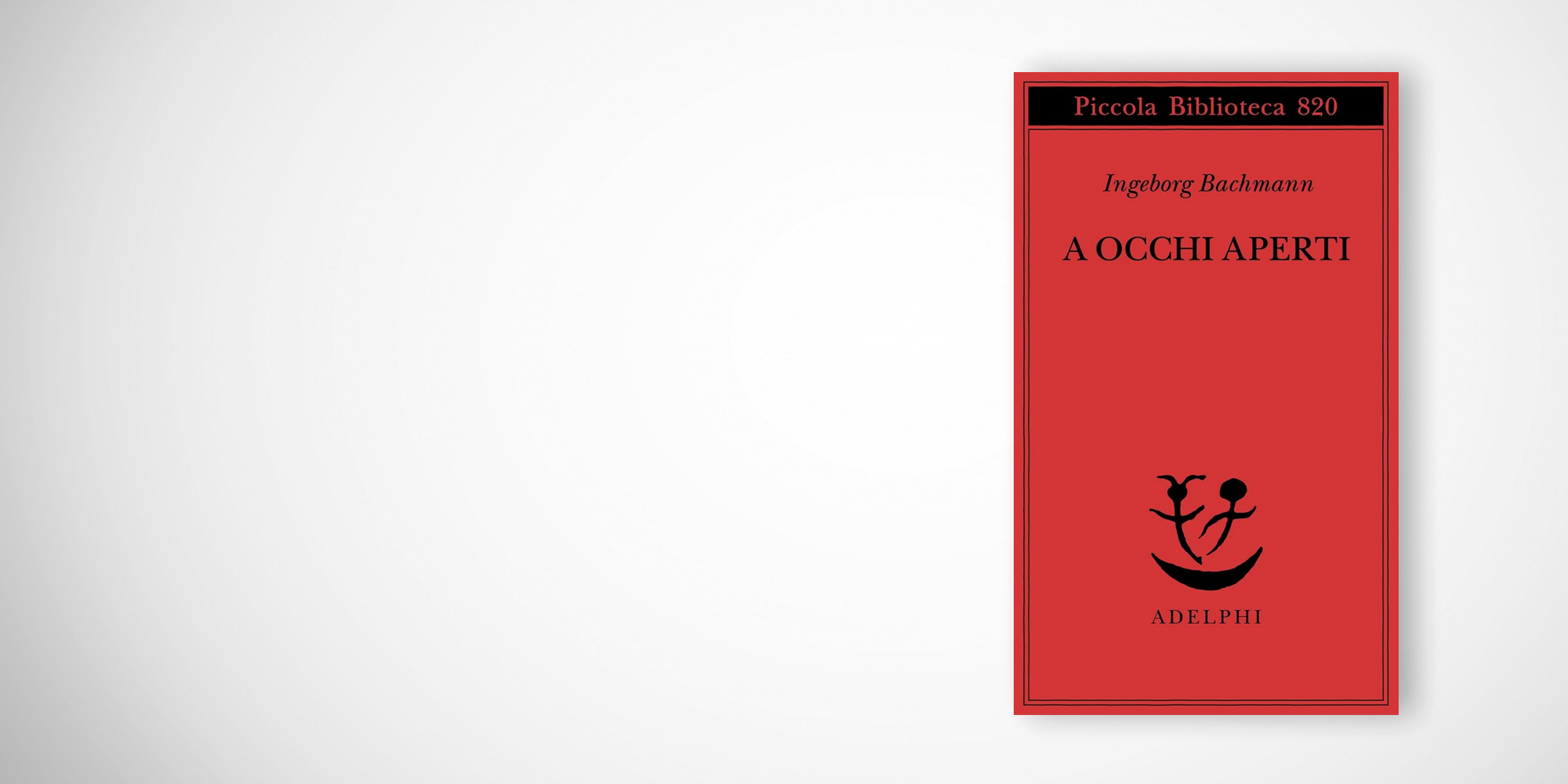
La poesia della Bachmann ha gli occhi aperti, è un luogo senza confini, uno spazio fisico delimitato dal suo respiro poetico, dagli oggetti del proprio sentire. Il tema della poesia è un tema che non abbandona mai la Bachmann.
In questo suo libro A occhi aperti uscito presso l’editore Adelphi e ben curato da Barbara Agnese che a sua volta aveva curato sempre per lo stesso editore il volume Il dicibile e l’indicibile, riunisce testi editi e testi pubblicati postumi. E dunque senza tanti preamboli Ingeborg Bachmann entra nel tema. Lo fa in maniera diretta con una sorprendente sensibilità intesa a capire cosa il tal argomento la può coinvolgere nella costruzione del suo pensiero creativo. Quando furono pubblicate le Lezioni di Francoforte, Letteratura come utopia ciò che colpì è come la Bachmann riusciva a legare il suo momento di poesia con una sorta di esistenziale figurazione critica del proprio processo poetico. Una frase detta in quella occasione è rimasta impigliata nella memoria e più volte è stata ripetuta: «Una poesia che dovrà essere affilata di conoscenza e amara di nostalgia se vorrà scuotere l’uomo dal suo sonno, dormiamo, infatti, dormiamo per paura di dover percepire il mondo intorno a noi».
Facendo un confronto con un analogo caso poetico che si esprime attraverso una peculiare soggettività poetica in un temperamento infuocato reclamante una posizione di coraggiosa audacia nello scrivere versi, si può fare il nome di Sylvia Plath a cui è dedicato uno scritto non positivo da parte della Bachmann sul romanzo della Plath La campana di vetro. Rimangono sorprendenti nella scrittura poetica di Sylvia Plath gli anni dal 1961 fino al 1963 (l’anno del suicidio) per la qualità estrema della sua arte poetica, tutta proiettata, specie fin dalle prime ore del mattino, l’ora felice della sua scrittura, a inalveare dentro al suo tessuto emotivo una parola germinante di poesia. In più, se questo paragone può reggere con la Plath, la Bachmann raccoglie la sua acuminata modernità del proprio sentire nella percezione critica.
Il suo stare ad occhi aperti, segna un assiduo passaggio metaforico, la poesia, e non metaforico, la percussione critica, tra il dire le cose in poesia e il dire interpretando la scrittura di altri scrittori e filosofi come Thomas Bernhard e Ludwig Wittgenstein. Quando la Bachmann scrive di altri scrittori come nel caso dei racconti dell’esordiente Heinrich Böll registra un un proprio portamento critico, penetrante quanto intransitivo. Scrive ciò che pensa senza tante mediazioni. Mette le cose letterarie a giudizio dentro a una propria situazione esistenziale mai disgiunta dalla sua vera identità: «Esisto solo quando scrivo». E se, come scrive la Bachmann, riguardo al Treno era in orario di Böll: «la bellezza della vita può compiersi soltanto quando la vita trova il suo compimento». E’ un tema che non abbandona mai Böll «e dal quale non riesce a liberarsi». Estrema e formidale è la capacità di concentrazione (di raccoglimento) della Bachmann di chinarsi sul testo letterario. La prosa direi inflessibile della Bachmann scava nella tana della poesia come unico tema. Lo si avvisa nella sua mente che scrive. «La poesia ha poche occasioni felici». È una frase tratta da una delle cose più belle e appaganti per chi ama la poesia da questo libro.
È molto difficile dare una sequenza degli scritti migliori, ma segnaliamo: Perché le poesie (un brano di poetica da imparare a memoria), Le meraviglie della musica (bellissimo al suo interno il paragrafo intitolato Un foglio per Mozart), Ungaretti («si deve essere a casa nella propria lingua per poter trasportare una poesia da una riva all’altra», la Bachmann aveva fatto traduzioni da Ungaretti, Gedichte, Suhrkamp, 1961), a quello dedicato a Wittgenstein richiamando Heidegger (la Bachmann riflette su Cos’é la metafisica?) e Carnap come suo reagente avversario. Riconducibili a questi scritti e alla scrittura di Ingeborg Bachmann alcuni fatti biografici però vanno ricordati. L’annessione dell’Austria (era nata la Bachmann nel 1926 a Klagenfurt), la Seconda Guerra Mondiale alle spalle, gli studi universitari, la tesi di laurea in filosofia su Martin Heidegger, la frequentazione del Gruppo 47 a Niendorf nel 1952 sul Baltico, l’incontro con Paul Celan (e la sua poesia), ed è solo l’inizio della sua avventura poetica letteraria.
Ricorre in Invocazione dell’Orsa Maggiore la parola Atem, ‘respiro’ («zahl ich die Spuren, und des Wolken», «conto le tracce e le nuvole del respiro»); Atem nella poesia della Bachmann, soffio vitale, come ricorre in Celan Atem, respiro come svolta indimenticabile della poesia. Una poesia quella Bachmann (ci riferiamo a quelle pubblicate in italiano: alla raccolta Poesie a cura di Maria Teresa Mandalari e all’Invocazione dell’Orsa Maggiore nella versione di Luigi Reitani) che ci è apparsa da subito evocativa intesa a comunicare una situazione reale, poesia inquieta, poesia finemente metaforica in una sorta di accelerazione di sensibilità poetica e dentro a una precisa condizione esistenziale (la poesia assorbe un momento della vita e della storia). E come di trapasso lirico tra Rilke e Stefan George in un futuro della lingua che non può più parlare con la loro lingua del passato. Dovrà essere la lingua della poesia arditamente polimelodica (Invocazione dell’Orsa Maggiore avrebbe dovuto intitolarsi Luoghi e Armonie) di contro alla lingua monologica di Benn.
Quando si leggono le sue poesie attraversiamo una ricchezza compositiva. La poesia per la Bachmann è termine esclusivo, impellente tensione, condizione ipersensibile. Della poesia come nuova forma di vita nel rapporto costante tra esistenza e linguaggio. Anzi per Ingeborg l’espressione artistica non è mai estranea a risonanze come può essere l’evento della musica che soggiace in lei come un torrente dentro a un terreno fertile nel canto armonico del Lied. In Musica e poesia possiamo leggere: «Una frase di Hölderlin dice che lo spirito può esprimersi soltanto ritmicamente». Le parole armoniche sono segnali sonori del ricordo dal luogo effettivo (tangibile) della poesia. La lingua della poesia dunque affiora da una terra desolata (qui si ascolta malinconia, qui si ascolta inquietudine), in modo improvviso, in un loro spazio concreto e definito; parole argomentanti, intuitive e come fresche dei colori di una natura primordiale. Il soggetto scrivente si trova nel dentro della poesia, c’è in quel luogo come una provenienza specifica della poesia stessa. La poesia è un evento dinamico, un fluire da un Land del suo cuore.
Nella poesia della Bachmann in un epicentro frantumato ricostruito per istanti di immagini, esiste un sentimento dell’abbandono e dell’essere per sempre abbandonati dalle persone come dai luoghi. Si riascolta la fisonomia estatica delle stagioni, lo sguardo furente di Hölderlin; un certo declamare i fenomeni della natura riportati in una estensione interiore mai statica. Relitti-poesie di un cosmo più grande, primi organismi di sopravvivenza. E da questo planetario fatto di turbata solitudine in tutta la sua evidente drammaticità c’è un luogo della poesia e c’è un luogo in cui la poesia resta la stella polare argomentante del suo itinerario conoscitivo. Il suo planetario contiene molte stelle risplendenti di urgenze e meditazioni. Rilkiana rimane nella Bachmann la sua fiducia verso l’espressione artistica attraverso l’impronta dei propri sentimenti non magniloquenti. Con Trakl la Bachmann non dimentica l’effetto drammatico di una poesia come tragedia, di espressionismo interiore. Ma, soprattutto, ed è ciò che conta, la poesia ha il potere di comunicare queste cose interiori. Rompendo consuetudini legate alla tradizione poetica tedesca la Bachmann, non dimentica le ragioni della tradizione rimettendole in movimento in un adesso fecondo nei nomi, ad esempio, di Goethe e Novalis. Tutti questi poeti però non possono più incarnare modelli di scrittura ideale, anzi dal loro passato rimandano a dei problemi urgenti di poetica contemporanea.
La poesia è sempre romantica? Viene da chiedersi quando si rilegge un passo come questo da Schlegel: «La poesia romantica è una poesia universale progressiva. Suo fine non è solo riunire nuovamente tutti i distinti generi della poesia e mettere a contatto la poesia con la filosofia e la retorica. Vuole, e anche deve, ora mescolare ora fondere poesia e prosa, genialità e critica, poesia d’arte e poesia naturale, rendere viva e sociale la poesia e far poetiche la vita e la società». Parole che saltano in mente leggendo A occhi aperti. Perché questa posizione romantica significa un continuo respingere l’oscurità attraverso la possibiltà della scrittura.
Ciò che non può non essere detto in Wittgenstein fluisce in una condizione mistica del dicibile. La Bachmann trasporta la tensione della lingua per mezzo della poesia oltre una proposizione logica delle cose che si possono dire, oltre i limiti dello stesso linguaggio. C’è un dualismo tra positivismo e poesia che la giovane Bachmann (lo si avverte nel saggio qui sul concetto di linguaggio in Wittgenstein) riconosce nella logica aforistica di Wittgenstein ma che non risolve dalla parte di Wittgenstein. La poesia esce dalla logica delle cose perché è la poesia stessa che fonda le cose. Molto più contrastato, ma vitale crediamo per la sua poesia, è il suo rapporto con Heidegger (la Bachmann mai perdonerà ad Heidegger la sua adesione al nazismo). Heidegger colloca la poesia in una situazione esistenziale in cui il pensare poesia è un momento indispensabile del volgere poetico che è un evento che istituisce immagini. La poesia della Bachmann, la sua inesausta ricerca – anche Paul Celan rientra in questa posizione orientativa del fare poesia-, deve qualcosa a questa condizione mentale come spinta filosofica nel pensare poesia, forse non così lontana da quella esposta dal nostro Leopardi. Nel pensiero di una lingua che possa toccare luoghi utopici e se non altro almeno inesplorati. L’utopia per la poesia è una direzione per un nuovo linguaggio e una nuova forma di vita.