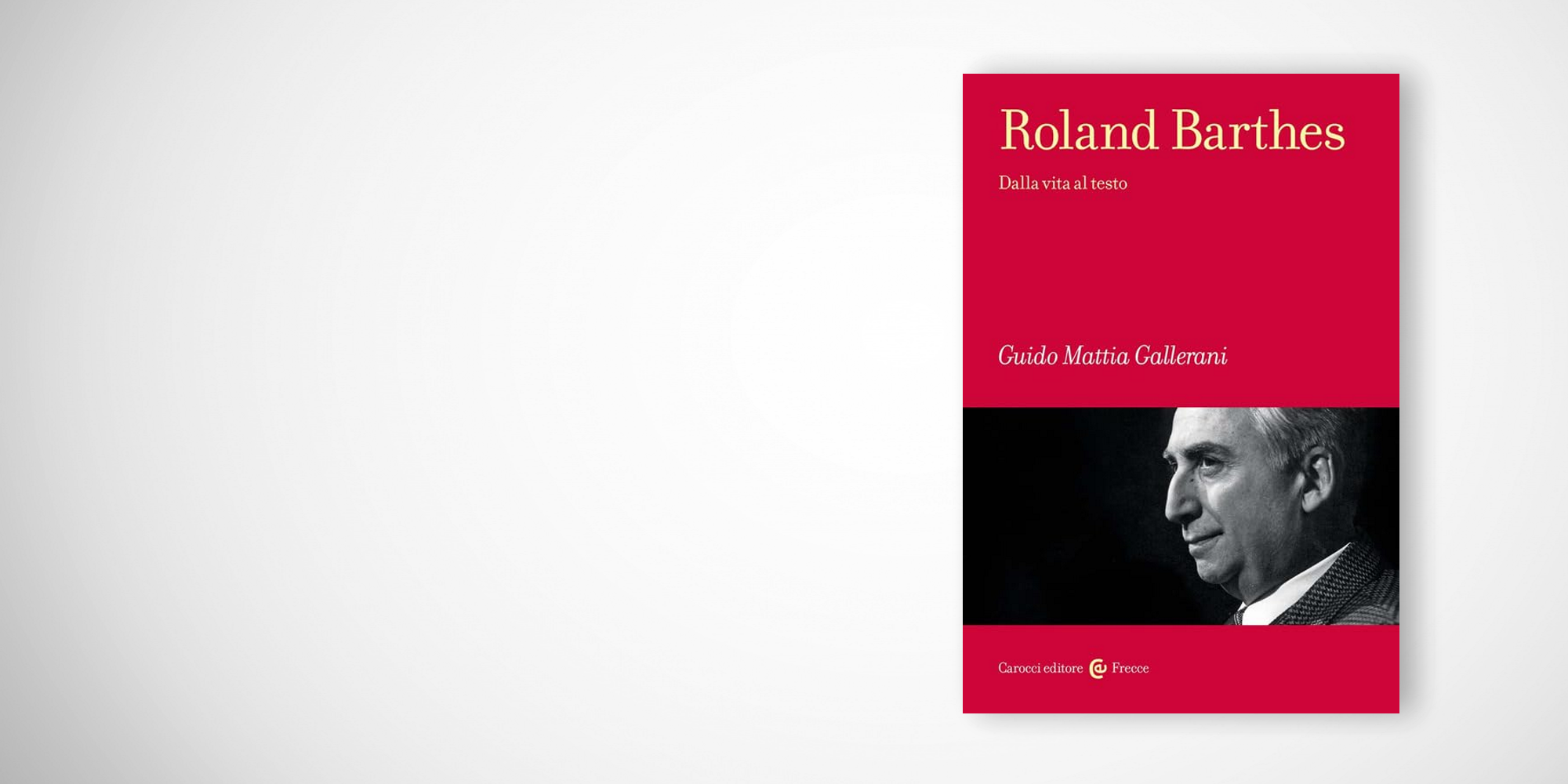
Cimentarsi nella stesura di un profilo biografico e delle opere di Barthes è un’operazione coraggiosa e rischiosa per via del necessario confronto con chi l’ha tentata prima, e in particolare con un precedente imprescindibile come il Roland Barthes di Tiphaine Samoyault (2015),1 e perché la materia scelta è tra le più difficili da riassumere. Questo per almeno tre ragioni: per l’eccezionalità di una bibliografia secondaria in cui, accanto a moltissimi altri studi, non possono essere ignorati gli apporti di allievi e amici come Antoine Compagnon, Julia Kristeva, Éric Marty o Philippe Sollers, custodi di una personalità sì estroversa, ma rimasta in parte restia al disvelamento del sé (probabilmente tale anche durante le poche, benché tanto rincorse, sedute psicanalitiche con Lacan); per l’estensione dell’opera di Barthes, che scoraggia operazioni classificatorie, o se non altro le costringe a contemplare eccezioni e sottoinsiemi; e da ultimo per l’irriducibilità di un’inquietudine intellettuale del tutto peculiare, che nella parabola autoriale funge da fil rouge. La produzione di Barthes sfugge infatti al controllo non solo e non tanto per la diversità degli argomenti toccati o per la ricerca a tratti ossessiva di un metodo infine sempre ritenuto insufficiente, ma perché, in un sistema di varianti, l’insoddisfazione e l’angoscia conoscitiva giocano il ruolo delle costanti. Restituirne la complessità rischia di sacrificare la chiarezza espositiva; eluderne o ridurne l’importanza significa offrire, al di là di ogni psicologismo, un’immagine parziale dell’uomo e del critico. L’operazione di Guido Mattia Gallerani, che nel novembre 2024 ha pubblicato con l’editore Carocci Roland Barthes. Dalla vita al testo, tiene conto di tutti questi pericoli riuscendo a volgerli a proprio vantaggio: se sul piano più schiettamente pratico l’agilità del volume (250 pagine in totale, contro le oltre 700 di Samoyault, con cui in ogni caso il dialogo è costante e serrato) offre a lettori e studiosi uno strumento maneggevole, è nelle caratteristiche dell’operazione di sintesi che risiede il principale punto di forza del lavoro.
I cinque capitoli che compongono il libro, preceduti da una breve introduzione e seguiti dalla conclusione, da un apparato bibliografico e da due indici (delle opere di Barthes e dei nomi citati), rispettano l’ordine cronologico, affiancando alla descrizione dei testi degli affondi storici e biografici selezionati in base alla loro rilevanza. Il rigore della scelta, che non cede al fascino delle indiscrezioni, ha sia il pregio di non saccheggiare la vita privata dell’autore sia il merito di instaurare un confronto, ben più proficuo, con il mondo intellettuale francese del periodo di volta in volta esaminato. In linea con queste coordinate, la restituzione puntuale dei cambi di rotta, dei ripensamenti, del policentrismo degli interessi è portata avanti da Gallerani con fermezza e criterio sin dal primo capitolo, dove vengono ripercorsi gli anni giovanili di Barthes fino alle prime importanti pubblicazioni. La campionatura di temi e snodi si sofferma su predilezioni (Gide, il teatro antico) e circostanze che, a partire dalla valenza biografica, finiscono sia per inscrivere simbolicamente Barthes nella sfera culturale parigina di quegli anni sia per rivelarne, al confronto, l’eccentricità. È a questa stagione che risale, ad esempio, il rapporto tanto reverenziale quanto conflittuale con una figura d’altro canto molto ingombrante: «modèle» e «contre-modèle»,2 Sartre è per Barthes un maestro e una presenza dalla quale emanciparsi. La speculazione biografica potrebbe spingersi fino a tracciare la diversità degli esiti scaturiti da circostanze condivise, vale a dire la prematura scomparsa della figura paterna (restio alla conservazione indiscriminata della corrispondenza, Barthes ha custodito per tutta la vita le lettere con cui ne era stata annunciata la morte alla madre) e il peso di una salute cagionevole.3 Ma se quest’ultima consentirà a Sartre di rientrare da La Rochelle, frequentare il prestigioso liceo Henri IV e poi l’École Normale Supérieure, per Barthes l’ingresso al Sanatorium des étudiants de France a Saint-Hilaire-du-Touvet nel 1942 darà inizio a un decennio complesso, che gli precluderà sia l’accesso a un’istruzione di alto grado sia la partecipazione attiva alla storia del suo tempo, promuovendo così la percezione di un maturato ritardo e di una forma di estraneità all’impegno e alla militanza diffusi invece tra i coetanei.4 È all’interno di questo quadro che Gallerani colloca la fortunata pubblicazione di Le Degré zéro de l’écriture (1953), ricostruendone approfonditamente i punti di contatto e quelli di distanza dalla riflessione sartriana, e un anno più tardi del Michelet (1954). La lunga gestazione di quest’ultimo aveva consentito a Barthes di parlarne a più riprese anche nella corrispondenza, attualmente quasi del tutto inedita, con Robert David:5 mentre alla confessione privata era stato affidato il volto intimo dell’opera (nel 1945 lo stesso David viene riconosciuto ‘motore’ ed eletto ‘destinatario’ del lavoro),6 sarà proprio a partire dalla percepita somiglianza con una figura a lui simile nell’«aver mancato l’appuntamento decisivo» (Michelet nacque nel 1798, a Rivoluzione francese ormai quasi conclusa) che Barthes svilupperà una visione dei rapporti tra storia collettiva e fatto letterario.7
A questo nodo è dedicato il secondo capitolo del volume di Gallerani, che si apre evidenziando l’irrequietezza, ma pure la precarietà lavorativo-economica, di Barthes. All’inizio del 1954, una volta persa la borsa di ricerca in lessicologia ottenuta nel 1951 grazie a Georges Matoré e intrapresa la strada della sociologia, la partecipazione alla rivista «Théâtre populaire» (fondata nel 1953) diventa tanto un sostentamento economico quanto un campo di riflessione ulteriore. L’opera di Brecht, in particolare, rappresenta per Barthes una sintesi riuscita tra arte e rivoluzione, capace, nel rifiuto di alcuni aspetti tipicamente borghesi e di altrettanti filtri consolidati (il metodo Stanislavskij), di indurre alla riflessione lo spettatore e di mettere la Storia al centro della scena. Al di là di questa parentesi e al netto della solita tendenza centrifuga, gli anni Cinquanta valgono come momento di svolta nella parabola di Barthes perché al loro interno si colloca la pubblicazione di Mythologies (1957). L’opera, di cui Gallerani ripercorre genesi, debiti contratti (in particolare con Saussure) e contenuto, di fatto inaugura l’adesione di Barthes alla semiologia e al suo linguaggio, aprendo il campo a futuri lavori, tra cui quelli di Baudrillard (Le Système des objets esce nel 1968, La Société de consommation nel 1970). La svolta, a fronte della seconda borsa di ricerca persa e delle ritrosie di Lévi-Strauss (che rifiuta di supervisionarne la tesi dottorale), gli vale una collocazione stabile: all’inizio degli anni Sessanta, Barthes è assunto come ricercatore all’École Pratique des Hautes Études, dove ottiene poi la cattedra in Sociologie des signes, symboles et représentations. L’incarico gli viene concesso anche in absentia del titolo di dottore di ricerca, che sarebbe stato invece necessario per proseguire la carriera in istituzioni accademiche tradizionali, come la Sorbonne. Proprio da quest’ultima e in special modo dalla figura di Raymond Picard, si leverà una voce di sdegno per l’impostazione barthesiana, che tra il 1960 e il 1964 si era prima spinta fino alla rilettura dei testi e della biografia di un autore canonico, Racine, per poi sollecitare esplicitamente un rinnovamento accademico (Essais critiques).8 La polemica, che culminerà con la pubblicazione, a stretto giro, da un lato di Nouvelle critique ou nouvelle imposture (1965) e dall’altro di Critique et vérité (1966), finirà per far guadagnare a Barthes il sostegno di personalità riconosciute (ad esempio Deleuze, Lacan, Starobinski); allo stesso tempo, una forma di autorevolezza gli era stata garantita dalla partecipazione a dibattiti à la page (è il caso di quello su Robbe-Grillet e il Nouveau roman) e, dopo la breve esperienza di «Arguments» (1956-1962), dalla co-direzione di «Communications» dal 1961. E mentre nel 1966 Barthes aprirà l’ottavo numero (Recherches sémiologiques: l’analyse structurale du récit) della rivista, che ospiterà indagini fondamentali per lo sviluppo della narratologia, è più o meno alla stessa altezza che il suo avvicinamento allo strutturalismo letterario si caratterizzerà definitivamente per il rifiuto opposto alla possibilità di elevarlo a metodo scientifico, sancendo così una nuova ragione di distanza da Lévi-Strauss: su queste note si apre il terzo capitolo del volume di Gallerani, che delle transizioni di Barthes sonda ragioni e contraddizioni, anche rispetto alla precedente vicinanza a un impianto fortemente storico e marxista. Le pagine successive esaminano invece la parabola semiologica di Barthes, a partire dall’innovatività teorica degli Éléments de sémiologie (1964) fino all’applicazione dell’analisi «a molteplici sistemi di oggetti».9 Proprio lo studio dedicato a uno di questi, la moda (Système de la Mode, 1967), fungerà al contempo da testamento e congedo nei confronti di una disciplina che gli aveva garantito l’ingresso in un’istituzione riconosciuta e a cui tanto aveva lasciato: alle soglie del ’68 (l’anno in cui su «Communications» esce L’Effet de réel), l’indagine sul linguaggio e sulla retorica delle didascalie che accompagnano le fotografie sulle riviste di moda, per quanto retta dalla convinzione che le parole istituzionalizzassero degli schemi sociali, rivelava le ragioni della propria insufficienza. E sebbene le aperture e la fisionomia di Barthes non entusiasmarono gli studenti durante il Sessantotto parigino, per i quali l’interlocutore ideale era ancora una volta Sartre, lo spirito di quella stagione contribuì nondimeno a determinare tre testi di poco successivi, a loro modo spinti a vedere nella pratica letteraria una forma di liberazione dall’ideologia dominante. All’interno del quarto capitolo, accanto ad altri contributi (come L’Empire des signes, 1970), Gallerani rilegge così S/Z (per cui sono state dirimenti le intuizioni di Derrida, Kristeva, Lacan) e Sade, Fourier, Loyola (1971): l’attenta restituzione dei nodi critici delle due opere sottolinea il legame dialettico con il precedente La Mort de l’auteur (che esce per la prima volta nel 1967 in inglese) e con il successivo Le Plaisir du texte (1973), riconoscendo nella maturità dell’evoluzione teoretica l’ombra di un intellettuale sempre più prossimo ad assurgere al ruolo di maître à penser.10
È allora quantomai indicativa la pubblicazione da parte di Seuil, nello stesso 1975, di Le Pacte autobiographique di Philippe Lejeune (già parzialmente edito su «Poétique» nel 1973) e del Roland Barthes par Roland Barthes. La coincidenza, menzionata da Gallerani nelle pagine iniziali del quinto capitolo, dedicato all’ultima parte della vita di un autore ormai canonizzato, ha un valore che va oltre il mero dato di cronaca. In una prospettiva storica, l’iniziativa testimonia la capacità di Barthes di intercettare e manifestare, attraverso le garanzie offerte dal genere letterario (Gallerani parla giustamente di «autofinzione»),11 ansie e bisogni del proprio tempo, anticipando una pratica, ma persino un’urgenza, che circa trent’anni più tardi lo sviluppo tecnologico avrebbe in qualche modo assicurato a tutti. Parallelamente, le strategie messe in atto dall’autore per ridurre la cifra narcisistica di un’impresa ad alto rischio autocelebrativo precorrono eventi, testi e tormenti. L’atmosfera romanzesca, per esempio, dichiara una fascinazione per un ambito diverso da quello prettamente critico.12 Il ricorso alle fotografie familiari, invece, preannuncia La Chambre claire (1980) così come la centralità tematica della figura materna.
Negli anni accademici 1974-1975 e 1975-1976 Barthes tiene il seminario su Le Discours amoureux all’École Pratique des Hautes Études. La riflessione, promossa anche dalla passione per Roland Havas (con cui nell’estate del 1975 Barthes è a Venezia e al Lido)13 e dalla constatazione di un tabù («Renversement historique: ce n’est plus le sexuel qui est indécent, c’est le sentimental»),14 si consolida nell’uscita dei Fragments d’un discours amoureux nel 1977. Sebbene la fortuna editoriale dell’opera non sia ancora tramontata, sono state con ogni probabilità altre le ragioni che hanno reso cruciale quell’anno, che lo stesso Barthes in termini sibillini individua come discrimine per una «vita nova»:15 il 7 gennaio tiene la propria lezione inaugurale al Collège de France, dove nel marzo precedente era stato accolto grazie al sostegno di Jacques Le Goff e all’insistenza di Michel Foucault, che ebbero così un ruolo determinante nel sancirne la definitiva consacrazione; dal 22 al 29 giugno 1977 gli viene dedicato un «colloque» (Prétexte: Roland Barthes) a Cérisy-la-Salle; ma, soprattutto, il 25 ottobre muore la madre Henriette.16 Mentre redige quello che sarà poi pubblicato sotto il titolo di Journal de deuil (Éditions du Seuil/Imec, 2009) Barthes tiene il corso su Le Neutre al Collège de France e si avvicina, nel segno di Proust, al romanzo. Gallerani, che al tema ha dedicato un libro (Roland Barthes e la tentazione del romanzo, Morellini, Milano, 2013), ne riassume efficacemente modi, ambizioni e risultati, interrotti dalla morte il 26 marzo 1980, pochi giorni prima di quella di Sartre (15 aprile). Benché il clamore suscitato dall’evento non sia stato lo stesso (in parte per scelte personali: il primo venne sepolto in forma privata a Urt, accanto alla madre; il secondo a Montparnasse davanti a 50.000 persone), l’eredità di Barthes non è stata meno rilevante. Nella conclusione, Il corpo e l’oblio, Gallerani ne mette in risalto lo spessore e indugia sulle prospettive ancora da sondare, soffermandosi peraltro sulle ragioni della risonanza ottenuta dall’opera in Italia. Ed è se non altro una concessione del caso a quel progetto romanzesco mai decollato che l’ultimo testo scritto di Barthes sia un intervento preparato in vista di una conferenza su Stendhal a Milano.17 Pubblicata postuma su «Tel Quel», la relazione si sarebbe dovuta intitolare On échoue toujours à parler de ce qu’on aime.
Con scrittura chiara ed efficacia discorsiva, Gallerani è riuscito a condensare biografia e produzione di Barthes mantenendo dall’inizio alla fine del volume un equilibrio critico e, cosa non meno importante, narrativo. Senza cedere a facili semplificazioni e senza il timore di confrontarsi direttamente con i testi, le pagine incoraggiano la rilettura di un’opera complessa, costituendo un valido punto di riferimento per gli specialisti così come per chi voglia iniziare ad accostarsi a Barthes.
1 T. Samoyault, Roland Barthes, Paris, Éditions du Seuil, 2015: allo stesso anno, in cui è ricorso il centenario della nascita di Barthes, risale anche l’uscita di Album. Inédits, correspondances et varia, éd. É. Marty, Paris, Éditions du Seuil, 2015. In Roland Barthes. Dalla vita al testo Gallerani rimanda a più riprese al materiale epistolare lì pubblicato.
2 Entrambe le formule in T. Samoyault, Roland Barthes cit., p. 257.
3 Le lettere menzionate si leggono, con una nota introduttiva di Éric Marty, in R. Barthes, Album cit., pp. 21-24 e le riproduzioni che seguono (I-VIII). Sulla riflessione di Barthes a proposito della vicenda e sulle somiglianze con certe confessioni sartriane cfr., in aggiunta, almeno C. Gury, Les Premiers jours de Roland Barthes, précédé de Barthes en Arcadie, Paris, Non Lieu, 2012, pp. 119-124.
4 Anche in questo caso Barthes ha, significativamente, conservato dei documenti epistolari. Presso il Département des manuscrits della Bibliothèque nationale de France, site de Richelieu, sono infatti consultabili nel Fonds Barthes una busta, una cartolina da «Toulouse» e 77 «cartes postales» (tutti i materiali, manoscritti, sono datati 1942) ricevute durante la sua permanenza al Sanatorium des étudiants de France de Saint-Hilaire-du-Touvet, Isère. Tra vari mittenti figurano anche Michel Delacroix (Barthes lo ricorderà come l’unico amore, sebbene in minore, prima di Robert David: cfr. la lettera allo stesso David del 6 dicembre 1945, Fonds Barthes), Madame Delacroix, René Denis, Jean Girodon (il corrispondente più assiduo), Paul-Louis Mignon.
5 Le fotocopie delle numerose lettere di Barthes, non sempre interamente leggibili, sono state fornite da Bertrand Poirot-Delpech (cfr. la nota di Éric Marty in R. Barthes, Album cit., p. 75) e sono ora conservate nel Fonds Barthes della Bibliothèque nationale de France.
6 Si tratta della lettera datata «Jeudi 15 Nov».
7 La citazione si legge in G.M. Gallerani, Roland Barthes cit., p. 43.
8 Ma per lo meno il contratto per l’edizione delle opere di Racine era stato firmato, con Le Club français du livre, già il 26 ottobre 1957. Tra il 1965 e il 1966, Barthes parla a più riprese di Picard anche a Philippe Sollers, arrivando a contrapporre esplicitamente la funzione-Picard a quella Goldmann (le fotocopie delle lettere originali, parte degli Archives Philippe Sollers conservati all’Institut Mémoires de l’édition contemporaine, si trovano a loro volta nel Fonds Barthes).
9 La citazione è in G.M. Gallerani, Roland Barthes cit., p. 104.
10 In questo senso, la Préface a Sade, Fourier, Loyola è già un’anticipazione del saggio del 1973: cfr. R. Barthes, Préface, in Id., Sade, Fourier, Loyola, in Id., Œuvres complètes. Livres, textes, entretiens, Nouvelle édition revue, corrigée et présentée par Éric Marty, Paris, Éditions du Seuil, 2002, 5 voll., III (1968-1971), pp. 699-868: pp. 701-707.
11 G.M. Gallerani, Roland Barthes cit., p. 219.
12 «Ce serait le cas si je pensais avoir dit la vérité sur moi; mais ce n’est pas du tout le cas. J’ai essayé de montrer justement que ce que je voulais faire, c’était de décrire ce que j’appelle un “imaginaire d’écriture”, une façon quasi romanesque de se vivre comme un personnage intellectuel, dans la fiction, dans l’illusion, et nullement dans la vérité»: questi i termini in cui Barthes risponde a Jacques Chancel, che gli aveva chiesto se con il suo Roland Barthes volesse fare il punto dopo che tanto si era scritto su di lui (cfr. R. Barthes, Entretien avec Jacques Chancel (17 février 1975), in Id., Œuvres complètes cit., IV (1972-1976), pp. 887-906: p. 893 e G.M. Gallerani, Roland Barthes cit., p. 174).
13 La notizia si ricava da un quaderno in cui Barthes ha annotato i viaggi intrapresi tra il 1960 e il 1978 (Fonds Barthes). Accanto alle due date veneziane (20-23 giugno e 30 agosto-5 settembre), aggiunge di esserci stato con «RH». È dato supporre che la sigla corrisponda alle iniziali di Roland Havas, menzionato nella stessa maniera anche in altre circostanze, come ad esempio riportato da Tiphaine Samoyault (Roland Barthes cit., p. 621; nella pagina successiva è inoltre ricordato il secondo dei due viaggi veneziani: «Ils font des voyages ensemble, en Suisse fin 1974, à Genève et à Zurich où ils assistent à une représentation de Tosca, à Venise en août 1975»).
14 R. Barthes, Fragments d’un discours amoureux, in Id., Œuvres complètes cit., V (1977-1980), pp. 25-296: pp. 218-219, corsivo nel testo; la citazione è riportata, in traduzione, in G.M. Gallerani, Roland Barthes cit., p. 177.
15 G.M. Gallerani, Roland Barthes cit., pp. 204 per la citazione (corsivo nel testo) e 209 per qualche informazione aggiuntiva sui “tentativi romanzeschi” di Barthes, con particolare riferimento alle pagine preparatorie di un progetto intitolato, per l’appunto, «Vita nova» (sono state pubblicate per la prima volta da Éric Marty nel 1995).
16 A tal proposito si leggano almeno le pp. 15-16 di P. Sollers, L’Amitié de Roland Barthes, Paris, Éditions du Seuil, 2015.
17 Cfr. la nota introduttiva di Éric Marty: R. Barthes, On échoue toujours à parler de ce qu’on aime, in Id., Œuvres complètes cit., V (1977-1980), pp. 906-914: p. 914.