Giacomo Principato Trosso,
«Parole e fumi
qui in Sicilia levo»
Stefania La Bionda
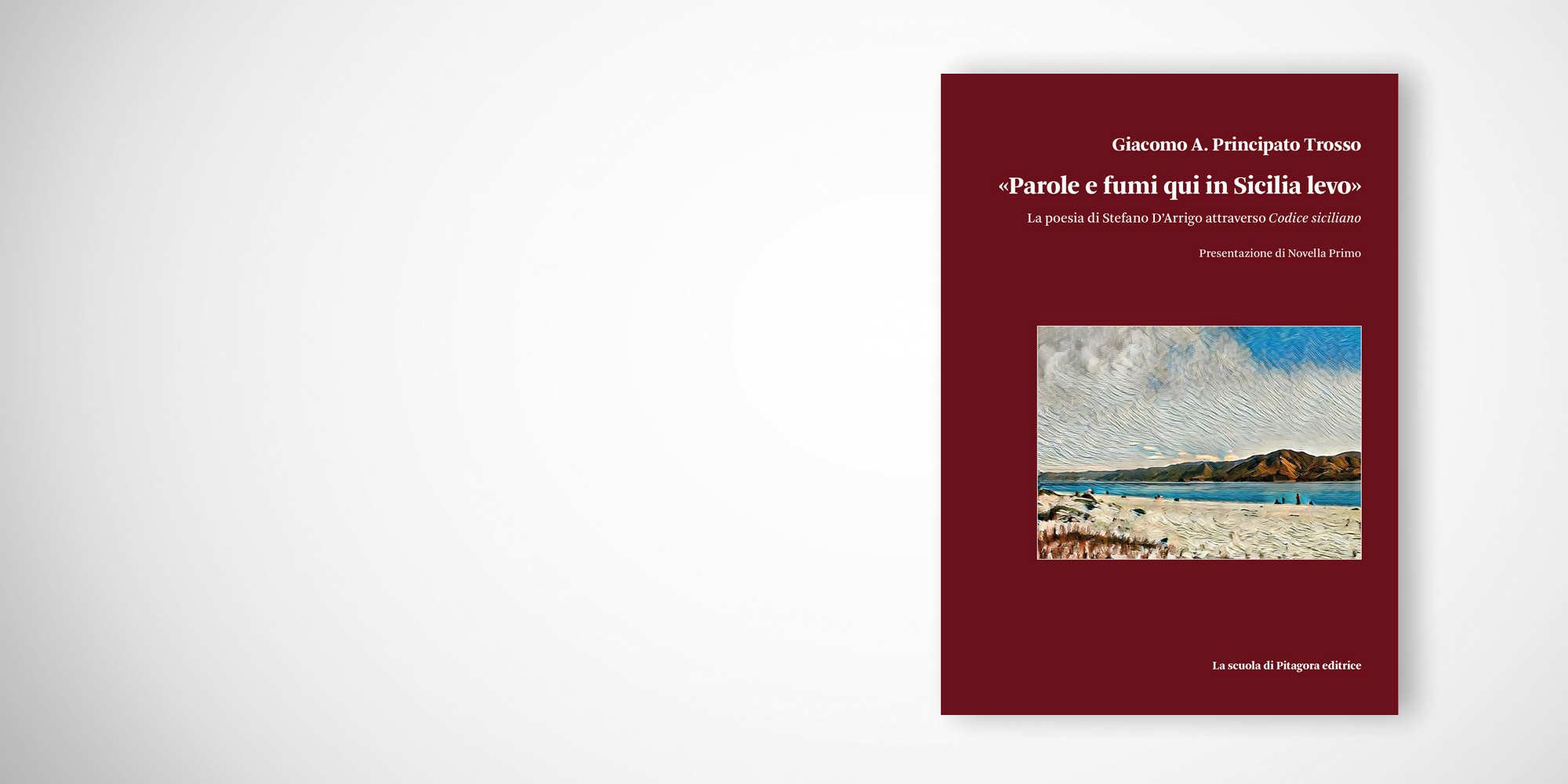
Lo studio dell’autore capitino, accolto nella collana «Biblioteca di Sinestesie» fondata e diretta da Carlo Santoli e dato alle stampe per i tipi de La scuola di Pitagora editrice nel 2025 corredato di una raffinata e accurata disamina introduttiva di Novella Primo,1 si configura come una rielaborazione della sua tesi magistrale, il cui nucleo di partenza è stato preservato, ma al contempo riorganizzato in una forma più essenziale perfezionata con un approccio critico di rafforzata incisività, orientato a offrire una visione più focalizzata degli argomenti esaminati nella trattazione originaria. Attraverso un’architettura critica articolata in tre sezioni intitolate, rispettivamente, L’estimo poetico di un prosatore; Dissertazioni critiche sulla poesia darrighiana; e «Codice siciliano»: percorsi di lettura, il saggio esplora i componimenti contenuti nell’unica silloge poetica dello scrittore nato ad Alì Marina (Messina), Codice siciliano, uscita per la prima volta nel 1957 per le edizioni Scheiwiller nella prestigiosa serie letteraria «All’insegna del Pesce d’oro» e successivamente ripubblicata presso Mondadori nella collezione «Lo specchio» nel 1978, mettendone in luce le peculiarità testuali e concettuali, ma non solo: prende infatti in esame anche una selezione di poesie rimaste escluse dalla raccolta definitiva, contribuendo in questo modo, come non ha mancato di mettere in luce Novella Primo, a retrodatare l’esordio poetico di D’Arrigo e a delineare con maggiore precisione l’evoluzione della sua voce lirica. Ma c’è di più. Questo denso percorso analitico, arricchito da alcune puntuali e mai superflue o sovrabbondanti considerazioni in merito alla posizione periferica ancora oggi occupata da Stefano D’Arrigo nel solco del canone novecentesco2 – che si rivelano fondamentali per comprendere le dinamiche di ricezione e contestualizzare il destino critico dell’autore aliese nel panorama letterario del Novecento –, analizza il Codice siciliano in connessione non esclusivamente con la monumentale opera-cardine, ma anche nel contesto degli scritti in prosa risalenti agli anni Quaranta e Cinquanta, tra elzeviri e scritti di critica d’arte. Tale prospettiva è approfondita in particolare nel primo dei tre capitoli, dove viene messa a fuoco con scrupolosa disciplina critica la questione della permeabilità tra prosa e poesia nell’opera darrighiana. Tale snodo critico è affrontato attraverso un’attenta operazione preliminare di raccolta e sistematizzazione dei numerosi testi sparsi, prevalentemente ascrivibili all’ambito giornalistico, a cui si affianca l’analisi di significativi carteggi, come quelli intrattenuti con Resta e Zipelli. L’esame di questa documentazione è prezioso, poiché consente di ricostruire con chiarezza l’iter compositivo ed editoriale delle poesie darrighiane, seguendone il percorso dalla loro iniziale pubblicazione su riviste e antologie sino alla definitiva “sedimentazione” nel Codice siciliano.
Mentre il primo capitolo è incentrato sull’analisi dei testi sparsi e della loro rilevanza per comprendere la “preistoria poetica” di D’Arrigo, il terzo capitolo si spinge oltre, confrontando le due edizioni del Codice – la prima, del 1957, e quella del 1978. Attraverso questo confronto, l’autore non solo esplora l’evoluzione della silloge nel tempo, ma approfondisce, con un taglio trasversale, temi centrali quali quello della giovinezza, il tema del viaggio, l’ulissismo della fase creativa giovanile di D’Arrigo e molto altro, ampliando così la prospettiva sulla ricchezza e la complessità della sua poesia, senza rinunciare a riflessioni sulla figura materna del poeta, Agata Miracolo – il cui nome è trascritto per intero in Versi per la madre e per la quaglia – restituita nella veste di una Penelope attualizzata.
Nel condurre la sua analisi critica, e più precisamente nel contesto del secondo capitolo, Principato Trosso individua poi cinque dinamiche di movimento, vere e proprie coordinate interpretative che consentono di restituire con precisione la complessità stratificata della silloge. A partire da questa scansione, lo studioso traccia una «tassonomia odeporica» (p. 9) originale, che si presenta per il lettore come una bussola critica utile ad orientarsi nell’opera poetica di Stefano D’Arrigo. È un impianto teorico, questo, la cui validità trova ulteriore conferma nelle pagine della bella Presentazione di Novella Primo, in cui l’originalità dell’approccio e l’acume dello sguardo analitico di Principato Trosso vengono lucidamente messi in risalto. Se si volesse tracciarne una sintesi, si potrebbe dire che il primo di questi movimenti si configura come un viaggio essenzialmente interiore, profondamente radicato nella tradizione lirica siciliana – ma non soltanto siciliana –, in cui il motivo ricorrente del nostos si carica di un’intensa forza suggestiva: il ritorno all’isola si intreccia al recupero memoriale di un’infanzia trasfigurata in uno spazio edenico. Il secondo movimento, invece, si dispiega lungo un vettore temporale «retrogrado» (p. 9), intrecciandosi alla storia della Sicilia, riletta attraverso una stratificazione di rimandi e suggestioni. Emblematica in tal senso, come evidenziato anche da Primo, è la collocazione della poesia Pregreca, dedicata a Rino Zipelli, in apertura dell’edizione mondadoriana della raccolta, dove l’eco arcaica dell’isola si manifesta con particolare pregnanza. Il terzo e il quarto movimento individuati da Principato Trosso nella raccolta darrighiana si sviluppano attraverso immagini paesaggistiche e opposizioni topologiche, come quelle tra Sud e Nord o tra Sicilia e Italia. Questi contrasti segmentano lo spazio poetico, creando una distinzione netta tra una dimensione esterna, che fa riferimento alla realtà concreta dell’isola e alla sua identità, e una dimensione interna, che riguarda una Sicilia immaginaria e idealizzata: sono i concetti condensati «nel duplice e contrapposto sentimento di sicilianità e sicilitudine» (p. 191). L’ultimo movimento, il quinto, «implica sì uno spostamento pseudo-fisico ma il suo valore è puramente metapoetico. Si tratta di moti di connessione che rappresentano la vertigine darrighiana dell’andirivieni, che ha poi uno sviluppo semantico compiuto in Horcynus Orca» (p. 193). Esso si manifesta, ad esempio, attraverso l’uso di proverbi ed espressioni idiomatiche, ossia con l’uso di elementi linguistici che appartengono alla tradizione orale, ma che nella poesia acquisiscono nuovi significati o vengono rielaborati, nonché nel ricorso a quelle che Giorgio Caproni ha definito «immagini pittate», ossia immagini poetiche così vivide da sembrare dipinte, evocando nella mente del lettore una forte sensazione visiva. Come lo stesso Principato Trosso suggerisce con una perspicacia interpretativa notevole, la poesia di Codice siciliano si caratterizza dunque per l’impiego di un «verso direzionale» (p. 193), che traccia traiettorie diversificate, ma tutte mirate a un ritorno alla Sicilia, intesa non come luogo fisico, ma come terra della memoria e degli affetti perduti. È un moto circolare, che il lettore è invitato a percorrere senza fine; un ritorno che non implica un recupero della vicinanza familiare originaria, bensì l’acquisizione di un’amara consapevolezza: quella di una distanza incolmabile.
In conclusione, la monografia di Giacomo Principato Trosso si segnala per l’approccio innovativo con cui esplora il Codice siciliano di Stefano D’Arrigo, un’opera che, come emerge chiaramente dalla lettura del saggio, pur occupando una posizione che può definirsi “centrale” in seno alla produzione dell’autore, ha ricevuto sino ad oggi un’attenzione critica relativamente scarsa e ragionevolmente limitata e limitante, almeno nel contesto degli studi monografici. La capacità dello studioso capitino di individuare e analizzare i “movimenti” presenti all’interno della raccolta, strutturando, come si è detto, una tassonomia odeporica articolata, è indice di una rimarchevole maturità critica, soprattutto in considerazione della sua giovane età. Questo lavoro, sorretto da un impianto bibliografico ampio e aggiornatissimo, non solo arricchisce la lettura di D’Arrigo, ma fornisce anche una base solida per future analisi, sanando una significativa carenza nell’ambito delle indagini critiche sinora effettuate. Come osserva Novella Primo, che ha accompagnato con grande zelo l’autore nel suo percorso di ricerca: «questo volume sembra essere la riprova di come dalla disamina di una piccola (ma preziosa) plaquette si possa generare un saggio complesso, stratificato e sicuramente arricchente nel panorama degli studi critici sulla produzione letteraria di Stefano D’Arrigo» (p. 10). Si tratta di un’osservazione che conferma pienamente il valore e l’originalità di questa «avvincente narrazione critica» (p. 11).
1 Novella Primo, docente di Letteratura italiana contemporanea presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli studi di Messina, è stata la relatrice della tesi magistrale da cui ha avuto origine lo studio di Giacomo Principato Trosso in esame.
2 «Non sono pochi, invero, i critici e i lettori che considerano HO un’opera tra le più importanti della letteratura europea contemporanea, da annoverare accanto allo Ulysses joyciano e alla Recherche proustiana, una delle opere destinate a durare, a restare nel tempo, cosa, questa, di cui D’Arrigo stesso era certissimo. Eppure la nicchia interpretativa entro cui D’Arrigo è rimasto rinchiuso lo dipinge come un autore difficile da leggere, complesso da capire, non eccezionale nella sua qualità di scrittura, come se fosse la facilità di divulgazione del messaggio letterario a dare qualità» (p. 111).