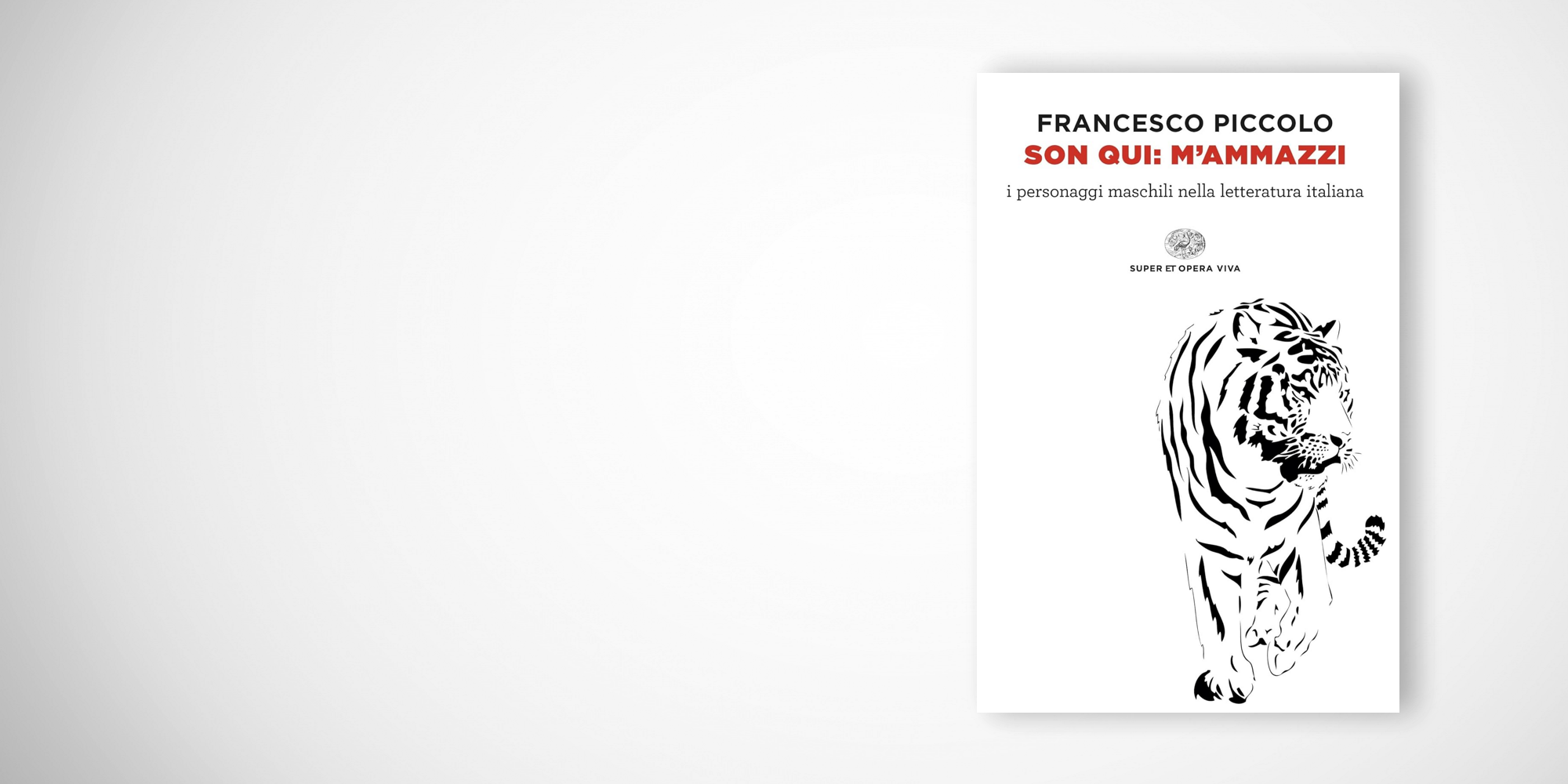
Son qui: m’ammazzi, il sarcastico pamphlet di Francesco Piccolo uscito da Einaudi può essere preso anche come un gioco a scacchi: una partita in cui a mossa si risponde con una contromossa, a tesi si oppone una tesi alternativa meno unilaterale e esemplificativa. Riassunta in breve, la tesi centrale sostenuta nei capitoli del libro è che la figura del maschio è costantemente rappresentata nella letteratura italiana, da Boccaccio a Starnone, esaltandone il potere, la supremazia, il dominio sessuale, la cinica astuzia. Insomma in tutti i romanzi o poemi dei tredici casi presi in esame la maschilità non è oggetto di condanna. Il che proverebbe un’attitudine diseducativa della letteratura: un avallo di disvalori che accorda compiaciuto spazio alla virile malvagità. Su questa base Piccolo costruisce un canone personale nel quale nessuno si salva, a partire da Alessandro Manzoni. Proprio da Manzoni, sissignori, dall’autore che forse più di ogni altro ha gettato una luce negativa sui don Rodrigo che andavano – vanno – a caccia di inermi fanciulle da stuprare.
In un saggio sulla letteratura si deve procedere facendo tesoro di categorie e metodi confacenti alla corretta ricezione di opere creative, da cui non è corretto ritagliare un repertorio di figure buone per la tesi da dimostrare. La contromossa da opporre può esse finalizzata a dimostrare che il protagonista individuato non è proprio quel tronfio vincitore che Piccolo vuol far credere o addirittura tentar di dimostrare che è portatore di una maschilità sconfitta, fragile. Magari la questione innegabile su cui soffermarsi è la scarsezza in talune fasi di personaggi femminili, a riprova di uno squilibrio sociale che la letteratura registra. Ripasso tutte le tredici proposte dell’infuocato autore.
Muoviamo dai passaggi dei capitoli XX e XXI dei Promessi sposi dedicati al rapimento di Lucia e alla sua lancinante implorazione in faccia all’imbarazzata prepotenza del maschio innominato. Quel grido, «Son qui: m’ammazzi», è una sfida, non una resa: è il momento saliente di un dramma sacro incastonato nel romanzo. Il protervo maschio è scosso da un tremore incontrollabile al sol riascoltare mentalmente le imploranti parole dell’inerme ragazza: «Lasciò cader l’arme, e stava con le mani ne’capelli, battendo i denti, tremando. Tutt’a un tratto, gli tornarono in mente le parole che aveva sentite e risentite poche ore prima: – Dio perdona tante cose, per un’opera di misericordia! – e la dignitosa umiltà che quelle parole gli sembrava avessero avuto ad un primo ascolto gli ritornava con un suono – scrive Manzoni – pieno d’autorità, e che insieme inducevano una lontana speranza». Il vero innominato era stato un campione della maschilità aggressiva e spavalda, ma la rappresentazione letteraria evidenzia un crollo che spinge alla conversione. Il cristiano Manzoni la declina applicando un paradigma di ascendenza giansenistica e di sapore autobiografico. A vincere è l’autorità di Lucia, e non a caso è usata la paradossale categoria di autorità. Se mi divertissi a comporre un puzzle con personaggi portatori di uno spiccato carattere, come fossero maschere di un canovaccio senza sfumature, indicherei a contrappeso Fra’ Cristoforo, l’eroe indubbiamente positivo di tutta la vicenda. Che chiede di essere interpretata nella sua intera architettura e badando alla soggettività di chi l’ha immaginata, non al nudo contenuto. I personaggi in un romanzo sono funzioni di un discorso complessivo. Il bello è che nell’insieme son le donne ad avere la meglio: Lucia decide a fronte dell’impacciato Renzo; Perpetua è cento volte più vispa dal pavido Abbondio; Donna Prassede più sottile dell’enfatico Ferrante.
Un altro cavallo di battaglia è il Decameron, dal quale Piccolo trae per exemplum la settima novella dell’Ottava giornata, quella di Rinieri che si vendica straziando crudelmente Pampinea «in modo sproporzionato». In questo caso è agevole contrapporre alla truce avventura i tanti Calandrino disorientati, beffati o ingenui, di novelle che esaltano la nascita dell’etica borghese-mercantile che introduce un senso innovatore della libertà, per tutti benefico. Anche per le donne non più ancorate agli stereotipi di angelo e demone, di santità e peccato. Piccolo non auspica certamente una letteratura pudica ispirata magari dal wokismo in voga. Si sa che il furioso Orlando dell’Ariosto è eccitato da una sfrenata follia possessiva alla ricerca di Angelica, che lo snobba e domina le danze: è il primo poema cavalleresco che dà ammirato spazio al volere femminile. Rimproverare il buon Ludovico di essersi nutrito dei moduli cortesi della civiltà rinascimentale è come attribuire all’Erasmo dell’Elogio della pazzia un’indiscriminata infatuazione per i matti anziché una saggia presa di distanza da una totalizzante ragione.
Le confessioni d’un italiano (1867) di Ippolito Nievo non suffragano sospetti maschilisti. La Pisana è una delle donne che più sprigionano un’appassionata empatia, senza infingimenti e forzature, e il buon Carlino Altoviti al cospetto fa una magra figura. La donna amata l’assolve con magnanima comprensione: «io peccai e tu mi perdonasti; io t’abbandonai, e non ne movesti lamento; tornata a te mi raccogliesti colle braccia aperte e col miele sulle labbra!… Tu sei l’essere più nobile più confidente e generoso che possa esistere…». Bisogna evitare un errore di fondo: il romanzo otto-novecentesco non ha un’impostazione esemplare o antiesemplare e quindi non ci sono modelli o proposte di modelli positivi o negativi. Ci sono tanti uomini e poche donne che meditano sui loro comportamenti e gli autori spesso ne mettono in luce i limiti: ossessioni, psicopatologie, turbamenti, frustrazioni e così via. Si fa fatica a trovare personaggi (maschili o femminili) tutti d’un pezzo, buoni o cattivi, accattivanti o deprecabili. Se nell’Ottocento il personaggio si muove in ambienti realistici sì da prestare il fianco a giudizi morali anche univoci, con i primi sintomi dell’esiguo modernismo novecentesco uomini o donne – non classificabili con manichea rigidità sessuale – dotati di una loro misteriosa autonomia vanno in cerca d’autore: e spesso l’inquietudine interiore sopravvive pure in età neorealistica, quando riprende fiato una vena veristica d’antan. Nello scapigliato e pettegolo romanzetto del napoletano Vittorio Imbriani Dio ne scampi dagli Orsenigo (1876) – caduto nel dimenticatoio, perché ripescarlo? – non trovo appigli per una contromossa. Mi dichiaro perdente e trascrivo una battuta del fatuo Maurizio alla povera Radegonda, che più sciocca non potrebbe essere: «Ma tu m’impastocchieresti una frottola. Io non son femmina, per saper fingere e mentire: io fo quel che m’accomoda; vo, dove m’aggrada».
I Malavoglia si concludono con la presa di coscienza da parte di ’Ntoni che l’esibizione della sua feroce maschilità comportava né più né meno che la fuga da Aci Trezza. Una tragica sconfitta l’ha cacciato per sempre. Deprecazione più totale di un maschio possessivismo non è immaginabile. Senza essere didascalico, Verga suggerisce tutto. Pirandello non è citato. E si salta a Svevo, che con La coscienza di Zeno è il pivot dello smilzo modernismo italiano. Zeno, ultima lettera dell’alfabeto non è uno sciupafemmine ma un debole sballottato qua e là dagli eventi, talmente convinto che l’individualismo è la tabe da eliminare da ritenere che «un uomo fatto come tutti gli altri», non un possente suprematista, «inventerà un esplosivo incomparabile», e sarà l’Apocalisse. Il bell’Antonio di Vitaliano Brancati è rovinato, lui impotente, da una società che fa del sesso il simbolo irrinunciabile di una conformistica scala di valori. Il moralista Brancati soddisfa in pieno la missione di una letteratura edificante. E il Gattopardo non muore da sconfitto di un mondo che gli crolla addosso? Il fascino che avverte di Angelica è osservato con lo sguardo dell’addio. Il domani sarà suo e di Tancredi, della loro fremente vitalità. «Quando – sottolinea Piccolo – don Fabrizio dice che il suo tempo è finito, e che è giusto che altri si occupino delle vicende della Sicilia e dell’Italia, sta dicendo che il suo tempo è finito anche come maschio». Che c’è di strano? È la mesta consapevolezza di un tramonto politico e fisico. Chiudo in fretta: Giorgio Bassani nel suo Il giardino dei Finzi Contini mette in scena l’impossibilità di un’amicizia di trasformarsi in amore e dà a Micòl la parola per una presa di coscienza coraggiosa, sullo sfondo dell’imminente guerra totale. Piccolo è, a ragione, particolarmente infastidito dal mediocre romanzo di Dino Buzzati Un amore. Ma la maniacalità di Antonio Dorigo esprime un maschilismo che sfiora il grottesco: anch’esso è una dolorosa sconfitta. Se la piglia con Domenico Starnone per Via Gemito (2000). Il primogenito ricorda con disprezzo il padre Federico, artista morso da un’incomprimibile violenza. Ma al consiglio del babbo di lasciare al suo destino un’Italia disgraziata netta è la sua risoluta risposta: «Mi immaginavo che presto avremmo combattuto strada dietro strada, mio padre su un fronte, io sull’altro, lui tradizione e realtà, io avanguardia e rivoluzione».
Ho lasciato da ultimo Una questione privata di Beppe Fenoglio. Non c’è romanzo nella letteratura resistenziale nostra che più intrecci con travolgente ritmo epico i profondi sentimenti privati di un vero, non eroicizzato partigiano, Milton, con la sua battaglia patriottica, e la sete di conoscere il destino di Giorgio, catturato da fascisti, pure lui innamorato di Fulvia. Un confuso combattere che non porta alla verità. E si chiude con fuga solitaria, disperata di Milton: «Sono vivo. Fulvia. Sono solo. Fulvia, a momenti mi ammazzi!». Perché immiserire un tormento così autentico in un’ostinata gelosa maschile voglia di verità?
La partita finisce con uno scacco matto. O almeno con un’obiettiva parità. Fatto è che quasi nessuno dei personaggi trascinati alla ribalta da Piccolo riesce a essere truce maschio fino in fondo. O mi sbaglio?
P.S. Questo è un elenco di titoli che metterei in gioco per proseguire l’immaginaria partita accesa dall’invettiva di Francesco Piccolo: Sibilla Aleramo (Una donna, 1906); Carlo Emilio Gadda (Eros e Priapo, 1944-45); Cesare Pavese (Il compagno, 1947; Tra donne sole, 1949); Anna Maria Ortese (Il ragazzo di Monte di Dio, 1953); Natalia Ginzburg (Valentino, 1957); Carlo Cassola (La ragazza di Bube, 1960); Anna Banti (con Artemisia, 1947 e Noi credevamo, 1967); Alberto Moravia (La Ciociara, 1957); Alberto Arbasino (Fratelli d’Italia, 1963); Dacia Maraini (La lunga vita di Marianna Ucrìa, 1960); Rosella Postorino (Le assaggiatrici, 2018); Carmen Pellegrino (Dove la luce, 2024).