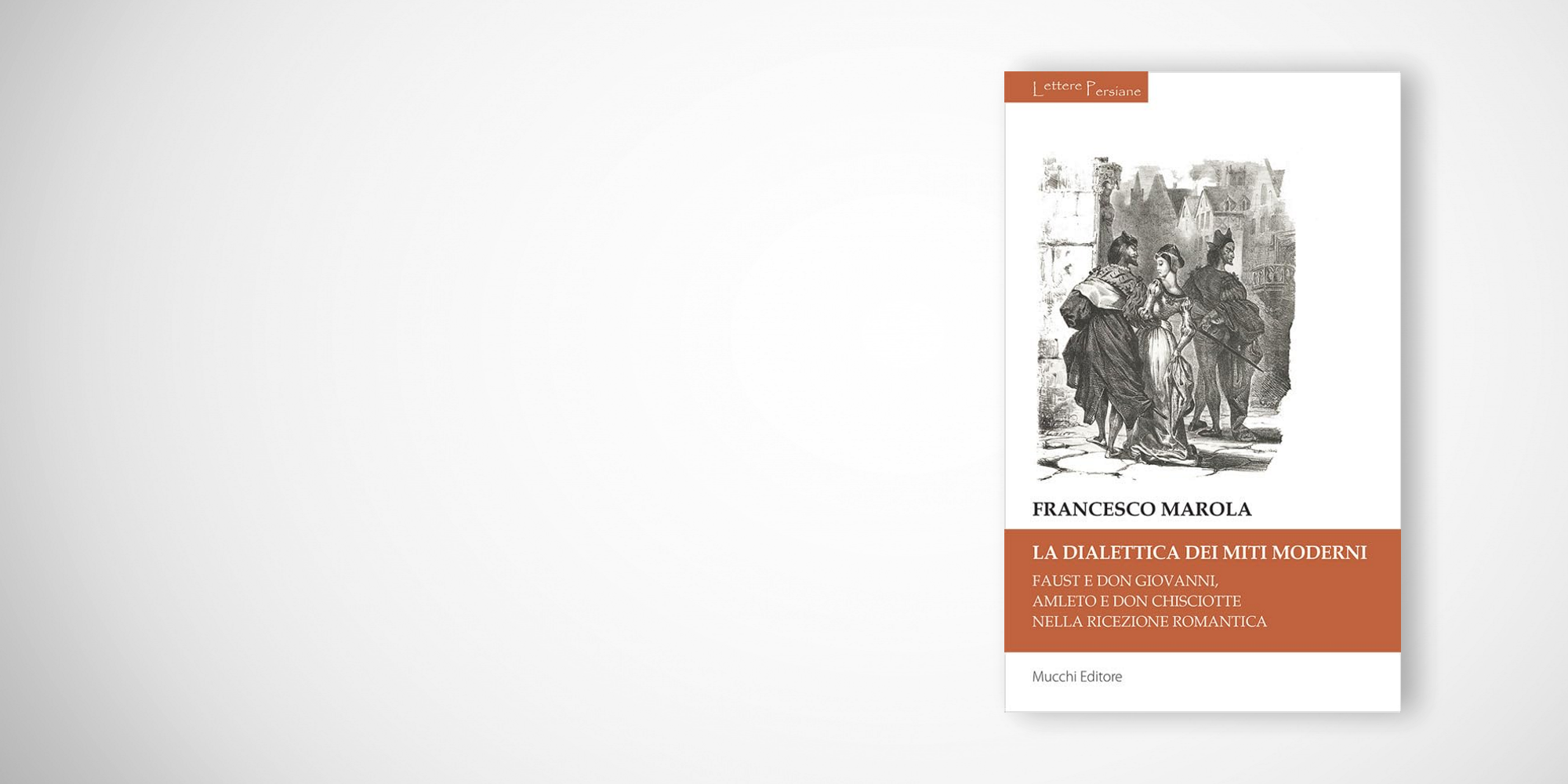
«È troppo facile parlare di mito. Lo si fa spesso, a proposito di qualunque cosa»,1 scrive Pierre Brunel richiamando il pensiero di André Jolles in Einfache Formen (1930), per il quale studiare il concetto di mito significava non solo «combattere la rilassatezza e la negligenza d’uso» del termine, ma anche superare definitivamente due concezioni, quella trascendentalista che eleva il mito al di sopra di ogni discorso, e quella immanentista che identifica il mito con il discorso stesso.
Sono considerazioni tutt’altro che superate e che pongono a mio avviso due questioni preliminari sulle quali è necessario soffermarsi. Una è di ordine terminologico: l’attuale proliferazione degli studi sul mito non sembra corrispondere nei fatti ad una maggiore consapevolezza nei riguardi del concetto di ‘mito’, della sua configurazione e delle sue applicazioni. La bulimia critica in questo campo rivela piuttosto una confusione di fondo, che si riversa in una varietà di approcci e interpretazioni – muovendosi peraltro in direzione opposta al monito di Jolles, il quale già segnalava il rischio che il termine ‘mito’ si inflazionasse fino a logorarsi. Il mancato consenso su cosa si intenda per mito e che accomuna gran parte degli studi più recenti, apre alla seconda questione di carattere metodologico: se da un lato le prospettive parallele, immanentista e trascendentalista, hanno conosciuto nel tempo tentativi di conciliazione – dalla mitocritica strutturalista e mitanalisi alla psicocritica, dall’ermeneutica alla filosofia del mito – dall’altro, negli studi letterari e segnatamente germanistici – ambito in cui, occorre dirlo, il discorso sul mito affonda le radici e si sviluppa – il dibattito sembra arrestarsi entro un orizzonte per lo più teoretico, eludendo il problema di un’indagine puntuale sul funzionamento del mito a livello testuale, là dove appunto il mito dovrebbe essere assunto come vero paradigma critico.
La dialettica dei miti moderni di Francesco Marola colma questa lacuna sciogliendo il duplice nodo concettuale-metodologico che inficia gran parte degli studi sul mito letterario. Muovendosi nell’ambito della teoria letteraria di ambito germanistico e dell’analisi testuale con un’apertura notevole alla comparatistica, Marola non solo cala il dibattito sul mito nel suo contesto d’origine, ma àncora analiticamente quel dibattito saldando tra loro teoria e prassi. Il dibattito sul mito nell’età classico-romantica, puntualmente ricostruito a partire dalle fonti, apre progressivamente a un’analisi della “macchina mitologica” – per dirla con Furio Jesi – che viene applicata a quattro grandi figure della modernità letteraria: Faust, Don Giovanni, Amleto e Don Chisciotte. Marola amplia lo studio di Ian Watt, Myths of Modern Individualism, che tra i miti dell’individualismo annoverava, tra gli altri, Faust, Don Chisciotte e Don Giovanni (miti nati come exempla negativi in epoca controriformistica per arginare il crescente individualismo di matrice rinascimentale con esiti punitivi o derisori), integrando a quelli la figura di Amleto e completando così il quadro del canone letterario moderno secondo la teoria primoromantica. Marola riprende infatti il discorso là dove Watt si era interrotto: dalla querelle sul mito nella Frühromantik, in cui tali figure emergono appunto come la cartina tornasole di una riflessione critica più ampia, che avvia tutta la concettualizzazione moderna di “mito letterario”.
La monografia è suddivisa in tre parti. La prima ricostruisce la genealogia del nuovo concetto di mito, connesso a quello di simbolo, che fu alla base della prima interpretazione della letteratura moderna come nuova forma di mitologia, con l’obiettivo di dimostrare l’implicito sviluppo dell’idea di mito letterario moderno all’interno della costellazione letteraria e filosofica del primo romanticismo e idealismo tedesco. In tale costellazione un posto di prim’ordine spetta a Friedrich Schlegel, a cui va il merito di aver individuato nelle opere-mito del cosiddetto Dichtertriumvirat – Shakespeare, Cervantes e Goethe – il fulcro del canone tedesco, ma soprattutto di aver evidenziato il rapporto inscindibile del mito con il testo letterario quale vettore del potenziale mitopoietico e trasformativo della Neue Mythologie. Il processo di costruzione attiva del mito, come esito di una libera creazione dello spirito teorizzata nella Rede über die Mythologie (Gespräch über die Poesie, 1800), si lega così al concetto di “poesia universale e progressiva”, formulato nel frammento 116 dell’«Athenaeum», elevando il mito a principio fondativo della letteratura moderna in quanto rappresentazione della fantasia.
La seconda parte si focalizza sull’articolazione tanto letteraria quanto filosofica dei miti dell’individualismo. Il cuore dell’indagine ruota attorno al concetto romantico di “dialettica”: il carattere moderno tragico e insieme ironico individuato da Schlegel nei miti di Amleto, Don Chisciotte e Faust diventa la chiave interpretativa che permette di rintracciare «associazioni, opposizioni e sintesi», che si riveleranno a loro volta in ogni nuova elaborazione di del mito. Marola sottolinea a questo proposito la fondamentale plurivocità che governa il principio dialogico-dialettico del mito letterario, in grado di istituire una serie di variazioni rispetto al mito tradizionale senza intaccarne il nucleo fondamentale. Interessante è notare come il concetto di dialettica apra al tema di una costante ambivalenza e dinamicità sottesa al mito letterario, che articola una rete di intarsi testuali, analogie e strutture parallele, tali per cui Faust-Don Chisciotte-Amleto-Don Giovanni emergono non tanto come protagonisti autonomi di opere-mito in sé conchiuse, quanto un corpo letterario mobile che li vede confondersi e ibridarsi a vicenda in un continuo dialogo intertestuale.
La dialettica si articola non solo in senso estetico, ma trova espressione nell’idea di un’alternanza tra forze polari complementari e inconciliabili, a perno di una riflessione storica che permette di leggere il mito come una rappresentazione esemplare della crisi dell’individuo moderno. Nella ricezione romantica di Kant, tale dialettica si traduce nella tensione tra reale e ideale; sul piano morale e psicologico si manifesta invece nel difficile equilibrio tra ragione e passione, riflessione e azione. Le spinte antitetiche così storicizzate si manifestano nella coesistenza di due anime – ripiegamento ascetico e interiorizzazione della natura da un lato, e slanci prometeici per la libertà e l’affermazione dell’io dall’altro – quale specchio dell’ambivalenza del soggetto scisso. Di tale principio l’allievo degli Schlegel, Heinrich Heine, si fece eccezionale interprete, prima teorizzando la dialettica in termini storico-politici nel suo saggio De l’Allemagne (1833), poi tematizzandola nel binomio spiritualismo/sensualismo – l’uno di matrice cristiana-medievale e romantica, l’altro di ascendenza pagana e materialista – binomio al quale ha conferito di volta in volta una forma plastica attraverso diverse figure del mito nella sua opera. In tal modo, Heine riannoda il filo di quel cruciale momento rivoluzionario primoromantico sotteso alla poesia universale e progressiva, che nel frattempo veniva per così dire “minato” da tendenze metafisiche e aprioristiche che intendevano il mito anzitutto come “simbolo” – una concezione, questa, che sarà criticata apertamente solo un secolo dopo da Walter Benjamin.2
La terza parte entra nel vivo dell’analisi di alcune opere tardoromantiche e del loro rapporto intertestuale con il canone. Decisiva e altrettanto convincente la sezione sul Faust: Marola non solo è attento a ricostruire filologicamente i diversi orientamenti del mito che si ripartono dalle stesure goethiane (Faust. Ein Fragment, 1790, Eine Tragödie, 1808, Zweiter Teil, 1832), ma si preoccupa di delineare gli sviluppi che da Goethe si irraggiano nelle successive riscritture. Tra queste troviamo quelle di E.T.A. Hoffmann (Don Juan, 1813), Christian Dietrich Grabbe (Don Juan und Faust, 1828), Prosper Mérimée (Les Âmes du purgatoire, 1834), Nikolaus Lenau (Faust, 1836; Don Juan, 1844) e Heine (Der Doktor Faust. Ein Tanzpoem, 1851) – solo per citarne alcune – così come le riflessioni di Søren Kierkegaard (Enten-Eller, 1843) e Ivan Turgenev (Gamlet i Don-Kichot, 1860), altrettanto fondamentali nella sistematizzazione teorica della dialettica del mito faustiano in epoca postromantica. Così, se nel Meister di Goethe si realizza per Schlegel una sintesi tra ironia cervantina e Sorge amletica, con il secondo Faust emergerà piuttosto un’opposizione in cui i caratteri di Don Chisciotte e Amleto riflettono «due diversi atteggiamenti dell’uomo nei confronti del proprio ideale». Analogamente, se per Turgenev la dialettica si gioca in termini politici e morali tra scepsi ed entusiasmo utopistico, tra intelletto paralizzante e incoscienza attiva e produttiva, con Hoffmann si sposterà sull’asse vitalistico ed erotico tra Streben e Liebe propria del secondo Faust, facendo risuonare nel lungo Ottocento la triplice ibridazione tra Faust-Mefistofele e Don Giovanni secondo lo spirito di Mozart, fusi nell’elemento musicale-demoniaco che caratterizzerà molte delle riscritture moderne dal tardoromanticismo in poi.
1 P. Brunel, Mitocritica, Firenze, Olschki, 2015, p. 9. Francesco Marola ripercorre il dibattito sul mito partendo da questo ed altri testi teorici nel suo saggio La “Mythocritique” e il concetto di “mito letterario”, in «Testo & Senso», 20, 2019, pp. 1-12. si lega così al concetto di “poesia universale e progressiva” formulato nel frammento 116 dell’«Athenaeum», elevando il mito a principio fondativo della letteratura moderna in quanto rappresentazione della fantasia.
2 W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, in Id., Gesammelte Schriften, hrsg. R. Tiedmann, H. Schweppenhäuser, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1974, pp. 203-409.