Carmela Biscaglia, Mariadelaide Cuozzo,
Artisti del Novecento per Scotellaro
Simone Zacchini
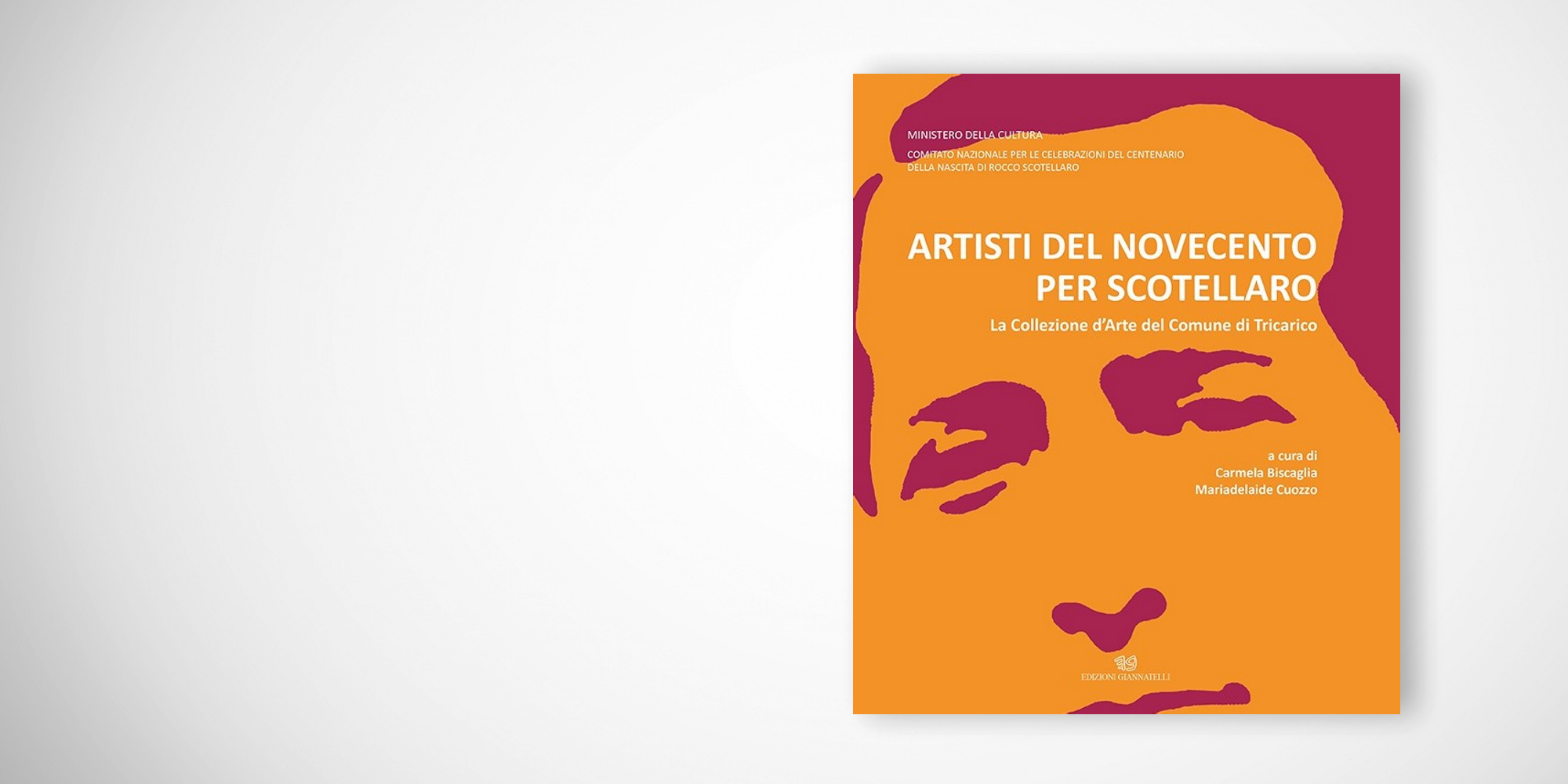
Nonostante porti lo stesso titolo dell’evento espositivo da cui ha preso spunto (allestito nei saloni del Castello Normanno di Tricarico, nell’estate del 2023), il volume curato dalla storica Carmela Biscaglia e dalla storica dell’arte Mariadelaide Cuozzo non è classificabile come un semplice catalogo di mostra. Il libro – nato dalla collaborazione tra il Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario della nascita di Rocco Scotellaro, presieduto dallo storico Antonio Lerra, il Comune di Tricarico, il Centro Carlo Levi di Matera e la Deputazione di Storia Patria per la Lucania – si pone l’obiettivo di portare a conoscenza e valorizzare un corpus di opere d’arte che nel secondo Novecento diversi artisti di caratura nazionale hanno donato al Comune di Tricarico, quale omaggio a uno dei più illustri tricaricesi: Rocco Scotellaro (Tricarico, Matera, 1923 – Portici, Napoli, 1953). Ma il pregio del volume è anche quello di ricostruire, attraverso i due approfonditi saggi delle due curatrici, il contesto culturale in cui quelle opere sono state realizzate e l’evoluzione nella percezione di artisti di diverse generazioni di una figura complessa e poliedrica come quella di Scotellaro.
Poeta, amministratore locale (Sindaco di Tricarico tra il 1946 e il 1950 e tra i più giovani sindaci d’Italia in quegli anni), militante politico socialista e ricercatore, Scotellaro, in tutta la sua breve vita, ha coniugato pensiero e azione, denunciando, per esperienza diretta, le condizioni di vita delle classi subalterne lucane, in particolare modo dei contadini, e lavorando al loro fianco per migliorarle. Non un poeta-contadino sognatore, come spesso è stato sbrigativamente etichettato, ma uomo attivo e combattivo, critico e operativo nel suo impegno civile sul campo, dialettico senza mai imporsi dall’alto.
L’intento del volume è quello di restituire nuove letture e analisi sul lascito politico-culturale di Scotellaro nel centenario della sua nascita e a settant’anni dalla sua morte, avvenuta prematuramente per infarto nel dicembre 1953 a Portici, dove si era trasferito per lavorare al Piano regionale di sviluppo per la Basilicata, promosso dalla SVIMEZ (Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno) ed elaborato nell’Istituto di economia e politica agraria dell’Università di Portici, diretto da Manlio Rossi-Doria, dopo la delusione seguita al breve arresto del 1950, con l’accusa, poi dimostratasi del tutto infondata, di irregolarità amministrative nella sua attività di sindaco a Tricarico.
Bisogna ricordare che questo nuovo slancio rispetto agli studi su Scotellaro è iniziato già qualche anno prima del centenario, con la pubblicazione del volume Rocco Scotellaro. Tutte le opere (Mondadori, 2019), a cura di Franco Vitelli, Giulia dell’Aquila e Sebastiano Martelli, i quali hanno poi continuato in questi anni le pubblicazioni di scritti di e su Scotellaro con la casa editrice Quodlibet. Ma con il centenario del 2023 il tutto ha preso ulteriore vigore grazie a una serie di iniziative editoriali, convegnistiche e espositive di valore nazionale.
Tutto questo recente fermento intorno a Scotellaro non sarebbe stato possibile, però, senza il grande lavoro che vide, proprio all’inizio degli anni Settanta (in concomitanza con il cinquantenario della nascita e il ventennale della morte), una serie di importanti approfondimenti scientifici sul poeta-sindaco di Tricarico. Il saggio di Carmela Biscaglia (pp. 13-26) sembra proprio creare un ponte tra 1973 e 2023, ricostruendo in maniera puntigliosa il contesto degli anni Settanta, momento di ripresa degli studi su Scotellaro su basi nuove rispetto alla sua “mitica” eredità culturale gestita, subito dopo la sua precoce scomparsa, in prima persona da Carlo Levi, che aveva conosciuto Scotellaro nel 1946, e dal già citato Manlio Rossi-Doria, che già nel 1954 e nel 1955 ne curarono la pubblicazione postuma di tre opere: la raccolta di poesie È fatto giorno (1940-1953), poi vincitrice del Premio Viareggio 1954, il saggio Contadini del Sud e il romanzo autobiografico L’uva puttanella. L’apoteosi della celebrazione di Scotellaro da parte di Levi avvenne qualche anno più tardi, nel 1961, quando il pittore decise di dedicare il suo enorme telero Lucania ’61 proprio alla figura illuminata del “poeta della libertà contadina”, che divenne emblematica per raccontare la Basilicata tout court nella Mostra delle Regioni, organizzata all’interno di Italia ’61, Esposizione Internazionale del Lavoro svoltasi a Torino per celebrare l’Unità d’Italia.
L’opera, esposta nel Museo nazionale d’Arte Medievale e Moderna della Basilicata presso Palazzo Lanfranchi a Matera, è un manifesto della lettura idilliaca e quasi mitologica che Levi dava dell’operato di Scotellaro all’interno del mondo contadino lucano che però, otto anni dopo la sua morte, era già stato quasi completamente dimenticato. Lontana era l’eco suscitata dalla sua morte precoce, che portò all’accesissimo dibattito sul valore intellettuale e politico della sua figura che sconvolse Matera nel febbraio 1955, quando Raniero Panzieri, l’allora responsabile culturale della Direzione centrale del Partito Socialista Italiano, organizzò il convegno Rocco Scotellaro, intellettuale del Mezzogiorno.
Tra gli interventi più lucidi al convegno, va menzionato quello di Franco Fortini, che verrà poi ripubblicato nel 1974 da Basilicata Editrice che, nello stesso anno, aveva anche curato la pubblicazione di un quarto libro postumo di Scotellaro, la raccolta di racconti Uno si distrae al bivio, con prefazione di Levi. Il libro di Fortini, invece, presentava un’introduzione firmata dalla redazione della rivista «Basilicata» che raccontava di come, a oltre vent’anni dalla morte di Scotellaro, il dibattito sulla sua figura fosse ancora lontano da una soluzione condivisa. Eppure i redattori della rivista si rendevano conto che, soprattutto per le generazioni più giovani, fosse necessario ampliare il quadro delle interpretazioni e conoscere Scotellaro sotto una luce meno riduttiva rispetto alle catalogazioni schematiche e dogmatiche utilizzate nei primi anni dopo la sua morte.
Il testo integrale dell’intervento di Fortini del 1955, di cui l’archivio di «Basilicata» custodiva la registrazione, veniva ripubblicato, con lievi correzioni apportate dallo stesso Fortini e insieme a un corpus di poesie inedite conservate da Levi, proprio con questo intento: bisognava far tornare al centro del dibattito la poesia di Scotellaro, demitizzando la sua figura di “poeta-contadino”, cantore di una classe sconfitta, in modo che la sua opera (e il suo operato) non fosse più pretesto per uno scontro ideologico politico-culturale tra visioni progressiste e conservatoriste sulla questione meridionale e il mondo contadino. In questo bisogno di ripensamento critico delle precedenti letture di Scotellaro, il punto di vista di Fortini diventa testimonianza fondamentale di un’analisi che è sì politica, ma anche e soprattutto poetico-letteraria; un contributo scritto da un poeta per un poeta, in cui si tornava a mettere al centro del dibatto l’opera letteraria e la sua autenticità:
Tra queste iniziative ebbero importanza paritetica a quelle editoriali, quelle che videro protagoniste le arti figurative, con una serie di mostre di artisti visivi che, come già Levi, s’ispirarono al mondo di Scotellaro, poeta e intellettuale che, ricorda la stessa Biscaglia citando uno dei suoi Taccuini, «manifestò sempre una notevole attenzione alle forme con cui si esprime l’arte e a ciò che muove l’artista a produrre un’opera» (p. 21). Tra questi eventi il più importante fu Omaggio al poeta Rocco Scotellaro, mostra di acqueforti inedite inaugurata al Circolo Culturale La Scaletta di Matera nell’ottobre 1974, dove – insieme alle opere di 12 artisti, tra cui l’immancabile Levi – furono esposte anche alcune poesie di Scotellaro, come parte integrante del percorso espositivo.
Buona parte degli artisti presenti in questa mostra sono tra i protagonisti del successivo saggio di Mariadelaide Cuozzo (pp. 27-47), che ricostruisce quel «dialogo ininterrotto» che la figura di Scotellaro ha da sempre intrecciato con le arti figurative, a partire dall’incontro con Levi fino alle influenze sugli artisti dei giorni nostri, passando per i citati eventi espositivi degli anni Settanta. Come spiega la stessa storica dell’arte:
Ma oltre a questa mostra, anche altri importanti eventi espositivi del 2023 raccontano di questo «dialogo ininterrotto» tra Scotellaro e le arti visive, che sfocia fino alla più stretta contemporaneità: in particolare, vanno citati quello alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma (E la mia patria è dove la terra trema. 45 artisti di oggi rileggono l’opera di Rocco Scotellaro, a cura dal lucano Giuseppe Appella) e quello ai Musei nazionali di Matera – Sede dell’Ex Ospedale San Rocco (Sempre nuovo è… Scotellaro. Al bivio, nel cui comitato scientifico era presente la stessa Biscaglia). In entrambe le mostre, così come in quella di Tricarico, è presente il fotografo sperimentale Mario Cresci, ligure di nascita ma legato alla Basilicata fin dalla fine degli anni Sessanta. A lui si deve la realizzazione grafica del logo del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario della nascita di Rocco Scotellaro, che viene ripreso anche sulla copertina del volume curato da Biscaglia e Cuozzo, che si pone come nuovo strumento di riferimento per chi vuole approfondire l’influenza della figura di Rocco Scotellaro sul contesto culturale lucano del secondo Novecento.
1 F. Fortini, La poesia di Scotellaro, Matera, Basilicata Editrice, 1974, pp. 3-4.