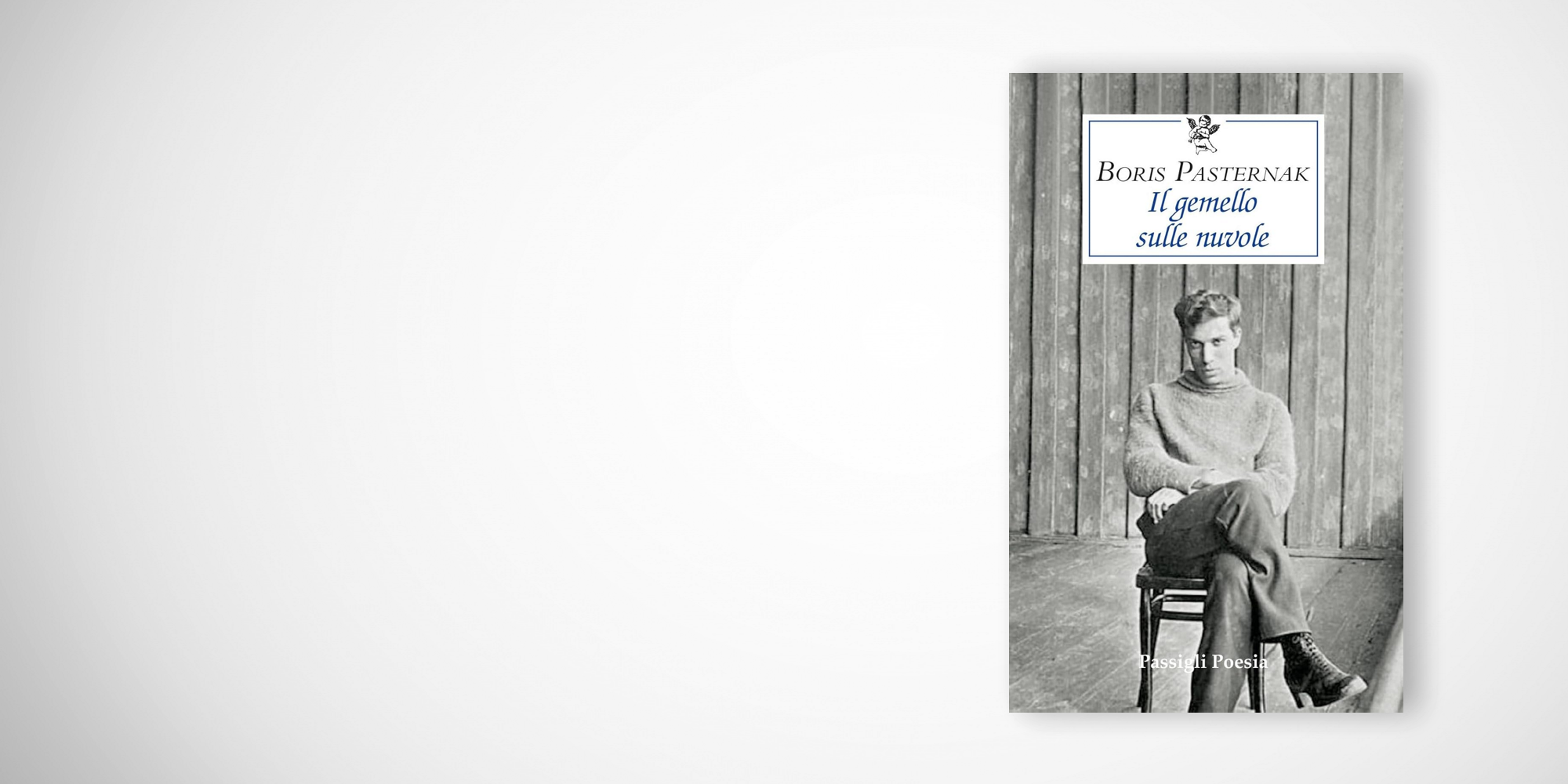
Immerso nel paesaggio boschivo intorno a un’antica tenuta di campagna a Molodi, a sud di Mosca, Boris Pasternak compose la sua raccolta d’esordio, il Gemello sulle nuvole, nell’estate del 1913, in un arco di tempo breve e circoscritto, favorito da una facilità compositiva e una predilezione per l’improvvisazione che contrassegnarono il suo processo creativo. L’opera è rimasta ignota al lettore italiano per oltre un secolo, salvo due liriche tradotte da Angelo Maria Ripellino nell’antologia einaudiana del 1957, e solo la recente pubblicazione da parte dell’editore Passigli, che prosegue il progetto di dare alle stampe l’intera opera poetica del poeta russo, ha colmato questo vuoto, affidandone la traduzione alla mano esperta di Paola Ferretti, già traduttrice di Temi e variazioni (2019) e Mia sorella la vita (2020).
Tornando all’epoca della sua composizione, il padre del futuro poeta, Leonid Osipovič, pittore di fama, ritrattista e amico di Lev Tolstoj, non approvava la vocazione alla scrittura del figlio, preferendole la prima musa artistica: la musica, a cui tuttavia Boris Leonidovič rinunciò non ritenendo di possedere un autentico dono. Come ricorda il fratello, egli aspirò sin da subito a un’indipendenza intellettuale ed economica in grado di condurlo a un’autonomia espressiva. Tra il 1911 e il 1912 si avviò allo studio della filosofia neokantiana a Marburgo, mentre a Mosca si accompagnò ai poeti Sergej Bobrov e Nikolaj Aseev, le cui poetiche, influenzate dal simbolismo, sarebbero evolute nella corrente moderata del futurismo Centrifuga.
Sergej Bobrov ebbe un ruolo significativo nella stesura del Gemello, che Pasternak riconobbe dedicandogli una lirica centrale della raccolta, una sorta di testamento poetico, Lo spazio lirico. Redattore del volume, Bobrov suggerì di modificare il titolo originario, Bliznec za tučeju (Il gemello al di là/dietro le nuvole) rinunciando alla preposizione ‘al di là/dietro’. Nello scarto di una preposizione è il transito verso la nuova sensibilità moderna, la volontà di scombinare i confini tra realtà speculari, non più come concepite nel sistema simbolista, di cui la raccolta è debitrice. La tensione simbolista verso la comprensione mistica dei fenomeni terrestri si riflette nella presenza della costellazione dei gemelli e nel principio duale e ascensionale terra-cielo, basso-alto che il termine nuvola, richiamando il cielo, esprime. Ma se la preposizione ‘za’ rimarca la separazione dei due mondi, con la preposizione ‘v’, letteralmente ‘in, dentro’, si compie un salto nel nuovo, poiché l’immagine diventa più materica e l’accento viene posto sulla presenza dell’oggetto (è lì, nelle nuvole), non sulla distanza e scomparsa dello stesso.
Il titolo offre numerose chiavi interpretative e, in tal senso, è significativa l’immagine della nuvola alla luce degli esperimenti artistici del primo Novecento; non per caso a distanza di poco tempo Majakovskij scrisse La nuvola in calzoni. La sua natura informe, mobile e impalpabile la rende una delle fonti da cui attinge l’arte astratta, non solo in pittura, da Kandinskij a Belyj, e prepara il terreno all’astrattismo delle Avanguardie.1 Inoltre la letteratura ha sempre associato alle nuvole un pensiero indefinito, «pensieri, dispersi come nuvole dopo la bufera» (Puškin in Rusalka), in tutto simile al pensiero scomposto e astruso, «alle composizioni a squarci incompiuti e interrotti» (Ripellino), che caratterizzano la produzione giovanile.
Il titolo obbliga, poi, a una precisazione terminologica. Boris Pasternak usa la parola tuča, e non oblako, come fa Majakovskij, sebbene entrambi i termini siano traducibili con nuvola. Il critico Vroon ipotizza un omaggio paronomastico al poeta romantico Fedor Tjutčev, altra fonte d’ispirazione dell’opera insieme al simbolismo;2 tuttavia, se attribuiamo peso semantico alla scelta dovremmo figurarci la nuvola temporalesca, grigia, carica d’intemperie. Tuča è, infatti, la nuvola che porta pioggia ed evoca la natura cupa e burrascosa, l’evento repentino e scrosciante, segnalando la predilezione per i fenomeni soglia e per il dinamismo delle manifestazioni naturali, cifra stilista e contenutistica dell’universo poetico pasternakiano.
Nei versi giovanili c’è già tutto Pasternak. Nel saggio L’epos e la lirica della Russia contemporanea, a proposito della sua fisionomia poetica, l’amica Marina Cvetaeva scrisse:
delle piazze ancora ignare dell’alba,
il mio cantare ha il sigillo di piombo
d’ogni più ineluttabile rovescio. (p. 35)
La lirica Boschivo recita:
l’incognito dei calici decifro:
sono la voce ai loro bordi muti,
dal motto loro boschivo elargita.
[…]
io sono il verbo tuo che vagabonda. (p. 27)
Il poeta è colui che unisce le manifestazioni del quotidiano e dell’universo, i piccoli e i grandi eventi, in un unico respiro. Registra il caotico movimento urbano della strada, ma si eleva con uno sguardo verticale: nello Spazio lirico lo sguardo si sottrae alla linea dell’orizzonte per liberarsi da vincoli prospettici e accostare frammenti disparati del reale, rintanandosi in una mongolfiera alle prime luci dell’alba. La visione aerea diventa un modo per cogliere del mondo geometrie mobili, scorci cubisti e prospettive simultanee.
Le riflessioni sul destino del poeta e della poesia si sviluppano anche in altre liriche. In Oltre i brandelli del giardino rado Pasternak attribuisce un ruolo vivido alla tradizione d’Oriente nel demarcare la Russia, rispetto al «declinare caduco di Occidente». In Pannello notturno racconta le «notti di tana» della creazione artistica, immaginando una conversazione telefonica che si svolge in un’intima complicità, suggellando il connubio tra il tema della creazione e quello della fratellanza e della comunità di intenti. Il poeta naviga su miraggi biconcavi e riflessi di pozzanghere, evocando un’atmosfera sospesa tra l’intimità e il sogno. In explicit di poesia, uno dei tanti interrogativi che la giovinezza solleva:
i sogni vacilleranno alla rada,
in quali baie finirà il sobborgo,
e dove, se unico luogo è il verso? (p. 75)
Nella poesia conclusiva, Cuori e satelliti, è nell’immagine del telescopio che si concentra la capacità dell’arte di riunire gli opposti, di fondere elementi distanti.
Il tema dell’amore, presente nella prima parte della raccolta, è legato alla delusione, alla solitudine e alla mestizia degli addii. In Stazione, una «cassaforte ignifuga dei miei congedi», il fumo, la cenere e i maltempi amplificano il destino dei treni in fuga che suggellano la fine dell’infatuazione per Ida Vysockaja, figlia del mercante di tè moscovita David Vysockij. Patimenti amorosi prendono a volte la cadenza del languido simbolismo, mimeticamente riproposto nella versione italiana, «così aspra suona la parola melodiosa/su labbra che hanno baciato la tua seta» in La mia tristezza – incatenata Serba. Le ardenti passioni sfumano, infine, e si controbilanciano nella sintonia che unisce anime affini, come Castore e Polluce, i Gemelli della costellazione a cui dedica la poesia di raccordo tra il tema amoroso e quello amicale. A protezione l’uno dell’altro, come nel mito greco, alternano una condizione terrena e carnale a una siderale e onirica.
Infine, la raccolta italiana ha il merito di mostrare una doppia veste dell’opera: la prima e originaria versione, così come fu concepita nell’edizione del 1914, seguita da un’Appendice di testi rimaneggiati dall’autore stesso nel 1928 per una nuova edizione. Un’operazione giudicata dai critici in modo non univoco, migliorativa in alcuni casi, peggiorativa in altri, che Paola Ferretti sceglie di sottoporre al vaglio del lettore, accompagnata da una prefazione che offre importanti coordinate biografiche e estetiche per comprendere il contesto creativo e gettare luce sui meccanismi più interni alla lingua. Una scrittura definita come un «intrepido baloccarsi sulle montagne russe dei registri della lingua, dei più scoscesi tornanti sintattici, tra metonimie disarmanti e plurali inaspettati; perso nell’oscurità delle sue stesse visioni, racconta i nessi inesplicabili tra le cose polarizzando il mondo in coppie di opposti – sfuggenti cumuli di inattingibili alter-ego» (Invito a un debutto, p. 16). Nel volgere l’incandescente materiale linguistico in un’altra lingua Paola Ferrretti trova un compromesso tra la necessità di votarsi al senso e la tendenza a dissolvere l’elemento semantico nell’assoluto lirico, per restituire anche in italiano la convivenza di musica e metafisica, analisi e analogia, sogno e veglia. La traduttrice rispetta la ricchezza lessicale e le corrispondenze foniche, mima la maniera ellittica e l’oscurità ermetica dell’originale, senza lasciare che la densità magmatica si disperda.
1 O. Matič, K istorii oblaka: Vasilij Kandinskij, Andrej Belyj i dr., in «NLO», 6, 2011, n. 112.
2 Cfr. Paola Ferretti nelle note alla prefazione del volume.
3 M. Cvetaeva, Il poeta e il tempo, Milano, Adelphi, 2009, p. 135.
4 Nel saggio di M. Cvetaeva, Poeti con storia e poeti senza storia, in Ead., Il poeta e il tempo cit., pp. 151-198.