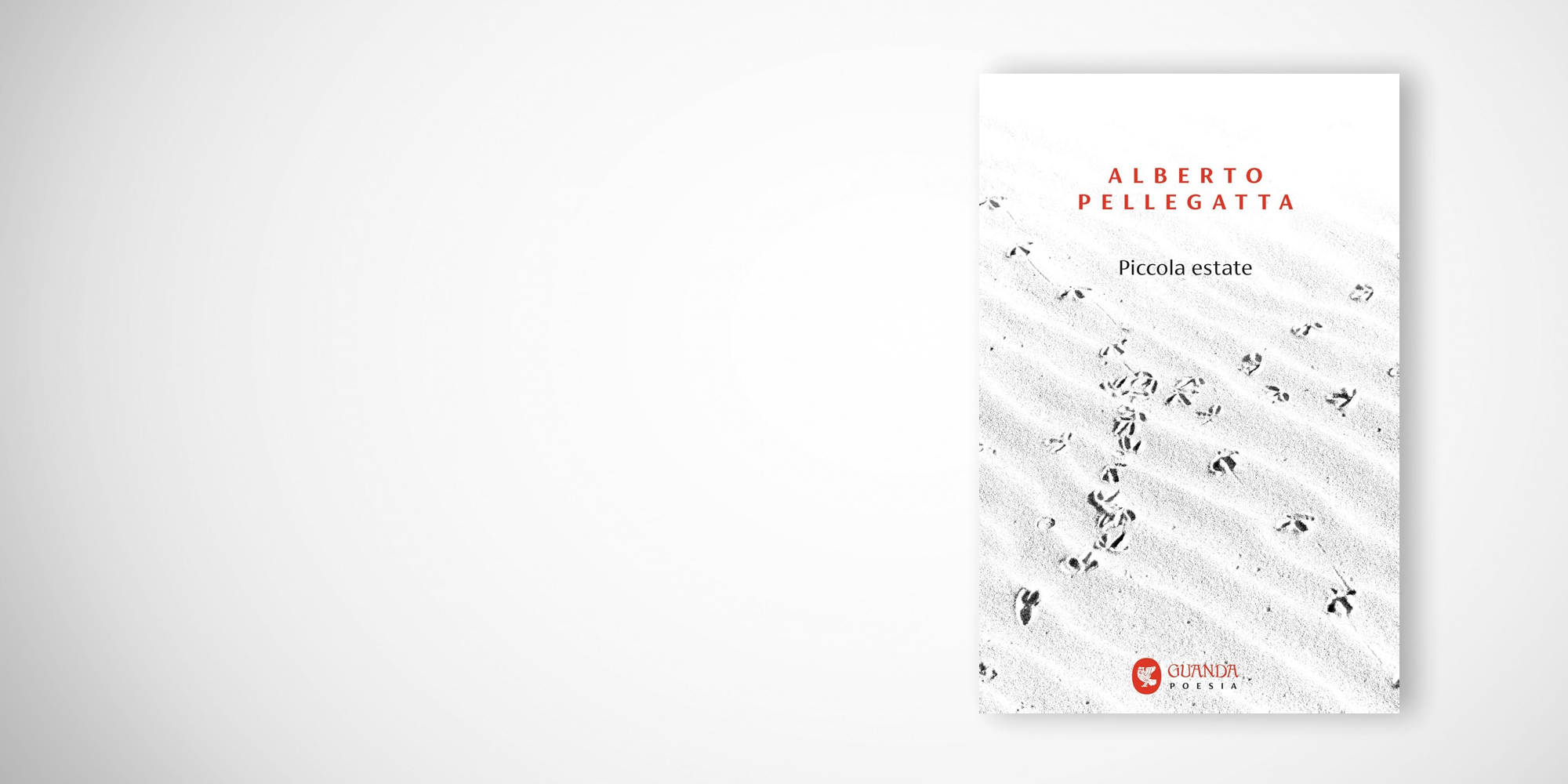Alberto Pellegatta,
Piccola estate, Milano, Guanda, 2025.
Torna dopo otto anni dalla sua ultima opera, il milanese Alberto Pellegatta e lo fa con un libro pubblicato da Ugo Guanda, nella collana di poesia coraggiosamente riaperta, dopo molti anni, dalla direttrice Federica Manzon e affidata alle cure del poeta Mario Santagostini.
Si intitola Piccola Estate, quest’ultimo lavoro, costituito da sei sezioni – Piccola estate, Improvvisi, Verbo notturno, Storie per dimagrire, La perdita della misura, La malattia della luce, per un totale di centododici pagine. E se è vero che il titolo di un’opera può, talora, custodire in sé una parte, seppur piccola, della poetica di un autore o, anche e più semplicemente, le scelte della propria vita, qui tale fatto sembra piuttosto chiaro – per lo meno, per chi conosce un poco Pellegatta e il suo percorso poetico – prima di tutto, perché il titolo è la traduzione del vocabolo veranillo che, in Spagna, paese dove il poeta risiede stabilmente da anni, indica quel periodo non meglio meteorologicamente connotabile che segue l’estate. A parte questa indicazione linguistico-geografica, l’aggettivo “piccola”, mentre sollecita subito un pensiero centrato sulla brevità delle vicende umane, evoca vagamente un senso di remota tenerezza, di perdita cui arrendersi, il sogno che si continua a fare di una giovinezza sospesa tra serenità e difficile apprendimento della vita, quando esperiamo problemi più grandi di noi; un momento indistinto, ricostruito da un io lirico che riesce a osservarlo con lucidità ma, allo stesso tempo, con il pensoso e talvolta doloroso abbandono cui solo i poeti sono capaci di lasciarsi andare; “estate” rinvia immediatamente alla forza solare, all’impeto della vita splendente ma anche, implicitamente e per contrasto, a quella spietatezza che madre natura possiede, appunto, rendendo gli esseri umani consapevoli (alcuni, in maniera accentuata) della provvisorietà ma anche delle vette speculative che, attraverso il patimento di essa, possono essere raggiunte.
Entrando in medias res e avendo quale obiettivo l’individuazione del messaggio che un autore intende inviare, mi pare, in questo caso, lo si possa focalizzare in due grandi aree tematiche protagoniste e comprimarie: una è la funzione che la consapevolezza, cioè la coscienza, ha di asseverare il reale come esistente, il che presuppone il problema ontologico quale centrale e di gran lunga superiore a quello strettamente cognitivo, di marca epistemica. In altre parole, la coscienza come unico ente che costruisce il reale, dandogli forma e rilevandone, allo stesso tempo, l’insensatezza, dovuta all’impossibilità costitutiva di trovarci una soluzione escatologica, eppure cercata ineludibilmente, nell’ordinaria quotidianità; l’altro, invece, è la parola, «Parola che sei nei cieli pericolante / moltiplichi i pesci strizzando gli occhi» (Canzone, cap. La malattia della luce, p. 107), il linguaggio, la lingua della poesia, quel sermo unius viri, eppure universale, primevo, la cui funzione è peraltro denunciata in vari passi di quest’opera, proprio in chiaro, come cruciale ai fini della significazione, seppure incompleta, degli accadimenti e della loro restituzione sulla pagina, nell’ipotesi che l’esperienza maturi in essi, infine, quel bene astratto, sfocato e soggettivo, definibile felicità, ovvero, etimologicamente, fecondità, tanto per suggerire un pallido richiamo al precedente lavoro, Ipotesi di felicità (Milano, Mondadori, 2017), incubatore importante di quest’ultimo, tanto sul piano dei contenuti, quanto su quello dello stile.
Che Pellegatta sia artista di pregio, intellettuale raffinato e, se vogliamo, anche un po’ elitario, lo denuncia già il modo in cui ha voluto impostare la struttura del libro, pensato come successione, non ordinata s’intende, eppure complessivamente assai organica, di fulminazioni epigrammatiche ad alto peso specifico, non di rado centrate su intelligenti cortocircuiti semantici, su sinestesie coraggiose; di poesie mediamente brevi, sobrie ed efficaci, e di prose brevi convincenti per il loro elegante nitore e per i guizzi creativi, di fantasia sbrigliata. Il tutto senza alcun manierismo, soprattutto senza sconti al lettore, né l’ombra della posa spocchiosa o del fastidioso compiacimento intellettualistico.
È opportuno dire a chi non lo sa o ricordare a chi già conosce qualcosa del suo percorso umano e artistico, che l’autore si occupa anche, da anni, di critica d’arte e, soprattutto, che si è laureato in filosofia con una tesi originale, ipersperimentale, su un poeta spagnolo del Novecento, poco noto, Jaime Gil de Biedma (1929 – 1990), tradotto, per la prima volta, proprio dall’autore stesso, contestualmente alla redazione della tesi. Ora, se i titoli accademici significano, di per sé, non molto, quando non pochissimo, non si può non intuirne, in questo caso, la flagrante e provvidenziale ricaduta sul percorso artistico del poeta; in special modo, sul tessuto connettivo di quest’opera e, in maniera più acerba, delle precedenti. Filosofia e poesia, dunque, due sconfinate aree del pensiero, che si potenziano a vicenda, intersecandosi, entrambe espressioni di un logos che Pellegatta può permettersi di frequentare e di usare con non comune disinvoltura e arditezza: il logos filosofico, da un lato, per significare, definire, determinare, mettere in piedi una fenomenologia del visibile e dell’invisibile, un diario sussultorio, anche amaramente paradossale, un po’ nevrotico agli occhi del lettore, con una sua cronologia smozzicata tra sconnessioni temporali e spaziali; dall’altro, il logos poetico, potente come il primo se non di più ma che non può mai esaurirsi nel solo significare e va ben oltre, lasciando spazi aperti, sempre oscuri e impervi, alle interpretazioni. E importa notare che, di entrambi, l’autore riesce a suggerirci l’inappartenenza a noi; anzi, che è il logos a possederci, a determinarci e, quindi, a essere il vero depositario delle storie e della Storia: a essere, in buona sostanza, lo scrigno misterioso della cosiddetta realtà.
Già ad apertura di pagina, si vede come questa verità prenda forma e lo faccia tramite una spiccata specificità stilistica, molto riconoscibile, da vero auctor, responsabile del proprio processo artistico e consapevole di quel che un’operazione creativa presuppone e comporta:
Per i problemi di cuore degli aceri
voglio solo che questo libro prenda sonno.
Sul retro di un volantino politico
il colibrì fa la voce grossa. (p. 7)
Chi è più abituato a un logos analitico che ha quale obiettivo e funzione costitutiva il nudo significare, mastica abbastanza male la presenza di vite vegetali o animali le cui problematiche e azioni sembrano quelle umane ma, se riesce a superare una certa inerzia e a gettare lo sguardo oltre, trova già in questo epigramma una prima, basilare connotazione di poetica, ovvero che l’io lirico va ad improntare la realtà, entrando in ogni ente, vegetale, animale o anche inerte (sempre che esista, nel cosmo, qualcosa di inerte, per come lo intende il vocabolo, astrattamente).
Ho sempre voluto essere pietra, uno scoglio, la roccia su cui si grattano i cervi, un sassolino che puoi metterti in tasca, la ghiaia da lasciare sulle tombe. Dove resta, minerale, la vita. (p. 36)
Pellegatta evidenzia la centralità del problema ontologico, suggerendoci che ogni cosa è esistente solo e soltanto tramite l’accertamento che la coscienza é destinata a farne. Anzi, è l’accertamento stesso, ovvero il suo modello ideale. L’io lirico qui si disloca, si frammenta e tale dislocazione praticata nella parola scritta non è priva di un certo rischio psichico, inimmaginabile e altresì inammissibile per l’uomo medio, come il poeta sembra evidenziare con la scelta dell’epigrafe che apre il terzo capitolo:
“se pensava a un estraneo o se lo immaginava vividamente, gli sembrava di diventare lui stesso quella persona, si smarriva tutto, e intanto una forza immensa lo spingeva a crearsi nella mente rapporti arbitrari”
1
E anche gli effetti, nonché i presupposti, della lingua parlata sono descritti, con un moderato e suggestivo
trobar clus, non meno impattanti, come in
Fonetica del sentimento (cap.
Piccola estate, p. 8), dove la pronuncia aperta di un’innocua vocale fa immaginare il retrostante invaso culturale, un certo gruppo di parlanti, «Se non chiudi la E si sente tutto / ma non si vede niente». E ancora, «Insegnami a cucinare le tue rape / […] che crescono tra noi da vent’anni come figli».
La lettura di poesia è un atto eversivo, diceva Enzensberger e, infatti, qui e in molte altre sue prove, Pellegatta ci offre, nel suo modo personalissimo, la possibilità d’esercitare con coraggio l’eversione necessaria affinché il senso del linguaggio poetico tenda, per nostro tramite, a chiarirsi, rimanendo entro il limite di un’irraggiungibile significazione completa, com’è naturale per la poesia. È ampio lo spettro interpretativo di quella “E” non chiusa, tanto ampio da indurmi a riflettere, per esempio, che un atto ritenuto scontato dai più, come il parlare, in realtà coinvolge complicatissimi meccanismi fonatori, affinati attraverso chissà quali percorsi evolutivi, in centinaia di migliaia d’anni e tali da poter conferire sfumate inflessioni differenti allo stesso fonema. Non solo: può suggerire anche il rovello invisibile delle storie umane («ma non si vede niente»), riassunto, qui, nel tempo ristretto dei comuni atti quotidiani, durante la cui implicita eternità due persone qualunque discutono di progetti di vita e a questa discussione assistono, mute protagoniste, le rape, cui tutto pare ridursi, per fatica, per pigrizia, per timore. Una condizione molto comune, questa, ça va sans dire.
Come ho accennato, alle singolari e piacevoli punture letterarie che i versi asciutti e rastremati al massimo distribuiscono, e ai versi delle poesie che respirano più ampiamente, si intercalano godibili affondi in prosa, sempre caratterizzati da una pregevole asciuttezza del dire, da una costante attenzione alla concretezza. Si tratta di un dettato mai indulgente in superflue fioriture linguistiche, in artifici di maniera, mantenendo un’efficace economia globale, sicché il risultato è un’elegante compattezza, il decoro raggiunto da chi padroneggia gli strumenti artigianali della scrittura e li usa per ottenere gli effetti voluti, con una perizia che affina la spinta creativa, potenziandone la carica. Potrei parlare di ingegneria dell’opera, rischiando – io già lo so – di porgere il fianco ad acuminati dubbi sulla spontaneità nella costruzione della stessa, considerando che, in molti, abita l’idea semplicistica e perniciosa che l’Arte sia un atto preminentemente spontaneo e la creatività un dono sul quale la Storia e la Critica hanno ben poco peso o, comunque, sarebbe meglio che non l’avessero. Chi, invece, è provvisto di curiosità e di passione autentica, d’acume e di cultura letteraria (perché la cultura è sempre determinante, nell’approccio all’Arte), trova in Pellegatta ampie espressioni di un tormentoso mondo intimo, commosso e commovente, nel quale la nostalgia, il dolore del ritorno di greca memoria, ha un peso non irrilevante. In non pochi versi di quest’opera, si respirano fole di questo sentimento, la cui esposizione è però come sobriamente contenuta, filtrata, neppure così facilmente immaginabile in chi può dare l’idea di avere nella scrittura una palestra dove esercitare, seppur con moderazione, più che altro le proprie sperimentazioni linguistiche e un’attività speculativa non comune, da maître à penser.
La commozione e la sofferenza appaiono abbastanza esplicite in Sartoria musicale (p. 22), una prosa di poche righe, che riporto integralmente.
Chiuso il negozio, l’uomo risale la strada, gira a destra e poi ancora a destra e sale due rampe di scale. Nel salotto di casa non ci sono divani o tavoli, solo manichini. Il sarto, ancora vestito con il panciotto, suona per il manichino prescelto, che aveva preparato al mattino con i vestiti di una delle sue migliori clienti. Si inginocchia, il povero vecchio, e canta la sua serenata.
Non sono, queste, righe che si sciolgono in una grande amarezza e riferiscono di un’anonimità esistenziale straziata, calpestata da un fato bieco? una modesta storia che nessuno vede ma il poeta ha introiettato nel suo intimo abisso, tentando di comunicarcela, come la soffrì, vivendola e, dopo, nel tormentoso atto dello scriverne?
Ma anche da altri sobri e impeccabili passaggi emerge l’attenzione al corso di esistenze prive di volto, travolte dai flutti indifferenti del tempo che salta a capriccio, le sballotta, le dimentica:
Età approssimativa 75 anni.
Per voi è estate, per lui inizia l’autunno scorso.
Troppo tardi per tornare alle vacanze annullate
ai ristoranti che avrebbe voluto provare, al mare. (p. 34)
C’è indubbiamente una cifra patetica molto caratteristica e, di certo, non minoritaria che, fra l’altro, si mostra in considerazioni dal taglio psicanalitico, come nel seguente inserimento paratestuale,
Come dall’innamoramento, attraverso stratificazioni, entusiasmi e tradimenti, si arriva al fastidio e si ritorna alla solitudine che si è cercato di allontanare con il piacere. Inizia così un’età di mezzo disillusa e emancipata. (p. 10)
Si tratta del laborioso processo esistenziale, durante il quale, a più riprese, si delineano e si riperdono i contorni dell’io: qualcosa che riguarda tutti. Il testo sopra riportato fa da didascalia alla successiva esposizione, da scrittore critico, di inveterate abitudini della buona borghesia e di certa umanità dalla vita inquadrata, piuttosto prevedibile:
Lontane impennate e diciottesimi in ville prese a nolo da cugini generali, politici locali, primari di provincia e, chissà perché, tanti avvocati che scrivono versi. (p. 10)
Citare in modo così nitido gli avvocati che scrivono versi, forse equivale a bollarli come scriventi illusi d’essere scrittori? Forse, e mi pare una piccola staffilata che denuncia la posizione dell’intellettuale nei confronti di certi titolati, magari pure un po’ tronfi, illusi di potere frequentare l’Arte e percorrerne i sassosi tragitti, con un modesto impegno e in maniera asettica, nello stesso modo in cui andiamo al bar o a fare una scampagnata domenicale. E a proposito del Pellegatta intellettuale, merita rilevare che non sopravanza lo scrittore che egli è, né il poeta, non oscurandone mai la carica emotiva, anzi, semmai potenziandola, anche quando palesa una cultura ampia, con incursioni in vari campi dello scibile, non facili da riportare nelle pagine di un prosimetro. È un merito non proprio da poco, questo equilibrio di per sé difficile, labile ed è possibile per il pudore, per l’elegante discrezione con cui l’autore esprime le sue speculazioni, a cominciare dalla buona scelta delle epigrafi, alcune davvero indicative della profonda attenzione alla sostanza della poesia e alle ragioni teoriche essa retrostanti, come quella che si trova a pagina 49, nella sezione
Improvvisi, ripresa dal critico e linguista britannico Ivor Armstrong Richards, secondo il quale la poesia è, di fatto, sempre poesia della Natura e niente altro.
2 Citare un passaggio dal significato così forte e altresì provocatorio, considerando che la poesia del Novecento e quella odierna si dimostra, in modi più o meno impliciti, essere anche, se non soprattutto, una ricognizione sulla natura di sé stessa, rappresenta una ragguardevole assunzione di responsabilità, una solida dichiarazione di poetica e chiarisce quale e quanta sia l’attenzione dell’autore a ciò che, per lui, rappresenta il vero e ultimo
Meaning of the Meaning – tanto per citare un altro titolo del Richards – «Gli animali vengono nelle mie poesie per il cambio climatico / torme di critici si appostano per estorcere loro una parafrasi» (p. 49). Versi condotti anche sul filo dell’ironia, un ingrediente di cui, per fortuna, la dispensa letteraria dell’autore non è mai mancante. Nel prosieguo di questo pezzo, si parla di un «colpo d’aria», di un «labiale», come invitati a partecipare della poesia. E saranno proprio questi invitati semplici, direi primordiali, qui elevati al piano delle idee, a fare giustizia di una massa turistica preda di una lingua impoverita tanto da preoccupare, a un passo da una sorta d’epidemica, orribile, afasia: proprio quella cui assistiamo, ogni giorno, nella nostra epoca tecnologica. Il tema della lingua e della sua filosofia, viene sviluppato a più riprese e per diverse vie, sovente con l’asciutta e originalissima brevitas del Pellegatta poeta-filosofo e filosofo-poeta, quando, per esempio, lascia intuire la sua pressante inquietudine di fondo in merito all’antichissimo problema della nominazione, «Qual è il mio nome / se mi hai sempre chiamato amore?» (p. 105) «Nomina sunt consequentia rerum» o vale, invece, il contrario? Chissà… Certo è che l’azione del logos arriva a fare diventare «i rami gomiti» e, quale verità a tutto l’esistente, ci siamo solo e sempre noi, con la fragilissima complessità della mente, il «cervello distribuito in grilli» (p. 107), senza il quale la realtà svanisce, non è più demarcata. Anzi, non é. Una corrispondenza biunivoca perfetta tra linguaggio e mondo è postulata nelle insenature che «[…] incontrano aggettivi rampicanti / fingono gialli imbronciati» (p. 100); è la nota tensione tra “oggetto” intimo e suo correlativo oggettivo, un legame stante alla base di tutta l’Arte: prova ne è che, a parlare di correlazione oggettiva, fu un pittore americano dell’Ottocento, Washington Allston.
Nel libro, oltre alle interessanti tematiche della filosofia del linguaggio, trovano posto alcuni quadri di cronaca familiare, i cui personaggi sono richiamati sulla pagina da una dolcezza arresa, con molta dignità, al dolore del distacco e la parola, come sempre essenziale, è analogica a un’emotività tutta da poeta ma temperata da conoscenze e speculazioni di ordine filosofico e ciò rappresenta una delle più lampanti cifre identitarie dell’autore. Vivere l’assenza di una persona cara, filtrando il relativo male psichico attraverso la scrittura; sopportare la morte «che è l’unica cosa sicura che non esiste» (Premesse Temerarie – cap. Improvvisi, p. 31), facendo propria quell’arte della perdita cantata dalla statunitense Elizabeth Bishop. Anche qui, è fornita l’occasione di riflettere su un dato cui non facciamo poi tanto caso, ovvero che la nostra massima certezza risiede in qualcosa di inesistente, visto che la morte non c’è, quando noi ci siamo.
Fra le figure ricordate, merita citare quella del compianto Giovanni Raboni, perché la sua parola poetica, sobriamente accorata, ha influenzato lo stile dell’autore che, in un pezzo in prosa del primo capitolo, accosta il ricordo del famoso poeta milanese a quello della madre, anche lei scomparsa, dando luogo a un momento di notevole tensione emotiva esposta con asciuttezza:
Ora che anche tu non ci sei più, quando passo da via Spadari, entro a bermi un caffè e vi vedo insieme, ti indica dove ho sbagliato nel mio ultimo libro e tu accampi per me qualche ragione. (p. 13)
Piccola estate si dimostra un lavoro equilibrato, organico, che evidenzia una maturazione marcata rispetto all’opera precedente, della quale l’autore ha ripreso qui i suoi tipici stilemi, rendendoli, per così dire, meno esasperati, meno spigolosi e artificiosi, ottenendo un netto miglioramento nella qualità della comunicazione. Come accennato sopra, un elemento importante è la fine ironia che possiamo trovare, talvolta abbastanza amara, spesso al limite della percettibilità o percepibile a una più attenta lettura, poiché dissimulata, argutamente, fra i numerosi apporti culturali, come l’epigrafe da persona colta, scelta per il capitolo
Storie per dimagrire, «terra tremat baratrumque metu sibi cagat adossum»
3 («trema la terra e, al sentirlo, se la fa addosso dalla paura», tratta da un’opera di Teofilo Folengo, il nostrano Rabelais) come se l’autore volesse o, anzi, necessitasse introdurre una specie di
divertissement pascaliano per digredire in modo leggero dal reale e, forse, assieme a tale digressione, addirittura una
epochè husserliana, per disporne in parentesi il giudizio d’esistenza, sospendendo l’impegno laborioso per contemperare l’attività speculativa propria dell’intellettuale e l’esuberante fantasia propria del poeta, così da ottenere, infine, quale temporaneo risultato, la riduzione del regime pressorio un po’ elevato che il ritmo dell’opera impone. Il lettore sappia che la frase latina sopra citata fa parte di un’opera con cui Folengo derideva gli imponenti e sussiegosi poemi epico-cavallereschi del tempo, rivolgendosi alle «pancificae Musae» che non hanno evidentemente nulla di soave, con le loro cicce belle debordanti. E le storie narrate per dimagrire, forse al contrario di quanto si potrebbe letteralmente credere, sono rappresentate da un’estesa metafora costituita da quindici pezzi (prose brevi e poesie di varia estensione) in cui il dimagrimento riguarda le illusioni, l’ingenuità, la dolcezza, la fiducia, più che il corpo. Ecco un’ironia dai tratti aciduli, per esempio, laddove, a causa della dissipazione, un dimagrimento c’è ma delle sostanze cui l’io lirico accenna, ereditate dopo la morte di antenati ricchi. Oppure, nel breve epigramma in cui il nome di un soggetto decentrato é un errore di pronuncia, sicché questi non può che continuare nel suo gramo destino di avulsione da sé stesso, di inguaribile sconnessione psichica che conduce alla povertà da emarginato, «[…] sposti i piedi non tuoi. Compri birra / e solo qualche volta pane» (p.75), a un dramma esistenziale tipico, con un retroscena inquietante, si direbbe quasi da fantasy-horror, in quei piedi che sono di un altro.
Delle non poche prose brevi – ascrivibili tanto al genere Fiction, quanto al Non-fiction – di alcune importa notare il gustoso contrasto tra testo puramente descrittivo, di taglio cronachistico, e le divertenti slogature della logica, che la fantasia, all’occorrenza molto sfrenata, del poeta introduce (ma anche, altrove, in taluni pezzi da intellettuale attratto dal genere Mistery). È il caso di Ricette esemplari/4, la cui epigrafe può sembrare semplice ma é, invece, dotta nella sua provocazione, «L’ordine degli ingredienti è più importante degli ingredienti stessi» (p. 79), che accenna a un tema inesauribile: la percezione di un oggetto come sistema dipende, più che altro, dalla posizione relativa degli elementi componenti, piuttosto che dalle loro precipue caratteristiche qualitative. Una considerazione che nasconde un universo speculativo, sul piano etico, su quello dell’apprendimento estetico e su quello epistemologico, poiché sposta il fuoco dei processi cognitivi e quindi valutativi sull’insieme, cioè sugli aspetti massivi, tendendo a trascurarne le singolarità. E in quanto alla fantasia sopra accennata, eccone un esempio indicativo,
Tipico dolce di carnevale, la prima volta che l’ho provato, avevo indosso un costume da Uomo Ragno. Avrei preferito un mantello più lungo, per volare meglio: mi esercitavo in giardino con l’asciugapiatti, volavo fino al lauro e ritornavo indietro […]. (p. 79)
L’immagine di un tipo adulto mascherato che sogna di infrangere la legge di gravità non può non divertire, però l’accostamento a quel che recita l’epigrafe accende pure una certa inquietudine e mi pare, questo, un altro risultato non trascurabile.
Ora, se tutto quanto è mondo e fa mondo risiede, sul piano della sopravvivenza, nella sua misurabilità, dunque nella quantificazione di qualcosa, l’ultimo capitolo, La perdita della misura, risulta cruciale, poiché accende riflessioni di natura etica sul modo in cui ci relazioniamo agli altri – che siamo, in definitiva, noi stessi – cioè sullo spostamento dal centro gravitazionale costituito dall’io verso quello di altri soggetti. Il noto «Je est un autre» del quale prendere faticosa coscienza, più o meno presto, nel giro di anni oppure, in modo dirompente, nel tempo di qualche ora, magari in un luogo preciso, da ricordare per tutta la vita:
ai giardini di Porta Venezia, in bicicletta, mi richiamava qualcosa di caoticamente plurale, qualcosa che più tardi avrei scoperto essere il passaggio dalla prima persona dell’infanzia al noi della rivolta. (p. 84)
Dunque, pluralità coniugata a rivolta e viceversa; le singole storie che assieme fanno coscienza collettiva, fanno popolo, coscienza popolare: un altro aspetto niente affatto trascurabile di Piccola estate, quello della scrittura civile che un intellettuale si converrebbe sentisse fra i propri piaceri e, anzi, fra i propri doveri. Dalla lucida speculazione e, assieme, dal sogno poietico, emerge la realtà così com’é, tanto dolce quanto puntuta, asperrima, che passa attraverso l’enumerazione di luoghi e situazioni divenuti punti di un’indelebile mappa interiore, la Villa Belgiojoso Bonaparte, l’architetto Giuseppe Piermarini, le bigiate di lombardo dialetto, il divisionista Segantini, un tale Moussafir, un poveraccio perseguitato dal destino, colpito fatalmente da un pezzo di lamiera e del quale la pietas dell’autore isola un penoso fotogramma dall’oscuro film della Storia e poi l’oncologo Veronesi, adoperatosi per salvarlo, in un climax trascinante: una catastasi senz’esito, senza successiva catastrofe. La Storia, quella dei tanti da essa tritati oppure quella dell’anarchico Santiago Salvador e del suo supplizio con la garrota; la Storia della terra creduta piatta ancora nel Novecento, della curiosità degli imperi andini e – altra buona trovata dell’autore – di un’Italia liberata niente di meno che dai… mapuche! una popolazione indigena del Cile e dell’Argentina. E poi? Poi, forse, ritornerà il regno degli animali, la loro meravigliosa innocenza cosmica, quando, appunto, «avranno precedenza gli animali» e saremo sospesi in un tempo, come quello che scorre e si comprime tutto, al punto che,
Partendo eri già a destinazione.
Nell’ultimo vagone, ancora in Centrale,
c’era un bar che era già Spagna. Poi cosa successo?
Ci siamo addormentati […]. (p. 92)
Resterà, infine, il mistero del logos, che accoglie nei suoi esiti gli struzzi, quelli che pure furono nelle memorabili righe di Senofonte. Resterà La Scuola di canto per canarini (p. 99); sopravviveranno le fantasie poetiche di un autore che ci è caro come poeta capace di immaginare insenature che «incontrano aggettivi rampicanti, fingono gialli imbronciati» (p. 100); ci è caro come intellettuale e, più semplicemente, come uomo che sa prendere le distanze dalla realtà, osservandola con singolare acume ma esserci immerso con passione incoercibile e, del pari, discreta, amandola ancora proprio alla maniera di un bambino, quello di un «cielo a pennarello / e i gomiti in una canzone».
Note
1 G. Büchner, Lenz, trad. it. di G. Dolfini, Milano, Adelphi, 1989.
2 I.A. Richards, Principles of Literary Criticism, London, Routledge, 1955.
3 T. Folengo, Baldus, a cura di M. Chiesa, Torino, UTET, 1997.