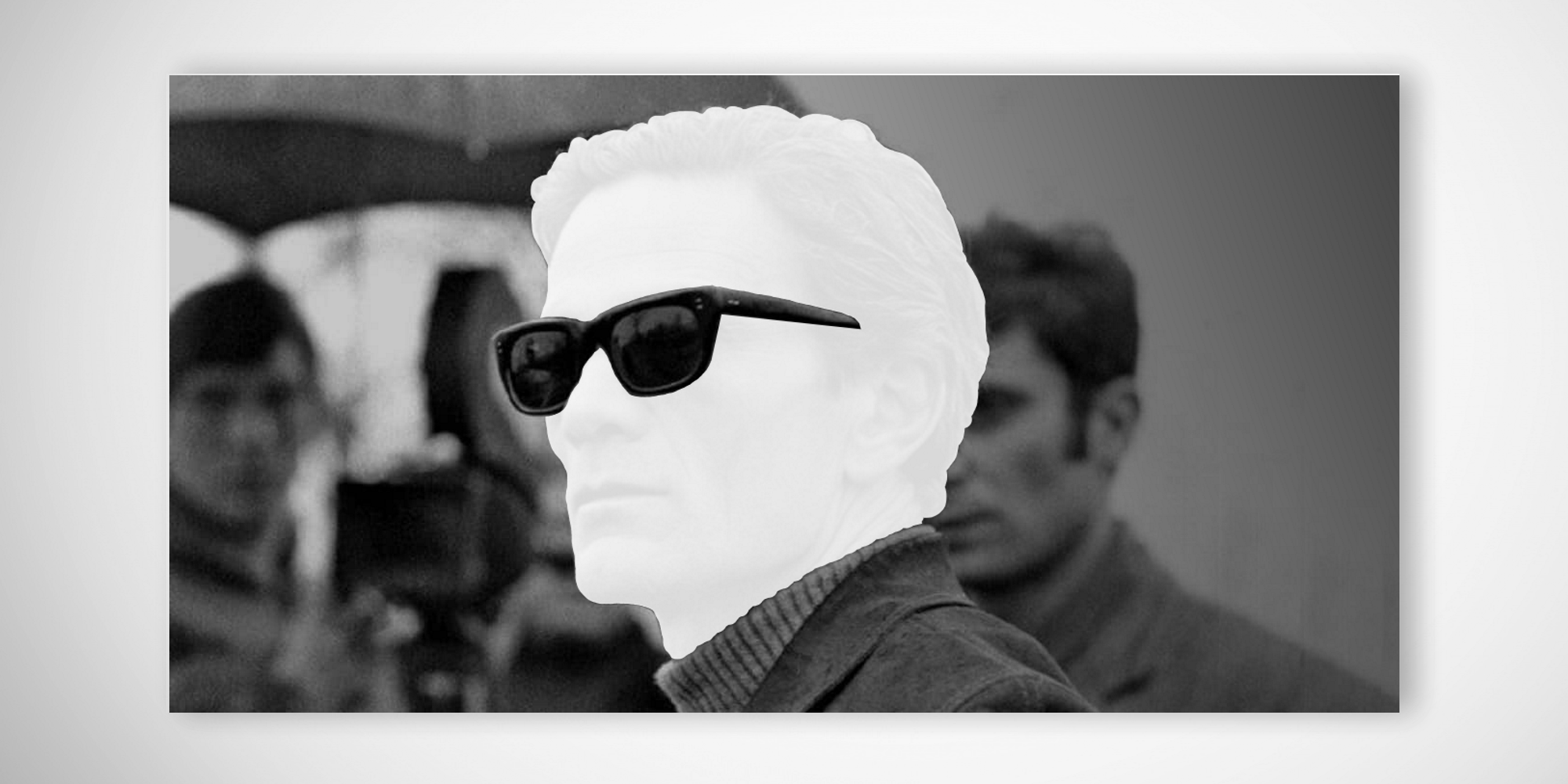
Chi è stato Pier Paolo Pasolini? La domanda potrebbe apparire poco appropriata se non addirittura provocatoria, dato che riguarda lo scrittore italiano fra i più citati e discussi. Eppure proprio i tanti libri e articoli, a cui vanno aggiunti documentari, fumetti, siti web, mostre, convegni e persino murales e canzoni, rischiano di eludere questa domanda. Anche i lavori migliori, non pochi a dire il vero, faticano a trovare spazio, sopraffatti dalla sovraesposizione di quello che è ormai diventato un mito postmoderno. Come da tempo osservato da molti specialisti, il nome di Pasolini non rimanda più all’opera o all’esperienza intellettuale di uno degli autori più significativi del Novecento, ma a un personaggio di finzione, a una figura opaca che ha smesso di essere sorgente di senso, spazio di interrogazione. La funzione del suo lascito è infatti al massimo quella di schermo, ovvero di catalizzatore delle identità altrui, di spazio di mascheramento di significati disparati e contraddittori che mescolano vecchie frustrazioni politiche e nuovi tabù intellettuali.
A questa forma di svuotamento hanno certamente concorso le approssimazioni di quegli interpreti che hanno trovato nella vicenda politica e intellettuale di Pasolini qualche pretesto per lanciare polemiche passeggere o finti scoop. Non stupisce nemmeno più come a questa pratica si siano prestati non solo giornalisti e accademici a corto di idee, ma anche alcuni volti noti dello spettacolo, della politica e persino della magistratura, non di rado sollecitati da operatori culturali improvvisati alle prese con iniziative che si vorrebbero divulgative, ma che salvo qualche eccezione propongono al pubblico solo la rimasticazione di discorsi usurati.
Se in passato il ricorso all’autore degli Scritti corsari e delle Lettere luterane evocava lo «scandalo della coscienza» e chiamava in causa responsabilità scomode, oggi si assiste a una sorta di ribaltamento. Da grande inquisitore della società dei consumi e della modernità neocapitalistica – per alcuni dunque un apocalittico – Pasolini si è trasformato in un autore integrato, anzi nell’autore che, a dispetto della sua opera, guida il processo di normalizzazione di ogni tensione drammatica tra arti e politica, tra ricerca espressiva e storia da fare.
Si direbbe una sorta di vendetta dell’industria culturale, capace di trasformare il poeta delle Ceneri di Gramsci in oggetto di intrattenimento deprivato dei suoi riferimenti politici. Il mito postmoderno non solo ne ha trasformato l’opera, e soprattutto la poesia, in un’appendice della sua figura mediatizzata, ma ha anche censurato i riferimenti più scomodi, come quelli al marxismo e appunto a Gramsci, tenuti in disparte senza mai trovare approfondimento o andare oltre la ricognizione biografica. L’intellettuale italiano eletto a esempio ideale dell’impegno civile non ha più pensiero. È «passione» senza «ideologia», «trasumanar» senza «organizzar». Prevalgono di lui le letture che ne fanno un personaggio pulsionale, fisico, governato da un’irrazionalità che ha trasformato la sua indagine sulla modernità in una sommatoria scomposta di parole d’ordine, la cui verità è solo un fatto estetico. La loro funzione politica non deve infatti mai superare il generico moto di indignazione morale per la protervia del «Palazzo» o per la pervasività «della società dei consumi» o ancora per la minaccia della «mutazione antropologica» e del «genocidio culturale». Non deve cioè oltrepassare la soglia della passeggera emotività individuale e restare entro i limiti rassicuranti di un impegno sempre più prossimo alla mera petizione di principio, ovvero all’impegno privo di effettualità storico-politica: l’esatto opposto di quello che Pasolini aveva cercato in Gramsci e nel marxismo.
A tale regressione, che ha consentito anche alla destra di inserirlo nel proprio pantheon, ha contribuito l’elevazione a mito gestuale, a personalità sganciata dal suo contesto storico, dai suoi grandi contrasti – tra passione e ideologia –, e soprattutto dai rapporti, talora polemici, con gli intellettuali e le formazioni politiche del suo tempo. Della sua vicenda vengono spesso messi in forte evidenza gli episodi di scontro o le polemiche attraverso però un’ottica antipolitica, che non sa vedere nulla al di fuori dell’eroe finzionale con cui schierarsi a favore o contro. Da metodo conoscitivo, mezzo per interrogare il proprio tempo e sottoporre a verifica le proprie posizioni, il conflitto intellettuale è divenuto l’ingrediente di uno storytelling che ha trasformato Pasolini in una solitaria vittima sacrificale, nell’attore passivo di una generica catarsi consolatoria e spoliticizzata.
Di fronte alla domanda su chi è oggi Pasolini si deve allora constatare come l’uso della sua figura abbia del tutto abbandonato quello spirito comunitario di ascendenza gramsciana (la «connessione sentimentale») presente nella sua attività, nella sua ricerca nel cuore dei subalterni – i contadini friulani, i borgatari romani, il Mezzogiorno e le realtà dell’Africa e del medio oriente – di una percezione del mondo inedita, estranea alle forze egemoni, capace di sopravvivere nei dialetti, nelle tradizioni e nei corpi, e di dare materia alla scrittura poetica e all’indagine politica.
La trasfigurazione postmoderna di Pasolini è invece l’espressione smorta dell’oggetto di consumo, del prodotto piegato ai principi neoliberali che hanno sottomesso tanto il lavoro letterario quanto quello politico alla logica dell’autopoiesi tipica di molta produzione culturale odierna. Piegata alla funzione di schermo, la sua opera non è più il luogo di interrogazione e scoperta, ma è lo spazio della contemplazione narcisistica che ripudia il conflitto e che rinuncia a ogni tentativo di trasformazione dei rapporti materiali e simbolici. Il Pasolini spoliticizzato, sottratto alla storia e consegnato al presente, è in altre parole l’icona conciliata che disperde lo «scandalo della contraddizione». È il mito consolatorio che riduce l’esperienza del mondo a estensione dell’io integrato alle forme più avanzate dello sfruttamento capitalistico odierno. Anziché riaprire la dialettica tra arte e vita, tra individuo e storia la falsificazione del lascito pasoliniano ne è dunque la dissoluzione.
Franco Fortini, con il quale non sono certo mancati fraintendimenti e incomprensioni, ma che per primo aveva visto il pericolo cui stava andando incontro la figura dell’amico poeta, proprio sulle colonne di questo giornale, all’indomani della morte, affermava che «il solo modo decente di parlare di Pasolini è leggerlo». Con queste parole denunciava non solo l’intramontabile pratica di parlare di ciò che non si conosce, a cui anche oggi si prestano i tanti pasolinisti d’occasione, ma anche l’attitudine a ridurre la sua opera alla proiezione delle aspettative del proprio tempo. La neutralizzazione del suo scandalo si direbbe in effetti nascere dall’incapacità di accettarne il dato estraneo, diverso e inconciliato. Qualcosa di tutto questo lo si ritrova nel problematico attaccamento al campo comunista, nell’ossessiva esplorazione del passato e delle tradizioni, e ancora nelle particolari forme della sua omosessualità, nelle scelte del suo sperimentalismo stilistico e nel continuo tentativo di rinnovare la sua connessione sentimentale con i soggetti sociali ai margini della storia. Si potrebbero fare numerosi altri riferimenti. Ciò che comunque accomuna questi primi esempi, così diversi ed eterogenei, è il carattere contrastivo che esprimono con il presente, è la loro inattualità o, sempre nei termini di Fortini, è la brechtiana manifestazione dei «torti» di Pasolini.
«Aveva torto e non avevo ragione» ha scritto Fortini nell’incipit di Attraverso Pasolini. Il suo intento non era però quello di arrendersi all’ordine del presente ma al contrario quello di sottrarvisi insieme al suo antico compagno di poesia e di battaglie politiche. Contro la sua normalizzazione, l’unico «modo decente» è allora quello di leggere Pasolini per riportarlo nel campo della «non ragione» o appunto del «torto», che è poi il terreno dello «scandalo della coscienza», della ricerca della discontinuità che genera lotta reale e che rifiuta ogni pacificazione consolatoria. È la lettura che riaccende la scintilla della poesia, il dissidio politico, il rifiuto del presente e delle sue falsificazioni: lettura che, dopo la catastrofe delle sinistre e l’euforia postideologica, rigetta l’attuale ordine di verità e accetta di stare dalla parte del torto nel tentativo di riaprire la contraddizione e riattivare il conflitto.