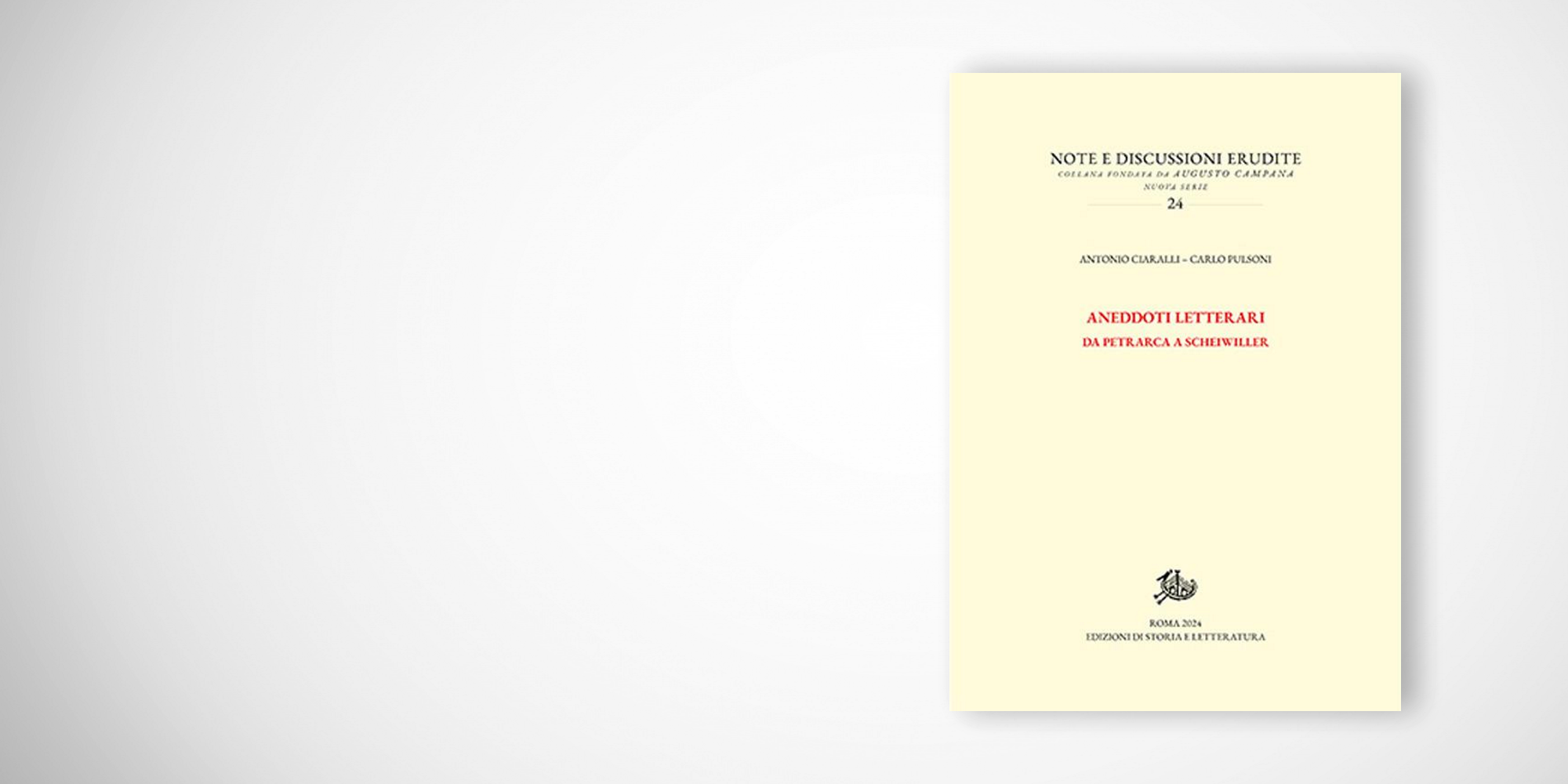
Per chi ha seguito un indirizzo di filologia e critica del testo, insegnato da Lanfranco Caretti, proseguendo la scuola di Giorgio Pasquali e coniugando rigore e qualità interpretativa, è occasione di grande interesse il volume di studi Aneddoti letterari da Petrarca a Scheiwiller di Antonio Ciaralli e Carlo Pulsoni, che, ricalcando nel titolo quello di Aneddoti di varia letteratura di Benedetto Croce, hanno indagato, da paleografo l’uno e da filologo l’altro, su prime edizioni e autografi inediti, l’elaborazione testuale tra edizione e trasmissione. Il percorso è assai affascinante se applicato a un codice petrarchesco o a una lirica di Ungaretti, all’Infinito di Leopardi o ad alcuni Ossi di seppia di Montale o, infine, all’opera di un editore come Scheiwiller in dialogo con Pasolini su Pound o Biagio Marin. Gli autori affermano di essersi fermati alla soglia dell’interpretazione. In verità altro ci giunge dal loro studio e non di poco conto: con una proposta metodologica, il riflesso di un’epoca e di una cultura, indagate e rappresentate vivamente.
Si veda il capitolo Onore ai vinti che ricostruisce la vicenda del ms. Vat. lat. 3195, un manoscritto celeberrimo dei Rerum Vulgarium Fragmenta di Petrarca, posseduto da Pietro Bembo e utilizzato per l’edizione di Manuzio del 1501. Il ritrovamento, secondo l’annuncio dato da Pierre de Nolhac nel 1886, s’incrociò con la perlustrazione nella Biblioteca Vaticana di un giovane Arthur Pakscher alla ricerca del manoscritto, sul quale stava interessandosi, per scoprirne l’autenticità, anche Ernest Langlois, dell’Ecole Françese de Rome, che intervenne nella questione (sua l’individuazione di due mani nella stesura del manoscritto, la seconda certamente di Petrarca), cercando di allontanare, screditandolo, lo studioso tedesco e sostenendo il connazionale. Molto ben raccontata attraverso lettere e recensioni d’epoca, si snoda una vicenda di attribuzioni e stroncature, di spiate e annunci, repliche e controrepliche, interventi di eruditi e poeti come Carducci fino a una soluzione concordata, che riconoscerà a Nolhac la priorità della riscoperta del Vat. Lat. 3195.
Ma altri manoscritti incontrano l’acuto studio degli autori, che s’inoltrano nella critica variantistica e genetica, esaminando il foglio contenente gli Abbozzi dell’Infinito meritevoli di una “perizia grafica”. Reso noto nel 1898 da Cozza Luzi, il foglio assai famoso e a lungo discusso, presenta una redazione in versi su una facciata e una formulazione in prosa sul verso. Riapparso all’interesse dei collezionisti grazie a un articolo di De Robertis nel 1951 (Ritrovati gli abbozzi autografi dell’«Infinito»), fu considerato frutto di falsificazione da Sebastiano Timpanaro, restituito a Leopardi da Pasquale Stoppelli nel 2021 e ora, attraverso un’analisi accurata e stringente sul tema dell’autografia leopardiana, restituito alla sua natura non autentica.
Non solo i manoscritti riservano sorprese e invitano a indagini sottili, anche le biblioteche e le edizioni originali, donate da scrittori ad amici, possono indurre a interessanti riletture di testi famosi. Ecco, nel libro di cui parliamo, il capitolo che indaga, dalla biblioteca ora alla Fondazione Primoli di Roma, l’edizione princeps di Ossi di seppia dedicata cordialmente nel 1927 a Mario Praz da Montale, testimonianza di un’amicizia molto viva e qui molto ben tratteggiata. Il dono degli Ossi ben manifesta la gratitudine di Montale per aver Praz tradotto in inglese Arsenio, ammirato da Eliot e da questi pubblicato nella rivista «Criterion»; conserva alcune correzioni montaliane e interventi di Praz, ora rimandi intertestuali a Keats o a D’Annunzio, ora sottolineature di lemmi letterari.
Partendo da questi rilievi l’indagine, che si avvale di molti confronti, recensioni e lettere, come quelle appartenenti al carteggio di Montale con Carlo Linati, si illustra il movimento dinamico impresso alla vicenda editoriale e autoriale, con un rilievo particolare e sorprendente dato a cinque parodie «in un inglese maccheronico parodiato da quello dei versi di Pound e di Eliot», composte da Praz forse in complicità con il poeta ligure. Infine, a dimostrazione di intrecci di vita e di cultura all’ombra della letteratura, ecco apparire, sempre dalla biblioteca di Praz conservata in Poesie a Casarsa, una lettera ossequiosa del poeta friulano, che ringrazia di «gentili parole», certamente quelle di una lettera ricevuta. Praz mostrerà in seguito molta attenzione a Teorema, letto evidentemente con molta acribia. Ma Pasolini ritorna all’osservazione di Pulsoni nell’ultimo capitolo Nel mondo di Vanni Scheiwiller, l’editore benemerito nella storia drammatica di Pound. Fu lui infatti ad accettare la proposta di Solmi e Valeri di promuovere una petizione italiana per liberare il poeta dal manicomio criminale sulla rivista «Stagione» nel settembre 1955, petizione cui aderirono poeti, ma non Pasolini restio a modificare il suo giudizio negativo sullo scrittore. Ma fu certamente Vanni a tessere un rapporto stretto e costruttivo con quest’ultimo al fine di fargli apprezzare Ezra Pound, la cui opera andava via via pubblicando. Altrettanto interessante la ricostruzione della vicenda editoriale di Biagio Marin, a partire dall’antologia Solitàe edita nel 1961 da Scheiwiller a cura di Pier Paolo Pasolini. Fu infatti questi, molto interessato, come sappiamo, alla poesia dialettale, a promuovere l’opera del poeta di Grado, intervenendo con la prefazione nella successiva opera La vita xe fiama del 1961 curata da Claudio Magris e insistendo, sia a livello critico sia con lettere, a far riconoscere il poeta in ambito nazionale, cosa che riuscì grazie all’Insegna del pesce d’oro.
Se infine, si torna con gli studiosi a seguire il percorso editoriale di una poesia del Dolore di Ungaretti nel capitolo 4 «GRIDASTI: SOFFOCO… Genesi ungarettiane, con esercizi di trascrizione», si coglie un intimo dramma, che diviene poetico, legato all’evento tragico della morte del figlio bambino. La poesia «alla quale tengo di più» (a Van Nuffel), fu rivista molte volte dal poeta, come indicano sia la tradizione a stampa sia quella pre-stampa sia l’indagine su una serie di carte appartenenti ora all’Archivio Alessandro Bonsanti e alla Biblioteca nazionale di Roma. La genesi creativa alterna due momenti, uno ascrivibile al tragico evento, l’altro alla messa a punto per la pubblicazione, con interventi perfettivi ed esercizi di trascrizione, sì che, nel caso in esame, si osservano le fasi di «una poesia che dell’immediatezza scaturita del tremendo evento conserva solo qualche traccia», inverando una linea evolutiva a livello espressivo, restituendo, con Contini, il testo «alla sua condizione di caleidoscopica variabilità» e offrendo una lezione importante sullo studio critico del patrimonio letterario contemporaneo.