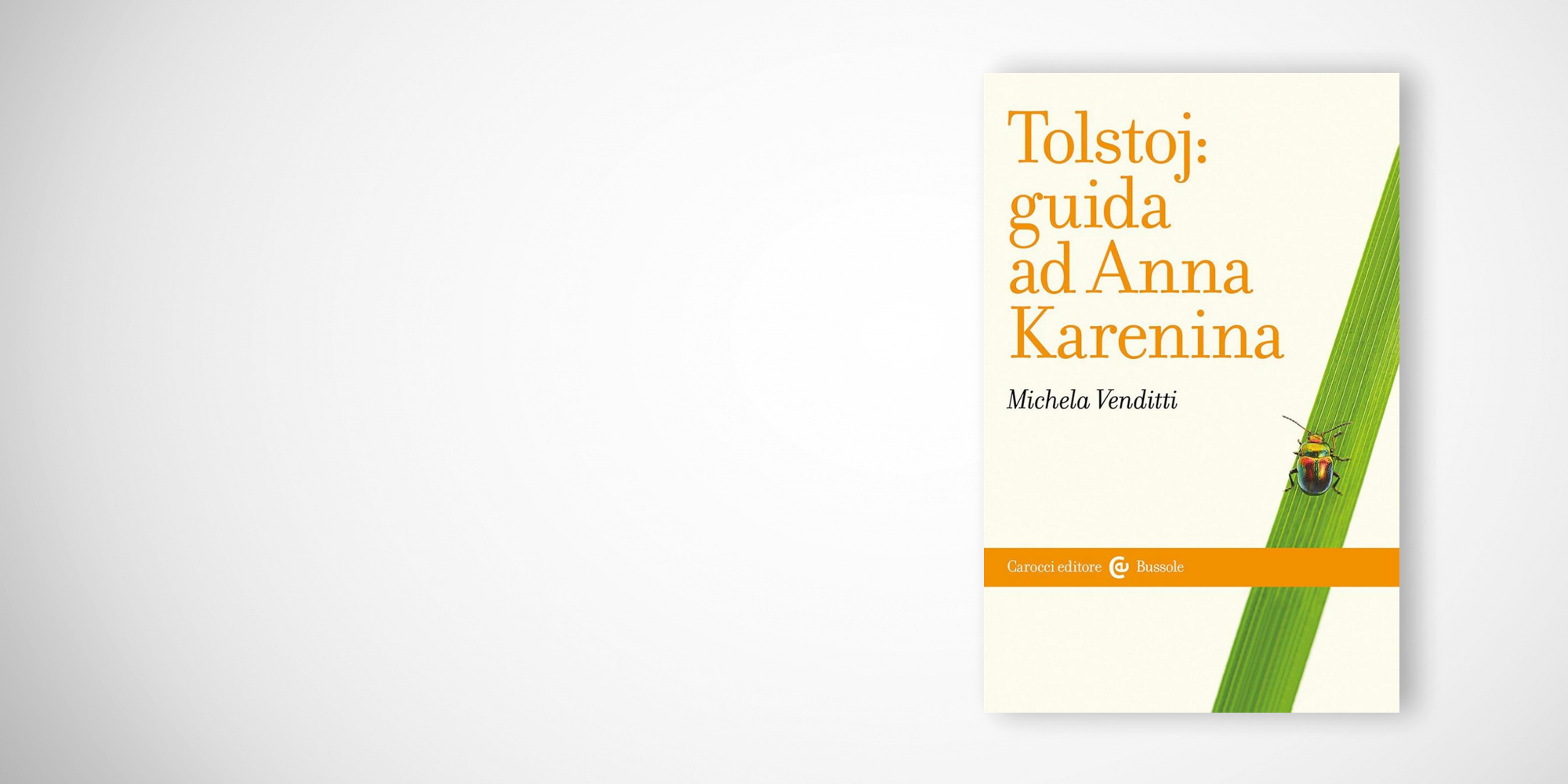
Perdersi nelle pagine di Anna Karenina non sarà più tanto facile per il lettore italiano, ora che dispone di uno strumento essenziale per rituffarsi in quel capolavoro: nelle cento pagine della «Bussola» Michela Venditti ce lo ricapitola tutto, dal contesto storico-biografico che lo sottende fino ai singoli gesti dei personaggi. Si avvale di letture critiche imprescindibili, trascelte con cura nel profluvio di pronunciamenti accumulatisi nel secolo e mezzo intercorso dalla pubblicazione del romanzo, e si addentra sicura dentro «quell’infinito labirinto di concatenazioni in cui consiste l’essenza dell’arte» (è Tolstoj stesso a scriverlo, p. 47). Ci mostra così come Anna Karenina porti a compimento, superandola, la linea narrativa del matrimonio infelice lasciata aperta da Puškin col finale del suo Evgenij Onegin e timidamente affrontata già nei decenni centrali dell’Ottocento dalle rare penne femminili russe avventuratesi nell’agone letterario.
Dando voce a Šklovskij e Gifford, Ejchenbaum e Lotman (o al Tolstoj delle lettere e dei diari), Venditti raduna e intreccia ogni possibile annotazione rilevante – non tutti sanno ad esempio che la scaturigine del romanzo risale a una illuminazione dovuta alla lettura del frammento puškiniano Gli ospiti si radunarono alla dacia – e riporta in scena la straordinaria figura dello scrittore russo, compendiata nel coacervo di contraddizioni di cui è intessuta: «Ateismo e fede assoluta, lussuria e astinenza, desiderio di fare qualcosa di essenziale nella vita e desiderio di porvi fine, scarsa stima per le donne e valore della famiglia, contadino e possidente, cacciatore e vegetariano» (p. 13).
Avvince il racconto di come i fatti biografici «si insinuano nella trama di Anna Karenina» (p. 20), della frenesia con cui il narratore si rapporta alla sua creatura: «durante i circa quattro anni della turbolenta creazione Lev vede il mondo circostante in funzione di Anna» (p. 22). Agile, fantasiosa e acuta, tanto nel ripercorrere le tappe ineludibili dell’esistenza e dell’opera complessiva dello scrittore, quanto nello sbozzare i lineamenti della “questione femminile” al tempo di Tolstoj, è nell’analisi del romanzo che questa Guida dà il suo meglio.
Venditti disarticola la macchina narrativa e ce ne restituisce i gangli cruciali, facendo riaffiorare il disegno di cui lo stesso artefice andava fiero: «gli archi sono costruiti in modo tale che è impossibile notare dove sia la chiave di volta» (p. 48). Non solo le otto parti in cui il romanzo è diviso, con i rispettivi perni narrativi (la confusione, l’abisso, l’incertezza, i desideri, lo iato tra ideale e realtà, il senso della famiglia, la crisi spirituale, gli echi della morte di Anna), ma anche il viluppo dei temi, dipanato nel suo altalenante intarsio: nascita e morte, tra loro strettamente associati, e la necessità di tendere a una vita intensa e consapevole; il matrimonio in tutte le sue varianti; la pedagogia e la gestione rurale; la vacuità dei salotti pietroburghesi e le insidie del progresso (incarnate dal “simbolo nefasto” del treno); per contro, la patriarcale, lenta vita moscovita; l’artificiosa e aristocratica campagna della tenuta di Vronskij e l’idilliaco possedimento di Levin.
Ne esce nuovamente galvanizzata tutta «l’energia del materiale narrativo» (p. 54), con lo smagliante rilievo assunto nell’intelaiatura del romanzo dalla dominante “sincerità vs menzogna”, e la rete dei procedimenti stilistici messi in campo. L’autrice individua l’immagine del cerchio come posizione tanto filosofica quanto narrativa capace di dar conto dell’andamento del romanzo, o la reciprocità di ruoli di incipit ed epigrafe, mentre il “falso finale” inscena la morte dell’eroina sui binari per poi proseguire la narrazione ancora un intero capitolo, indugiando sugli sviluppi ad essa successivi.
Lumeggia infine il sistema dei personaggi (coi loro prototipi reali e quelli di finzione), la fitta compagine di sembianze letterarie – tutte impastate in quantità variabili di bene e male – in cui il narratore onnisciente riversa se stesso:
Tutt’altro che una diligente silloge dei saggi più illuminanti, o un evocativo montaggio di citazioni – con l’atmosfera ottocentesca che riaffiora dagli stralci di lettere o testimonianze d’epoca – la Guida di Michela Venditti si configura come un contributo critico importante, che fa progredire la nostra interpretazione di questo classico, con le aperture sui filosofi studiati da Tolstoj (Pascal, Schopenauer o Kant, per citarne solo alcuni), ma anche su quelli che da Tolstoj furono influenzati (Berdjaev su tutti), e fa riemergere rimandi al XVIII secolo poco battuti, scovati nella convinzione che «la concezione del mondo di Tolstoj salta una generazione ed è più legata al pensiero del Settecento, con il suo moralismo e razionalismo, che a quello del suo secolo» (p. 49).
A sottendere l’intero lavoro, la convinzione che Tolstoj abbia brandito il suo romanzo animato da un elevato grado di consapevolezza riguardo al formidabile impatto che esso avrebbe avuto sui mutamenti culturali in tema di unioni matrimoniali (e non solo), in Russia.